cult

CULT
The Best of 2019. Le serie TV
In un panorama seriale sempre più frammentato, iper-produttivo e affollato, l’anno appena concluso è stato senz’altro quello di Phoebe Waller-Bridge con le sue Fleabag e Killing Eve: ma anche di Chernobyl, della seconda stagione di Mindhunter e della conclusione di The Deuce di David Simon. Ecco (in rigoroso ordine alfabetico) le serie TV che abbiamo amato di più nel 2019
BROAD CITY
di Ilana Glazer e Abbi Jacobson (Comedy Central)
 Broad City si innesta in un filone cinematografico e televisivo che raramente ha deluso, a partire da Girlfriends (1978) fino a Frances Ha (2012) e Girls (2012-2017): ovvero quello capace di utilizzare la topografia, l’architettura e gli interni newyorkesi (a volte vissute come labirinti asfissianti, altre come un far west liberatorio) per dare spazio a tutte le ambiguità di legami che non stanno né dentro la categoria di amicizia, né dentro quella di relazione sentimentale. Ma al di là dell’evanescenza dei confini tra tipologie, non c’è dubbio che si tratti di amore, fatto di sentimenti eccessivi e a volte egoisti, ma soprattutto di storie che valgono la pena di essere vissute. Nel finale dell’ultima stagione Abbi e Ilana passeggiano con un water in braccio sull’iconico ponte di Brooklyn mentre affrontano quello che sembra l’inesorabile destino della stragrande maggioranza delle relazioni personali: il rapporto a distanza. Dopo reazioni disperate e tentativi dell’ultimo minuto Ilana accetta la partenza di Abbi per il Colorado, ma non l’illusione che il loro rapporto rimarrà inalterato. E passa al contrattacco: «this is going to change. But this is still going to be the most beautiful, deep, real, cool and hot, meaningful, important relationship of my life!». L’unica cosa che le due protagoniste non mettono in discussione è il desiderio di vivere il legame con l’altra, qualsiasi forma esso prenda. Poco importa se il risultato sarà fallimentare, perché il coraggio di sobbarcarsi il proprio desiderio senza fare calcoli è un atto di ribellione alla norma mortifera del pragmatismo. (Jacopo Favi)
Broad City si innesta in un filone cinematografico e televisivo che raramente ha deluso, a partire da Girlfriends (1978) fino a Frances Ha (2012) e Girls (2012-2017): ovvero quello capace di utilizzare la topografia, l’architettura e gli interni newyorkesi (a volte vissute come labirinti asfissianti, altre come un far west liberatorio) per dare spazio a tutte le ambiguità di legami che non stanno né dentro la categoria di amicizia, né dentro quella di relazione sentimentale. Ma al di là dell’evanescenza dei confini tra tipologie, non c’è dubbio che si tratti di amore, fatto di sentimenti eccessivi e a volte egoisti, ma soprattutto di storie che valgono la pena di essere vissute. Nel finale dell’ultima stagione Abbi e Ilana passeggiano con un water in braccio sull’iconico ponte di Brooklyn mentre affrontano quello che sembra l’inesorabile destino della stragrande maggioranza delle relazioni personali: il rapporto a distanza. Dopo reazioni disperate e tentativi dell’ultimo minuto Ilana accetta la partenza di Abbi per il Colorado, ma non l’illusione che il loro rapporto rimarrà inalterato. E passa al contrattacco: «this is going to change. But this is still going to be the most beautiful, deep, real, cool and hot, meaningful, important relationship of my life!». L’unica cosa che le due protagoniste non mettono in discussione è il desiderio di vivere il legame con l’altra, qualsiasi forma esso prenda. Poco importa se il risultato sarà fallimentare, perché il coraggio di sobbarcarsi il proprio desiderio senza fare calcoli è un atto di ribellione alla norma mortifera del pragmatismo. (Jacopo Favi)
CHERNOBYL
di Craig Mazin (HBO)
 La serie prodotta da HBO e centrata sulla catena di eventi che nel 1986 fece seguito all’esplosione del reattore 4 nella centrale nucleare ucraina, è diventata in pochissimo tempo uno degli eventi televisivi più acclamati dalla critica e dal pubblico. Con una realizzazione tecnicamente ineccepibile, un ritmo incalzante e ansiogeno, la serie scritta da Craig Mazin riporta alla memoria un trauma pressoché rimosso dalla coscienza collettiva: più di trent’anni fa, l’idea che l’origine del disastro fosse da ricercare nel regime sovietico – con la sua negligenza e le sue tecnologie obsolete – consentì ai contemporanei di domare nel tempo le paure che si erano immediatamente scatenate a livello mondiale. La miniserie riesce invece nella difficile impresa di riattivare il trauma, riportando l’”evento Cernobyl” a quello che effettivamente fu, un presagio e una profezia.
La serie prodotta da HBO e centrata sulla catena di eventi che nel 1986 fece seguito all’esplosione del reattore 4 nella centrale nucleare ucraina, è diventata in pochissimo tempo uno degli eventi televisivi più acclamati dalla critica e dal pubblico. Con una realizzazione tecnicamente ineccepibile, un ritmo incalzante e ansiogeno, la serie scritta da Craig Mazin riporta alla memoria un trauma pressoché rimosso dalla coscienza collettiva: più di trent’anni fa, l’idea che l’origine del disastro fosse da ricercare nel regime sovietico – con la sua negligenza e le sue tecnologie obsolete – consentì ai contemporanei di domare nel tempo le paure che si erano immediatamente scatenate a livello mondiale. La miniserie riesce invece nella difficile impresa di riattivare il trauma, riportando l’”evento Cernobyl” a quello che effettivamente fu, un presagio e una profezia.
[…] Se c’è un’indicazione politica che nella serie sembra più di altre proiettarsi ai nostri tempi, è che la “lotta per la verità” costituisce ancora oggi il campo di battaglia principale per combattere il nuovo autoritarismo, il quale – al pari del vecchio – continua a giustificarsi con l’uso sistematico della forza e della menzogna. […] Ma è proprio in questa proiezione – nel rinnovato valore politico della scienza come antagonista del potere – che qualcosa non torna. Perché se Cernobyl mostra il formarsi della crepa nel controllo della verità da parte dell’autorità burocratica, al contempo è anche l’inizio di un nuovo tempo che vede la stessa scienza perdere il monopolio della produzione sociale della verità: il campo lasciato vuoto dal regime arbitrario del potere non sarà mai più riempito dalla ricostituzione di un’autorità legata alla verità scientifica. Negli anni che ci separano da Cernobyl, la verità si è frammentata in miriadi di specializzazioni ed è stata rifeudalizzata dalle pseudo-autorità degli “esperti”.
Benché ancora intriso di menzogne, il nuovo autoritarismo non si appoggia più ad alcun nuovo monopolio della verità, quanto piuttosto sul suo rovescio: l’assenza di un suo fondamento riconosciuto. I protagonisti della nuova svolta reazionaria globale piantano il loro potere sulla moltiplicazione di micro-sfere identitarie che non rispondono più ad alcuna logica contro-fattuale, quanto a verità che si confermano nella più assoluta e incontestabile auto-referenzialità. (Alberto De Nicola) Leggi qui la recensione di DinamoPress
THE DEUCE
di George Pelecanos e David Simon (HBO)
 La Deuce è una strada di New York che al centro della vita della città è affollata da chi vive i margini. Nel corso delle stagioni i meccanismi della vita cittadina mutano e le mode si impongono prorompenti nei loro colori: trasformazioni che sembrano mantenere e consolidare i rapporti di forza prestabiliti dalla società patriarcale. I tentativi di emancipazione degenerano in continui fallimenti ma nel susseguirsi delle puntate permane una forma di resistenza politica. Ed è proprio il tema della resistenza a incendiare questa serie tv: i personaggi resistono a una vita di soprusi e tentano a loro modo di migliorare la propria condizione, si ascoltano nei bar e nelle camere d’albergo, a volte qualcuno tenta di prendere la parola e di emanciparsi. In questo contesto di continuo fermento visivo permane la metafora della riproducibilità tecnica dei film in pellicola, del cinema che entra nelle case con l’avvento dei vhs: il sesso che viene fruito attraverso la proiezione e sempre meno consumato. Corpi si alternano nello schermo, protagonisti di storie ben delineate che si impongono tra spazio privato e spazio pubblico. Eroina tragica della serie, Candy, tenta l’impossibile e riscrive la sua storia, da prostituta e attrice dei primi filmini amatoriali pornografici, diventa regista di film sul sesso, senza mai rinnegare se stessa. Un’emancipazione faticosa e ricca di compromessi a cui fa da contraltare la parabola di Lori, alla quale la liberazione dal proprio protettore/sfruttatore, il successo come attrice porno e il sogno hollywoodiano non bastano per lenire la propria inquietudine. Così il campo e controcampo di uomini e donne, poliziotti e criminali, papponi e puttane è attraversato dalla storia di una città che cambia per non cambiare. La riqualificazione urbana è l’altro tema attorno a cui ruota The Deuce, in un mondo che impone di cambiare i termini dei rapporti e le pedine in gioco per mantenere e sostenere lo squilibrio politico di genere, razza e classe sociale. Il finale mostra la trasformazione avvenuta, la pulizia del centro della città di New York, senza più i suoi protagonisti “pericolosi”, le puttane, i mafiosi italiani, i gay malati di AIDS. Sulla Deuce rimane però ancora chi ascolta al bar, qualcuno che ha lottato, la memoria di chi è passato e una regista riscoperta, in onore del potere rivoluzionario e controverso del mezzo cinematografico. (Giulia Cosentino) Leggi qui la recensione di DinamoPress
La Deuce è una strada di New York che al centro della vita della città è affollata da chi vive i margini. Nel corso delle stagioni i meccanismi della vita cittadina mutano e le mode si impongono prorompenti nei loro colori: trasformazioni che sembrano mantenere e consolidare i rapporti di forza prestabiliti dalla società patriarcale. I tentativi di emancipazione degenerano in continui fallimenti ma nel susseguirsi delle puntate permane una forma di resistenza politica. Ed è proprio il tema della resistenza a incendiare questa serie tv: i personaggi resistono a una vita di soprusi e tentano a loro modo di migliorare la propria condizione, si ascoltano nei bar e nelle camere d’albergo, a volte qualcuno tenta di prendere la parola e di emanciparsi. In questo contesto di continuo fermento visivo permane la metafora della riproducibilità tecnica dei film in pellicola, del cinema che entra nelle case con l’avvento dei vhs: il sesso che viene fruito attraverso la proiezione e sempre meno consumato. Corpi si alternano nello schermo, protagonisti di storie ben delineate che si impongono tra spazio privato e spazio pubblico. Eroina tragica della serie, Candy, tenta l’impossibile e riscrive la sua storia, da prostituta e attrice dei primi filmini amatoriali pornografici, diventa regista di film sul sesso, senza mai rinnegare se stessa. Un’emancipazione faticosa e ricca di compromessi a cui fa da contraltare la parabola di Lori, alla quale la liberazione dal proprio protettore/sfruttatore, il successo come attrice porno e il sogno hollywoodiano non bastano per lenire la propria inquietudine. Così il campo e controcampo di uomini e donne, poliziotti e criminali, papponi e puttane è attraversato dalla storia di una città che cambia per non cambiare. La riqualificazione urbana è l’altro tema attorno a cui ruota The Deuce, in un mondo che impone di cambiare i termini dei rapporti e le pedine in gioco per mantenere e sostenere lo squilibrio politico di genere, razza e classe sociale. Il finale mostra la trasformazione avvenuta, la pulizia del centro della città di New York, senza più i suoi protagonisti “pericolosi”, le puttane, i mafiosi italiani, i gay malati di AIDS. Sulla Deuce rimane però ancora chi ascolta al bar, qualcuno che ha lottato, la memoria di chi è passato e una regista riscoperta, in onore del potere rivoluzionario e controverso del mezzo cinematografico. (Giulia Cosentino) Leggi qui la recensione di DinamoPress
EASY
di Joe Swanberg (Netflix)
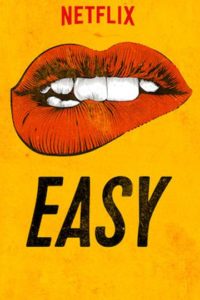 Easy, scritta e prodotta da Joe Swanberg, interroga e racconta il desiderio sessuale tra abitanti di una Chicago tirata a lucido. I personaggi sembrano destinati a non incontrarsi mai, si sfiorano per caso ogni tanto, ma si incontrano sul piano sentimentale, in quanto ripercorrono dinamiche relazionali diverse ma dettate spesso da necessità comuni in un continuo rimando emotivo. È una serie tv eterogenea che parla di corpi e li mette in relazione, che senza intervenire nelle storie intime dei suoi protagonisti ne restituisce i drammi e le delusioni, che racconta il sesso senza giudicarlo, mettendo in scena il conturbante rispettando una grande chiarezza narrativa. Uomini e donne si rappresentano e definiscono attraverso monologhi estenuanti e dialoghi infiniti con gli altri e le altre con cui condividono una relazione amorosa, una fisica o semplicemente uno spazio.
Easy, scritta e prodotta da Joe Swanberg, interroga e racconta il desiderio sessuale tra abitanti di una Chicago tirata a lucido. I personaggi sembrano destinati a non incontrarsi mai, si sfiorano per caso ogni tanto, ma si incontrano sul piano sentimentale, in quanto ripercorrono dinamiche relazionali diverse ma dettate spesso da necessità comuni in un continuo rimando emotivo. È una serie tv eterogenea che parla di corpi e li mette in relazione, che senza intervenire nelle storie intime dei suoi protagonisti ne restituisce i drammi e le delusioni, che racconta il sesso senza giudicarlo, mettendo in scena il conturbante rispettando una grande chiarezza narrativa. Uomini e donne si rappresentano e definiscono attraverso monologhi estenuanti e dialoghi infiniti con gli altri e le altre con cui condividono una relazione amorosa, una fisica o semplicemente uno spazio.
La sessualità è una chiave per costruire o iniziare dei rapporti sociali, ma può anche essere motivo di allontanamento da se stessi. La ricerca di una pratica sessuale più in ascolto del proprio desiderio appare una battaglia politica per l’appagamento personale all’interno di relazioni monogame socialmente accettate. Il movimento circolare dei temi trattati, in un’elegante orchestrazione di eccitazione e compromesso e con uno sguardo sul sesso molto spietato e finalmente libero da banali poeticità, interroga uomini e donne sull’inevitabile egoismo del desiderio e su quanto questo sia motivo d’angoscia per l’altro/a. (Giulia Cosentino)
EUPHORIA
di Sam Levinson (HBO)
 Dunque siamo ancora agli adolescenti che al di fuori dal mondo degli adulti si drogano, scopano, rubano e trasgrediscono ogni regola e norma sociale? Come negli anni Novanta facevano i ragazzini di Kids di Larry Clark o quelli di Gummo di Harmony Korine? Se Euphoria fosse solo questo – se fosse cioè, soltanto lo spostamento un po’ più in là dell’asticella della provocazione, che a livello 2019 significa cazzi in erezione on camera, webcam sex, revenge porn e fluidità sessuale – sarebbe davvero poca cosa e avrebbe ragione chi dice che è solo una mossa pruriginosa di HBO per attirare un po’ di sguardo voyeur (e di abbonamenti). Ma Euphoria non è (solo) questo, è anche una delle più belle riflessioni degli ultimi anni su che cosa voglia dire avere a che fare con un sintomo, ovvero avere a che fare con l’enigma soggettivo per eccellenza: che cosa vuol dire godere, desiderare e fare esperienza dell’abisso a cui ci consegna l’esperienza del desiderio dell’altro (che ci può amare, violentare, usare, con la medesima intensità anche nella stessa relazione)? Una specie di Bildungsroman aggiornato all’epoca del godimento post-edipico e diffuso. E nonostante le mille linee narrative, i forse troppi personaggi, sarà propria la storia di Rue (Zendaya) e della sua addiction quella che in mezzo alla dispersione di questo mondo non solo adolescenziale rende questa serie memorabile. E alla fine – colpo di scena! – non si tratterà di imparare a lasciarsi andare e di liberare il nostro desiderio per farlo diventare fluido e imprendibile (come vuole il senso comune cinico e postmoderno) ma di riscoprire la frustrazione, l’impossibilità, il dubbio, l’esitazione, in una delle scene d’addio in stazione più belle che la storia recente ricordi. Sarebbe bello finirla così con una fine non-fine, ma purtroppo temiamo che sia in arrivo la maledizione della seconda stagione… (Pietro Bianchi)
Dunque siamo ancora agli adolescenti che al di fuori dal mondo degli adulti si drogano, scopano, rubano e trasgrediscono ogni regola e norma sociale? Come negli anni Novanta facevano i ragazzini di Kids di Larry Clark o quelli di Gummo di Harmony Korine? Se Euphoria fosse solo questo – se fosse cioè, soltanto lo spostamento un po’ più in là dell’asticella della provocazione, che a livello 2019 significa cazzi in erezione on camera, webcam sex, revenge porn e fluidità sessuale – sarebbe davvero poca cosa e avrebbe ragione chi dice che è solo una mossa pruriginosa di HBO per attirare un po’ di sguardo voyeur (e di abbonamenti). Ma Euphoria non è (solo) questo, è anche una delle più belle riflessioni degli ultimi anni su che cosa voglia dire avere a che fare con un sintomo, ovvero avere a che fare con l’enigma soggettivo per eccellenza: che cosa vuol dire godere, desiderare e fare esperienza dell’abisso a cui ci consegna l’esperienza del desiderio dell’altro (che ci può amare, violentare, usare, con la medesima intensità anche nella stessa relazione)? Una specie di Bildungsroman aggiornato all’epoca del godimento post-edipico e diffuso. E nonostante le mille linee narrative, i forse troppi personaggi, sarà propria la storia di Rue (Zendaya) e della sua addiction quella che in mezzo alla dispersione di questo mondo non solo adolescenziale rende questa serie memorabile. E alla fine – colpo di scena! – non si tratterà di imparare a lasciarsi andare e di liberare il nostro desiderio per farlo diventare fluido e imprendibile (come vuole il senso comune cinico e postmoderno) ma di riscoprire la frustrazione, l’impossibilità, il dubbio, l’esitazione, in una delle scene d’addio in stazione più belle che la storia recente ricordi. Sarebbe bello finirla così con una fine non-fine, ma purtroppo temiamo che sia in arrivo la maledizione della seconda stagione… (Pietro Bianchi)
FLEABAG
di Phoebe Waller-Bridge (BBC/Amazon)
 In due stagioni e appena dodici episodi complessivi, la londinese Phoebe Waller-Bridge traspone dal teatro al piccolo schermo l’irresistibile parabola relazionale di una trentenne senza nome (soltanto un soprannome tra l’affettuoso e il dispregiativo, letteralmente “sacco di pulci”), ossessionata dal sesso e dal cattivo gusto, votata al senso di colpa e all’autosabotaggio, ma anche viva e passionale: qualcuno capace di masturbarsi su Obama, scoreggiare in ascensore, regalare un vibratore alla sorella ossessivo-compulsiva, boicottare la nuova relazione del padre vedovo. E che fin dall’inizio rompe la quarta parete e ci parla: non tanto per intrattenerci da vicino, ma per farci sentire un suo riflesso, persino una risorsa contro i fantasmi del proprio fallimento. Oggi è impossibile sottovalutare l’impatto che Fleabag ha avuto sul suo pubblico, ma se la serie tv si è rivelata un instant classic, molto si deve alla capacità della sua autrice di non venire meno all’essenzialità del filtro teatrale di partenza: loquela a profusione, un clamoroso polso della scena, dinamiche di potere fra personaggi risolte in fulminanti schermaglie di sguardi, una sessualità ingombrante ma pressoché lasciata fuori campo, scorci londinesi stilizzati o ridotti a pura forma, una sostanziale reticenza insomma a filtrare sociologicamente il contesto del racconto, tacendo persino l’intrusività dell’odierna tecnologia e la trasfigurazione virtuale delle nostre vite. Prima ci innamoriamo della protagonista per prossimità alle sue idiosincrasie, poi lasciamo che a conquistarci sia l’ideale di un amore puro e impossibile, non a caso scoperto accanto a un sacerdote. In questa dialettica tormentata, fertile di spunti sottilissimi sulla condizione femminile, la serie diventa uno splendido trattato sulla solitudine che si fa carico del proprio desiderio, anche quando le sue proiezioni sono incollocabili. Con l’idea, geniale, di smascherare e a poco a poco ribaltare la dipendenza che il personaggio coltiva verso il suo pubblico, a confermare che quella verbosità lunatica e incessante altro non sia che un rimuginare intorno alla propria ferita, finalmente illuminato dalla “grazia” di una potenziale trasformazione. (Marco Longo) Leggi qui la recensione di DinamoPress
In due stagioni e appena dodici episodi complessivi, la londinese Phoebe Waller-Bridge traspone dal teatro al piccolo schermo l’irresistibile parabola relazionale di una trentenne senza nome (soltanto un soprannome tra l’affettuoso e il dispregiativo, letteralmente “sacco di pulci”), ossessionata dal sesso e dal cattivo gusto, votata al senso di colpa e all’autosabotaggio, ma anche viva e passionale: qualcuno capace di masturbarsi su Obama, scoreggiare in ascensore, regalare un vibratore alla sorella ossessivo-compulsiva, boicottare la nuova relazione del padre vedovo. E che fin dall’inizio rompe la quarta parete e ci parla: non tanto per intrattenerci da vicino, ma per farci sentire un suo riflesso, persino una risorsa contro i fantasmi del proprio fallimento. Oggi è impossibile sottovalutare l’impatto che Fleabag ha avuto sul suo pubblico, ma se la serie tv si è rivelata un instant classic, molto si deve alla capacità della sua autrice di non venire meno all’essenzialità del filtro teatrale di partenza: loquela a profusione, un clamoroso polso della scena, dinamiche di potere fra personaggi risolte in fulminanti schermaglie di sguardi, una sessualità ingombrante ma pressoché lasciata fuori campo, scorci londinesi stilizzati o ridotti a pura forma, una sostanziale reticenza insomma a filtrare sociologicamente il contesto del racconto, tacendo persino l’intrusività dell’odierna tecnologia e la trasfigurazione virtuale delle nostre vite. Prima ci innamoriamo della protagonista per prossimità alle sue idiosincrasie, poi lasciamo che a conquistarci sia l’ideale di un amore puro e impossibile, non a caso scoperto accanto a un sacerdote. In questa dialettica tormentata, fertile di spunti sottilissimi sulla condizione femminile, la serie diventa uno splendido trattato sulla solitudine che si fa carico del proprio desiderio, anche quando le sue proiezioni sono incollocabili. Con l’idea, geniale, di smascherare e a poco a poco ribaltare la dipendenza che il personaggio coltiva verso il suo pubblico, a confermare che quella verbosità lunatica e incessante altro non sia che un rimuginare intorno alla propria ferita, finalmente illuminato dalla “grazia” di una potenziale trasformazione. (Marco Longo) Leggi qui la recensione di DinamoPress
KILLING EVE
di Phoebe Waller-Bridge ed Emerald Fennell (BBC/AMC)
 Può far sorridere, ma i personaggi di Phoebe Waller-Bridge sono tutte figure al centro di una sostanziale antropotecnica intorno al tema del desiderio, una sorta di esercizio quotidiano dalle conseguenze sempre più nette o pericolose. Basti pensare alla Eve Polastri protagonista della serie Killing Eve, con cui Waller-Bridge ha portato sullo schermo il ciclo di novelle Villanelle del britannico Luke Jennings: la storia di un’annoiata funzionaria dell’MI-5 che inizia a dare la caccia a un’allucinata sicaria sociopatica e presto realizza, ricambiata, di essere abitata da una vera e propria ossessione, tra eros e thanatos. Anche nei codici del genere – un’efferata spy-story intinta di umorismo – Waller-Bridge eleva la “tentazione di esistere” delle sue protagoniste femminili a destino quasi tragico di cui dover rispondere coram populo, intrecciando acrobaticamente la provocazione morale al bisogno di tracciare percorsi di sopravvivenza alla norma. Come già la protagonista di Fleabag, anche Eve e Villanelle, indiscutibili mind builder, sono accomunate dall’eccentricità della loro azione, tanto più impattante agli occhi del pubblico quanto più ascetico è il loro distaccarsi da un orizzonte globale emotivamente immunizzato. In questa volubile galleria di segni che girano “a ruota libera”, sconquassando il dato ordinario e la norma, c’è lo spazio per omicidi estetizzanti, viaggi sotto copertura in tutta Europa (compresa una lunga parentesi romana) e giochi di inganno e seduzione tra spie esposte al massimo regime di sospetto. Insomma, grande gusto per l’intrattenimento, in odore di nostalgia ma senza compiacimenti. Se infatti l’alchimia tra Eve e Villanelle tiene il passo dopo due stagioni alla stregua di un’ineludibile vocazione, accade perché Waller-Bridge esalta senza freno l’eresia di chi tenta di dare a se stesso una forma propria, qualunque sia il prezzo da pagare nel rapporto trasparente tra libido e destrudo, libertà e verità. Fosse anche un’infinita scia di sangue alle spalle di due donne che non hanno nulla in comune, ma si attraggono al punto da rovesciare il mondo e le sue regole pur di continuare a gravitare l’una intorno all’altra. (Marco Longo)
Può far sorridere, ma i personaggi di Phoebe Waller-Bridge sono tutte figure al centro di una sostanziale antropotecnica intorno al tema del desiderio, una sorta di esercizio quotidiano dalle conseguenze sempre più nette o pericolose. Basti pensare alla Eve Polastri protagonista della serie Killing Eve, con cui Waller-Bridge ha portato sullo schermo il ciclo di novelle Villanelle del britannico Luke Jennings: la storia di un’annoiata funzionaria dell’MI-5 che inizia a dare la caccia a un’allucinata sicaria sociopatica e presto realizza, ricambiata, di essere abitata da una vera e propria ossessione, tra eros e thanatos. Anche nei codici del genere – un’efferata spy-story intinta di umorismo – Waller-Bridge eleva la “tentazione di esistere” delle sue protagoniste femminili a destino quasi tragico di cui dover rispondere coram populo, intrecciando acrobaticamente la provocazione morale al bisogno di tracciare percorsi di sopravvivenza alla norma. Come già la protagonista di Fleabag, anche Eve e Villanelle, indiscutibili mind builder, sono accomunate dall’eccentricità della loro azione, tanto più impattante agli occhi del pubblico quanto più ascetico è il loro distaccarsi da un orizzonte globale emotivamente immunizzato. In questa volubile galleria di segni che girano “a ruota libera”, sconquassando il dato ordinario e la norma, c’è lo spazio per omicidi estetizzanti, viaggi sotto copertura in tutta Europa (compresa una lunga parentesi romana) e giochi di inganno e seduzione tra spie esposte al massimo regime di sospetto. Insomma, grande gusto per l’intrattenimento, in odore di nostalgia ma senza compiacimenti. Se infatti l’alchimia tra Eve e Villanelle tiene il passo dopo due stagioni alla stregua di un’ineludibile vocazione, accade perché Waller-Bridge esalta senza freno l’eresia di chi tenta di dare a se stesso una forma propria, qualunque sia il prezzo da pagare nel rapporto trasparente tra libido e destrudo, libertà e verità. Fosse anche un’infinita scia di sangue alle spalle di due donne che non hanno nulla in comune, ma si attraggono al punto da rovesciare il mondo e le sue regole pur di continuare a gravitare l’una intorno all’altra. (Marco Longo)
MINDHUNTER
di Joe Penhall (Netflix)
 Nel 1977 Holden Ford, giovane negoziatore in crisi dell’FBI, rinnova con l’aiuto del collega e veterano Bill Tench e dell’accademica Wendy Carr la ricerca psicologico-comportamentale su un nuovo tipo di assassino, presto noto come serial killer. È l’inizio di un lungo tour fatto di faccia a faccia sempre più infernali con le celebrità pluriomicide d’America, capace di rendere evidente non solo ai protagonisti ma allo stesso spettatore l’esile barriera contenitiva che separa luce e buio, pensiero e azione, legge e desiderio. Dopo un esordio dal forte respiro teorico, portato avanti attraverso lo sguardo di Ford fino al culmine psicosomatico di un violento attacco di panico, la seconda stagione della serie supervisionata e diretta da David Fincher, basata su fatti e protagonisti reali, rovescia focus e punto di vista, variando in assoluta coerenza. A dispiegarsi lungo gli ultimi nove episodi di Mindhunter, che cominciano dove i precedenti si fermavano, è infatti la meticolosa ricostruzione di una nota pagina di cronaca nera statunitense, quella degli Atlanta child murders, che vide oltre 25 tra bambini e adolescenti nati da famiglie povere nere scomparire e essere ritrovati uccisi tra il 1979 e il 1981. Per Ford e Tench è il banco di prova di una metodologia sempre più avanzata, e al contempo inaccettabile per il senso comune (le famiglie delle vittime) e per l’autorità costituita (le forze di polizia locali): quanto più si fa sistematica, tanto più la tecnica del profiling diventa la cartina di tornasole per mappare il contesto stesso, il suo razzismo e i luoghi comuni di chi ne è vittima, ma anche la macchina burocratica della presunta sicurezza, complicando e estendendo all’infinito una metodologia di indagine destinata a rimanere frustrata, vera e propria croce – come una grande scena-metafora lascerà intendere – per chi come Ford se ne fa quasi ottuso interprete. Sembra di stare in Zodiac, non solo per il ramificarsi a ruota libera delle piste narrative, ma perché l’immagine del colpevole è al contempo data e negata, aprendo al vuoto di un’indefinitezza temporale qualsiasi ipotesi di vittoria dei protagonisti (il caso non si può chiudere: e in effetti resta tuttora irrisolto). Da quello di Ford si scivola poi al primato narrativo del più maturo Tench, la cui vita familiare è sconquassata dal coinvolgimento del figlio ancora bambino in un omicidio tra coetanei: è qui che Mindhunter continua a scavare, utilizzando una paternità affaticata come territorio in cui dispiegare la sua domanda tematica: chi è l’Altro? Perché fa quello che fa? Che poi è la domanda di tutto il cinema di Fincher. (Marco Longo)
Nel 1977 Holden Ford, giovane negoziatore in crisi dell’FBI, rinnova con l’aiuto del collega e veterano Bill Tench e dell’accademica Wendy Carr la ricerca psicologico-comportamentale su un nuovo tipo di assassino, presto noto come serial killer. È l’inizio di un lungo tour fatto di faccia a faccia sempre più infernali con le celebrità pluriomicide d’America, capace di rendere evidente non solo ai protagonisti ma allo stesso spettatore l’esile barriera contenitiva che separa luce e buio, pensiero e azione, legge e desiderio. Dopo un esordio dal forte respiro teorico, portato avanti attraverso lo sguardo di Ford fino al culmine psicosomatico di un violento attacco di panico, la seconda stagione della serie supervisionata e diretta da David Fincher, basata su fatti e protagonisti reali, rovescia focus e punto di vista, variando in assoluta coerenza. A dispiegarsi lungo gli ultimi nove episodi di Mindhunter, che cominciano dove i precedenti si fermavano, è infatti la meticolosa ricostruzione di una nota pagina di cronaca nera statunitense, quella degli Atlanta child murders, che vide oltre 25 tra bambini e adolescenti nati da famiglie povere nere scomparire e essere ritrovati uccisi tra il 1979 e il 1981. Per Ford e Tench è il banco di prova di una metodologia sempre più avanzata, e al contempo inaccettabile per il senso comune (le famiglie delle vittime) e per l’autorità costituita (le forze di polizia locali): quanto più si fa sistematica, tanto più la tecnica del profiling diventa la cartina di tornasole per mappare il contesto stesso, il suo razzismo e i luoghi comuni di chi ne è vittima, ma anche la macchina burocratica della presunta sicurezza, complicando e estendendo all’infinito una metodologia di indagine destinata a rimanere frustrata, vera e propria croce – come una grande scena-metafora lascerà intendere – per chi come Ford se ne fa quasi ottuso interprete. Sembra di stare in Zodiac, non solo per il ramificarsi a ruota libera delle piste narrative, ma perché l’immagine del colpevole è al contempo data e negata, aprendo al vuoto di un’indefinitezza temporale qualsiasi ipotesi di vittoria dei protagonisti (il caso non si può chiudere: e in effetti resta tuttora irrisolto). Da quello di Ford si scivola poi al primato narrativo del più maturo Tench, la cui vita familiare è sconquassata dal coinvolgimento del figlio ancora bambino in un omicidio tra coetanei: è qui che Mindhunter continua a scavare, utilizzando una paternità affaticata come territorio in cui dispiegare la sua domanda tematica: chi è l’Altro? Perché fa quello che fa? Che poi è la domanda di tutto il cinema di Fincher. (Marco Longo)
OUR BOYS
di Hagai Levi, Joseph Cedar e Tawfik Abu-Wael (HBO Israel)
 Al centro di un violento dibattito che ha appena sfiorato le pagine statunitensi (in fondo la serie è stata prodotta, in collaborazione con l’israeliana Keshet, da Hbo, che l’ha mandata in onda sul proprio canale) ed europee, Our Boys è uno degli esempi più lampanti dell’importanza della serialità televisiva per l’immaginario collettivo. Il primo ministro israeliano Netanyahu infatti, con un post sulla propria pagina Facebook, ha invitato tutto il paese a boicottare la serie tv ancor prima che andasse in onda il primo episodio, in quanto sarebbe stata colpevole di antisemitismo (poco importa che due dei tre creatori siano ebrei israeliani e uno dei due ortodosso). L’accusa nasce dalle scelte narrative fatte dagli autori per raccontare gli eventi, realmente accaduti nel 2014, preludio (se non la miccia) di un’estate di fuoco a Gaza. Attraverso un registro iperrealista viene messo in scena il rapimento e l’omicidio di Mohammed Abu Khdeir da parte di tre israeliani, atto a vendicare quello di Naftali Fraenkel, Gil-Ad Shaer e Eyal Yifrah uccisi poco tempo prima da Hamas. Quest’ultimo fatto tuttavia, a parte un breve accenno iniziale, viene lasciato consapevolmente fuoricampo. Netanyahu manca completamente il bersaglio affermando che i tre adolescenti israeliani uccisi avrebbero “meritato” uno spazio equo. Ma a mancarlo è anche una larga parte della stampa di sinistra, entusiasta (“Haaretz”) o meno (“+972”). Il motivo è semplice: Our Boys parla della società israeliana rifiutando lo specchio palestinese. Esaurita la fede in una società come laboratorio propria dell’ideologia sionista, le narrazioni egemoni necessitano dell’Altro palestinese per nascondere le crepe ciclopiche che la dividono e che ne mettono a rischio la stabilità tanto quanto la questione “esterna”. Grazie all’approccio iperrealista possiamo mettere da parte l’evento centrale (e alcune sbavature e stereotipizzazioni nello sviluppare i personaggi palestinesi) e vedere cosa resta ai lati: mizrahim contro aschkenazim, laici contro haredim, coloni contro residenti in Israele; a volte un conflitto sopra l’altro e identità che raddoppiano o triplicano lo stigma di altre. Nessun film o serie tv come Our Boys mostra la fallacia israeliana di certificare la propria unità attraverso lo specchio dell’Altro e l’urgente necessità di credere malgrado tutto in quelle crepe che rifiuta di vedere per intraprendere una nuova trasformazione di sé. (Jacopo Favi)
Al centro di un violento dibattito che ha appena sfiorato le pagine statunitensi (in fondo la serie è stata prodotta, in collaborazione con l’israeliana Keshet, da Hbo, che l’ha mandata in onda sul proprio canale) ed europee, Our Boys è uno degli esempi più lampanti dell’importanza della serialità televisiva per l’immaginario collettivo. Il primo ministro israeliano Netanyahu infatti, con un post sulla propria pagina Facebook, ha invitato tutto il paese a boicottare la serie tv ancor prima che andasse in onda il primo episodio, in quanto sarebbe stata colpevole di antisemitismo (poco importa che due dei tre creatori siano ebrei israeliani e uno dei due ortodosso). L’accusa nasce dalle scelte narrative fatte dagli autori per raccontare gli eventi, realmente accaduti nel 2014, preludio (se non la miccia) di un’estate di fuoco a Gaza. Attraverso un registro iperrealista viene messo in scena il rapimento e l’omicidio di Mohammed Abu Khdeir da parte di tre israeliani, atto a vendicare quello di Naftali Fraenkel, Gil-Ad Shaer e Eyal Yifrah uccisi poco tempo prima da Hamas. Quest’ultimo fatto tuttavia, a parte un breve accenno iniziale, viene lasciato consapevolmente fuoricampo. Netanyahu manca completamente il bersaglio affermando che i tre adolescenti israeliani uccisi avrebbero “meritato” uno spazio equo. Ma a mancarlo è anche una larga parte della stampa di sinistra, entusiasta (“Haaretz”) o meno (“+972”). Il motivo è semplice: Our Boys parla della società israeliana rifiutando lo specchio palestinese. Esaurita la fede in una società come laboratorio propria dell’ideologia sionista, le narrazioni egemoni necessitano dell’Altro palestinese per nascondere le crepe ciclopiche che la dividono e che ne mettono a rischio la stabilità tanto quanto la questione “esterna”. Grazie all’approccio iperrealista possiamo mettere da parte l’evento centrale (e alcune sbavature e stereotipizzazioni nello sviluppare i personaggi palestinesi) e vedere cosa resta ai lati: mizrahim contro aschkenazim, laici contro haredim, coloni contro residenti in Israele; a volte un conflitto sopra l’altro e identità che raddoppiano o triplicano lo stigma di altre. Nessun film o serie tv come Our Boys mostra la fallacia israeliana di certificare la propria unità attraverso lo specchio dell’Altro e l’urgente necessità di credere malgrado tutto in quelle crepe che rifiuta di vedere per intraprendere una nuova trasformazione di sé. (Jacopo Favi)
RAMY
di Ramy Youssef, Ari Katcher e Ryan Welch (Hulu)
 Nel panorama televisivo c’è un rispetto quasi religioso per il concetto d’identità, anche nei casi più virtuosi in cui viene declinato per raccontare disuguaglianze e discriminazioni che gruppi subalterni subiscono sistematicamente. Rimane tuttavia uno strumento equivoco che rischia di rimuovere le contraddizioni vissute dalle persone e diventare un confine che aiuta a riconoscere l’Altro solo in quanto al di là di quest’ultimo. Ramy di Ramy Youssef prende la direzione opposta e, avanzando a suon di strafalcioni del suo protagonista (con una narrazione quasi slapstick), mette in luce l’impossibilità di “ritrovare” una purezza identitaria che aiuti ad orientarsi tra le contraddizioni della contemporaneità. Ramy è un ragazzo statunitense di padre egiziano e madre palestinese, frequentatore regolare della propria moschea tanto quanto dei party il sabato sera, voglioso di una relazione con una donna musulmana ma scandalizzato se questa manifesta il proprio desiderio sessuale. Sempre diviso tra due posizioni all’apparenza inconciliabili, qualsiasi cosa faccia si sente sempre fuori posto. E in fondo lo è. Ma invece di accettare e vivere le proprie contraddizioni, decide di intraprendere un percorso di pulizia (a volte letterale, come quando si mette a lucidare ogni angolo di un’intera moschea per smaltire l’effetto di un orsetto gommoso ad alto tasso di Thc) personale con risultati tra il comico e il tragico. Durante il ramadan, che vive come decisivo, finisce per fare sesso con una donna sposata e il viaggio in Egitto alla ricerca delle proprie radici inizia con un funerale, impedendogli l’accesso a quel sapere che tanto bramava. Il risultato finale di questo sorprendente prodotto televisivo è proprio il funerale alle radici e all’identità incontaminata, perché, come scritto da un brillante antropologo, «i frutti puri impazziscono»ı. Proprio come Ramy. (Jacopo Favi)
Nel panorama televisivo c’è un rispetto quasi religioso per il concetto d’identità, anche nei casi più virtuosi in cui viene declinato per raccontare disuguaglianze e discriminazioni che gruppi subalterni subiscono sistematicamente. Rimane tuttavia uno strumento equivoco che rischia di rimuovere le contraddizioni vissute dalle persone e diventare un confine che aiuta a riconoscere l’Altro solo in quanto al di là di quest’ultimo. Ramy di Ramy Youssef prende la direzione opposta e, avanzando a suon di strafalcioni del suo protagonista (con una narrazione quasi slapstick), mette in luce l’impossibilità di “ritrovare” una purezza identitaria che aiuti ad orientarsi tra le contraddizioni della contemporaneità. Ramy è un ragazzo statunitense di padre egiziano e madre palestinese, frequentatore regolare della propria moschea tanto quanto dei party il sabato sera, voglioso di una relazione con una donna musulmana ma scandalizzato se questa manifesta il proprio desiderio sessuale. Sempre diviso tra due posizioni all’apparenza inconciliabili, qualsiasi cosa faccia si sente sempre fuori posto. E in fondo lo è. Ma invece di accettare e vivere le proprie contraddizioni, decide di intraprendere un percorso di pulizia (a volte letterale, come quando si mette a lucidare ogni angolo di un’intera moschea per smaltire l’effetto di un orsetto gommoso ad alto tasso di Thc) personale con risultati tra il comico e il tragico. Durante il ramadan, che vive come decisivo, finisce per fare sesso con una donna sposata e il viaggio in Egitto alla ricerca delle proprie radici inizia con un funerale, impedendogli l’accesso a quel sapere che tanto bramava. Il risultato finale di questo sorprendente prodotto televisivo è proprio il funerale alle radici e all’identità incontaminata, perché, come scritto da un brillante antropologo, «i frutti puri impazziscono»ı. Proprio come Ramy. (Jacopo Favi)
TALES OF THE CITY
di Lauren Morelli (Netflix)
 Il sequel/revival prodotto quest’anno da Netflix, indeciso tra il puntare su una fan-base nostalgica delle vecchie stagioni o su un pubblico nuovo, è riuscito a scontentare entrambi. Ha però avuto il merito di rendere nota al pubblico europeo una serie imperfetta ma affascinante. Piagata da una storia produttiva travagliata, che ha fatto uscire tre stagioni nell’arco di otto anni (1993-2001) con un ricambio di attori non sempre all’altezza, la “saga” di Tales of the City ripaga, soprattutto nella prima stagione, con fotografia, colonna sonora e scenografie curate ed evocative, che accostate alle improbabili avventure ideate da Armistead Maupin (nate come column sul free-press locale “Pacific Sun” nel 1974) creano uno straniamento quasi lynchiano. C’è qualcosa di naif e allo stesso tempo perturbante nel mondo che esce dalla sua penna: c’è l’indagine sottile e affettuosa di un microcosmo di relazioni queer, con personaggi indimenticabili (specie quelli femminili: la matriarca transgender Anna Madrigal in primis, o l’ottuagenaria tenutaria di bordello Mother Mucca), ma allo stesso tempo Maupin non rinuncia a sotto-trame pulp da thriller di genere. Anche se abbondano sesso, droga (e, più avanti, l’HIV), sembra di sfogliare un libro di avventure per l’infanzia, in cui gli intrighi sono stemperati dal calore della famiglia (of choice, in questo caso). Proprio questo rispecchia l’atmosfera da paese dei balocchi per adulti che si doveva respirare a San Francisco negli anni Settanta, quella di un’eterotopia. Fedele a quello spirito, anche la nuova stagione finisce per ridurre a intrattenimento temi scomodi come la repressione (di un tempo) e la gentrificazione (di oggi), mettendo al centro quello del passaggio del testimone tra due generazioni molto diverse, offrendo in definitiva una versione meno drammatica e profonda (ma non per questo necessariamente meno interessante) di Transparent nella volontà di raccontare la storia della comunità LGBT+ statunitense. (Elisa Cuter)
Il sequel/revival prodotto quest’anno da Netflix, indeciso tra il puntare su una fan-base nostalgica delle vecchie stagioni o su un pubblico nuovo, è riuscito a scontentare entrambi. Ha però avuto il merito di rendere nota al pubblico europeo una serie imperfetta ma affascinante. Piagata da una storia produttiva travagliata, che ha fatto uscire tre stagioni nell’arco di otto anni (1993-2001) con un ricambio di attori non sempre all’altezza, la “saga” di Tales of the City ripaga, soprattutto nella prima stagione, con fotografia, colonna sonora e scenografie curate ed evocative, che accostate alle improbabili avventure ideate da Armistead Maupin (nate come column sul free-press locale “Pacific Sun” nel 1974) creano uno straniamento quasi lynchiano. C’è qualcosa di naif e allo stesso tempo perturbante nel mondo che esce dalla sua penna: c’è l’indagine sottile e affettuosa di un microcosmo di relazioni queer, con personaggi indimenticabili (specie quelli femminili: la matriarca transgender Anna Madrigal in primis, o l’ottuagenaria tenutaria di bordello Mother Mucca), ma allo stesso tempo Maupin non rinuncia a sotto-trame pulp da thriller di genere. Anche se abbondano sesso, droga (e, più avanti, l’HIV), sembra di sfogliare un libro di avventure per l’infanzia, in cui gli intrighi sono stemperati dal calore della famiglia (of choice, in questo caso). Proprio questo rispecchia l’atmosfera da paese dei balocchi per adulti che si doveva respirare a San Francisco negli anni Settanta, quella di un’eterotopia. Fedele a quello spirito, anche la nuova stagione finisce per ridurre a intrattenimento temi scomodi come la repressione (di un tempo) e la gentrificazione (di oggi), mettendo al centro quello del passaggio del testimone tra due generazioni molto diverse, offrendo in definitiva una versione meno drammatica e profonda (ma non per questo necessariamente meno interessante) di Transparent nella volontà di raccontare la storia della comunità LGBT+ statunitense. (Elisa Cuter)
WHEN THEY SEE US
di Ava DuVernay (Netflix)
 Ormai possiamo dire, dopo più di 10 anni di fulminante carriera, che esistano due Ava DuVernay: quella che ha sviluppato una tra le riflessioni più avanzate e politicamente più radicali sul razzismo istituzionale statunitense (come nel documentario 13th ma anche nel meno conosciuto My Mic Sounds Nice su femminismo e Hip-Hop o nel suo secondo lungometraggio Middle of Nowhere); e quella che collabora in innumerevoli progetti con Oprah Winfrey, che ha diretto l’orribile disneyano A Wrinkle in Time e che si è fatta portatrice di quella visione consolatoria e neoliberale che vede nella resilienza e nella capacità di riscatto individuale l’unica possibile narrazione soggettiva. Già in Selma queste due anime coesistevano, ma ancora di più caratterizzano (e in un certo senso dividono in due) questo When They See Us, mini-serie Netflix incentrata sul caso giudiziario dei Central Park Five: uno dei più grandi scandali giuridici dell’America recente e, in un certo senso, un sintomo emblematico dell’ingiustizia e del razzismo che ancora oggi caratterizzano il sistema giudiziario americano. Cinque ragazzi neri di Harlem (quattro dei quali minorenni) che vengono incolpati dello stupro e del tentato omicidio di una donna bianca di 28 anni che il 19 aprile 1989 stava andando a fare jogging di sera a Central Park. Non ci sono evidenze oggettive né prove che li possano incolpare, solo delle dichiarazioni estorte a botte dalla polizia (e poi subito ritrattate) con cui i ragazzi confessano il loro crimine. Nonostante le mille incongruenze i cinque finiranno per essere condannati e per fare diversi anni di carcere. E la serie oscilla – proprio come il pensiero della DuVernay – tra sguardi in macchina, dichiarazioni d’amore e di resilienza che dovrebbero essere più forti di qualunque ingiustizia (secondo il tipico repertorio di buonismo confortevole a cui ci ha abituato Oprah Winfrey in questi anni, ovvero secondo uno dei più grandi dispositivi di introiezione della propria subordinazione sociale) e un’accusa potente al razzismo intrinseco e strutturale (cioè indipendente da ogni logica della mela marcia) di polizia, giudici e assistenti sociali. Ma questi sono i due poli entro cui si dibatte oggi la questione razziale americana e la serie ha l’enorme merito di riportarceli in tutta la loro ambiguità e potenzialità politica. Che è poi quella con cui si deve confrontare oggi il movimento black post-Black Lives Matter. (Pietro Bianchi)
Ormai possiamo dire, dopo più di 10 anni di fulminante carriera, che esistano due Ava DuVernay: quella che ha sviluppato una tra le riflessioni più avanzate e politicamente più radicali sul razzismo istituzionale statunitense (come nel documentario 13th ma anche nel meno conosciuto My Mic Sounds Nice su femminismo e Hip-Hop o nel suo secondo lungometraggio Middle of Nowhere); e quella che collabora in innumerevoli progetti con Oprah Winfrey, che ha diretto l’orribile disneyano A Wrinkle in Time e che si è fatta portatrice di quella visione consolatoria e neoliberale che vede nella resilienza e nella capacità di riscatto individuale l’unica possibile narrazione soggettiva. Già in Selma queste due anime coesistevano, ma ancora di più caratterizzano (e in un certo senso dividono in due) questo When They See Us, mini-serie Netflix incentrata sul caso giudiziario dei Central Park Five: uno dei più grandi scandali giuridici dell’America recente e, in un certo senso, un sintomo emblematico dell’ingiustizia e del razzismo che ancora oggi caratterizzano il sistema giudiziario americano. Cinque ragazzi neri di Harlem (quattro dei quali minorenni) che vengono incolpati dello stupro e del tentato omicidio di una donna bianca di 28 anni che il 19 aprile 1989 stava andando a fare jogging di sera a Central Park. Non ci sono evidenze oggettive né prove che li possano incolpare, solo delle dichiarazioni estorte a botte dalla polizia (e poi subito ritrattate) con cui i ragazzi confessano il loro crimine. Nonostante le mille incongruenze i cinque finiranno per essere condannati e per fare diversi anni di carcere. E la serie oscilla – proprio come il pensiero della DuVernay – tra sguardi in macchina, dichiarazioni d’amore e di resilienza che dovrebbero essere più forti di qualunque ingiustizia (secondo il tipico repertorio di buonismo confortevole a cui ci ha abituato Oprah Winfrey in questi anni, ovvero secondo uno dei più grandi dispositivi di introiezione della propria subordinazione sociale) e un’accusa potente al razzismo intrinseco e strutturale (cioè indipendente da ogni logica della mela marcia) di polizia, giudici e assistenti sociali. Ma questi sono i due poli entro cui si dibatte oggi la questione razziale americana e la serie ha l’enorme merito di riportarceli in tutta la loro ambiguità e potenzialità politica. Che è poi quella con cui si deve confrontare oggi il movimento black post-Black Lives Matter. (Pietro Bianchi)
