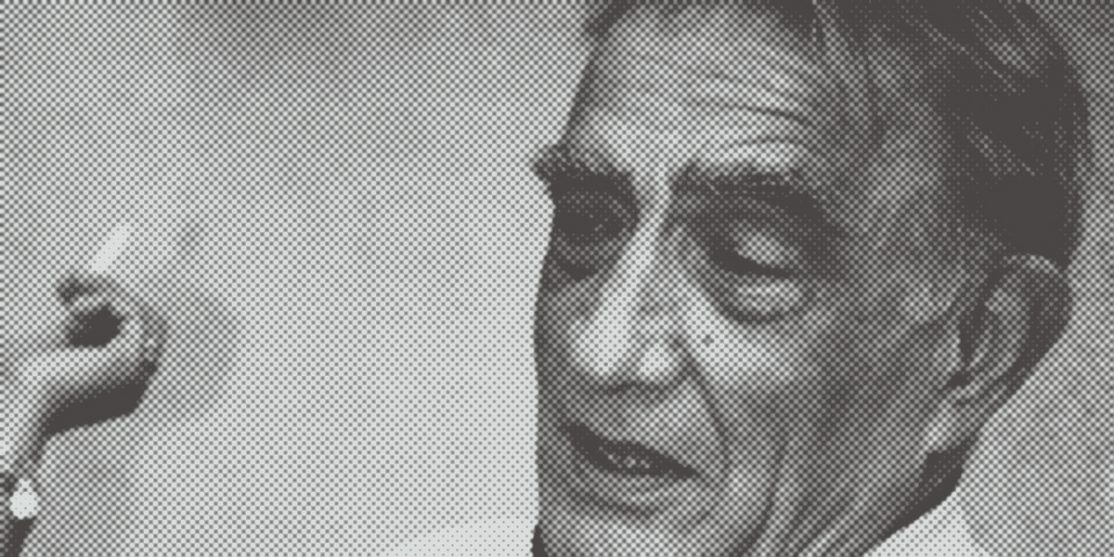MONDO

Rifugiati, Netanyahu decide la deportazione
I rifugiati eritrei e sudanesi che vivono in Israele da 15 anni rischiano ora concretamente la deportazione in Africa a causa di una recente legge emanata dalla Knesset. Il loro destino è appeso ad un filo, mentre il mondo rimane a guardare, nel paese si estendono le proteste
L’arrivo di un flusso costante di rifugiati sudanesi ed eritrei in Israele ha inizio nel 2005/2006. La migrazione, in quegli anni, ha luogo attraverso il deserto del Sinai, dove i migranti, prima di arrivare a destinazione, subiscono sistematicamente sequestri e torture da parte della malavita beduina che controlla il territorio.
Nonostante questo orrore, la possibilità (o per meglio dire l’illusione) di raggiungere un lembo di mondo “occidentale” senza dover attraversare il mare ha spinto negli anni migliaia di persone a compiere quella tratta. Tra il 2012 e il 2013 tuttavia, il governo israeliano completa la costruzione di un muro di separazione lungo il confine con l’Egitto, fatto che provoca una riduzione drastica dei migranti che riescono effettivamente a entrare in Israele. Nel 2017 non è riuscito ad arrivare nessun migrante dall’Egitto.
Coloro che sono riusciti ad attraversare il deserto non hanno comunque una vita facile. Israele ha una bassissima percentuale di riconoscimento dell’asilo politico e nel frattempo si può ottenere un permesso di soggiorno temporaneo (a volte di solo 1 mese), in attesa del responso. La procedura per la richiesta è pure estremamente farraginosa e in migliaia semplicemente non riescono ad accedere ai moduli per fare domanda. Non è poi semplice, con questo permesso temporaneo, accedere a una serie di servizi minimi, come istruzione e sanità.
La maggior parte dei richiedenti asilo oggi vive a Tel Aviv, adattandosi a condizioni precarie di vita. Circa 3500 vivono in centri di reclusione, soprattutto in quello tristemente famoso di Holot, sopportando gravi privazioni dei diritti di base.
Negli anni, molti governi hanno cercato di rendere insostenibili le condizioni di vita dei rifugiati in Israele con provvedimenti tra i più disparati quali l’obbligo di rimanere confinati in alcuni quartieri a sud di Tel Aviv e con una propaganda mediatica assillante relativa agli “infiltrators” come vengono definiti dai giornali e dai politici di destra.
A dicembre scorso il governo Netanyahu ha approvato una legge che sa molto di “deportazione di massa”: si stimano a oggi circa 28.000 eritrei e 9.000 sudanesi presenti nel territorio israeliano, più quelli già in detenzione, per un totale di circa 40.000 persone.
Sostanzialmente a chi viene negato l’asilo politico (cioè in pratica la totalità della popolazione rifugiata) vengono proposte ora due alternative: o la detenzione indefinita, o un rimpatrio in Uganda e Rwanda con i quali Israele ha stretto accordi bilaterali e che vengono considerati “paesi sicuri”. Devono scegliere cosa fare entro tre mesi.
L’allarme è scattato, le possibilità che il provvedimento nelle prossime settimane venga attuato sono reali. Molte testimonianze raccontano che, in passato, chi è stato deportato in Rwanda è poi stato imprigionato, torturato o costretto dalla mancanza di alternative a ripartire lungo le rotte verso la Libia.
A dicembre sono iniziate, contro il provvedimento, proteste in varie parti del paese, che hanno visto in prima persona i rifugiati organizzarsi e prendere parola, ad esempio incatenandosi come schiavi davanti al parlamento o in protesta davanti all’ambasciata del Rwanda o davanti alla residenza del Presidente della Repubblica Rivlin.
Ma la protesta si è allargata anche a livelli inaspettati, tanto che tre piloti della compagnia di bandiera El Al hanno dichiarato ai giornali nazionali che si rifiuteranno di guidare i voli della deportazione.
Gli attivisti israeliani in primo piano in questa battaglia ricordano sempre la vergognosa contraddizione di questa politica del governo. Israele è un paese che, alla sua nascita, si proclamava il luogo dove il popolo ebraico, storicamente in fuga da persecuzioni, poteva stare al sicuro. Ora in quello stesso paese, il governo perseguita e deporta chi è arrivato lì fuggendo da guerre e violenze, e lo fa solo per il fatto che non sono ebrei.
Le associazioni di rifugiati e i tanti attivisti che stanno sostenendo le proteste sperano che le mobilitazioni possano influenzare l’opinione pubblica e quindi il governo, riuscendo ad allontanare il baratro di una deportazione così devastante.
In generale, la questione rifugiati riesce ad avere più supporto tra la popolazione rispetto alla questione palestinese. Per molti attivisti e compagni la lotta per i diritti dei rifugiati è sempre stata un’opportunità per stimolare le coscienze all’idea che si potesse convivere con popoli che non hanno la tua religione e la tua lingua: quasi un viatico concreto a una possibile convivenza futura anche con la popolazione palestinese.
Va inoltre ricordato che ora Netanyahu vuole espellere famiglie che vivono da 15 anni a Tel Aviv, che hanno fatto figli che vanno a scuola lì, che hanno imparato l’ebraico e lavorano in città mantenendo una stretta trama di relazioni di vita con il territorio. La violenza che la deportazione determinerebbe nelle loro vite è solo immaginabile.
Intanto sabato notte attivisti hanno fatto visita agli uffici per le migrazioni del Ministero dell’Interno, con vernice rossa e teste di manichini. Per vendetta, nella giornata di domenica, il ministero si è rifiutato di accettare ogni richiesta di asilo.
L’Europa amica di Israele non si pronuncia sulla questione, tanto meno il destino di 40.000 persone pone alcun problema all’amministrazione Trump, mentre un appello dell’UNHCR che chiedeva di fermare le deportazioni offrendo collaborazione per soluzioni alternative è, a oggi, rimasto inascoltato. Il conto alla rovescia dei tre mesi finali prima della deportazione va avanti inesorabilmente.