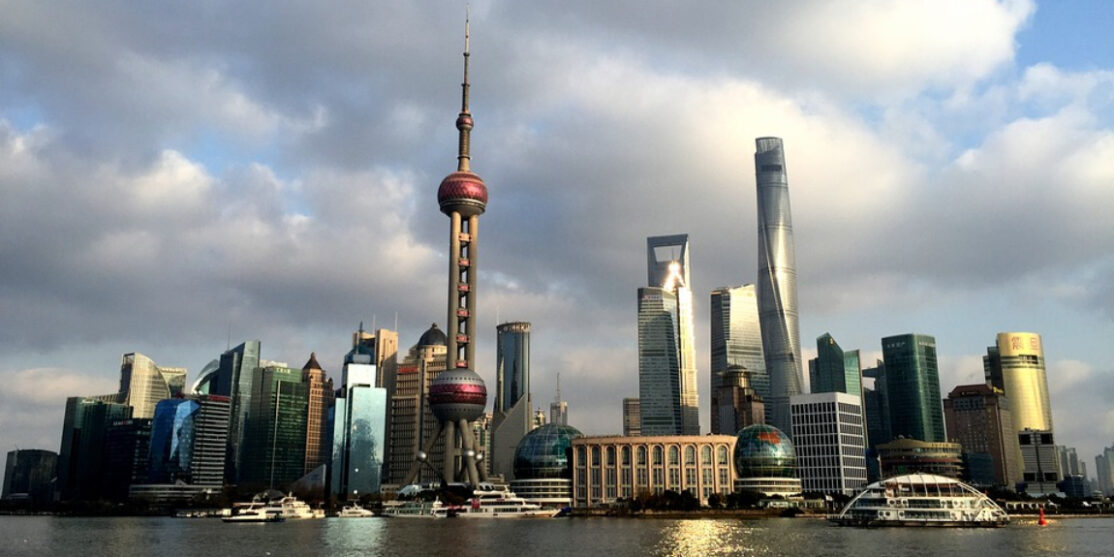COMMONS

Perché dovremmo odiare la Silicon Valley. Appunti sui Big Data
Come dimostra il caso recente di Facebook e dei Cambridge Analitica, l’utilizzo commerciale dei Big Data pone interrogativi urgenti sullo sfruttamento e sul controllo messo in campo dalle piattaforme
Non è oro tutto ciò che brilla; né gli erranti son perduti
È essenziale partire dalla base: di cosa parliamo quando parliamo di Big Data? Il termine Big Data racchiude tutte quelle tecnologie e metodologie volte all’analisi di enormi quantità di dati, al fine di trarne un output, un risultato strutturato ed utilizzabile. Grazie allo studio dei Big Data è possibile stabilire collegamenti laddove prima non ce n’erano, portare alla luce tutta una serie di connessioni fra fenomeni a prima vista estremamente diversi tra loro, stabilire dei pattern e delle causalità precedentemente impossibili da analizzare. Grazie all’utilizzo intensivo di tecnologie in grado di sfruttare questa mole enorme di informazioni, quali ad esempio le tecniche di Machine Learning e le relative Intelligenze Artificiali, si sta entrando nel pieno della quarta rivoluzione industriale, quella digitale. L’utilizzo crescente di dispositivi definiti smart è un perfetto indice d’analisi di questa rivoluzione alle porte: nei prossimi anni si avrà a che fare con un aumento esponenziale della tendenza alla connettività che già è possibile osservare in tutti campi del quotidiano. L’irruzione sul mercato delle tecnologie definite I.O.T, acronimo di internet of things, sarà il passo decisivo in questa direzione. Grazie all’implementazione ormai prossima del nuovo standard della rete fino a 5ghz e allo sviluppo di una fetta di mercato completamente nuova, quella legata al concetto di smart houses, sarà possibile coronare il sogno di ogni neo-liberale d’occidente e sviluppare una rete interamente circolare, tracciabile fra consumatori e produttori. Tutti i prodotti che prima non erano in grado di fornire informazioni sul loro uso e consumo, diventeranno improvvisamente miniere dalle quali estrarre le miriadi di dati sui consumatori e sulle modalità d’uso dei prodotti stessi.
Come ogni rivoluzione che si rispetti, la rivoluzione digitale ha una sua avanguardia: parliamo di GAFAM. L’acronimo G.A.F.A.M sta per Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft; giganti dell’Hi-tech, veri Signori della Silicon Valley e alfieri del modello di business neo-liberale americano. L’arrivo sul mercato di queste piattaforme, è superfluo dirlo, ha cambiato le regole del gioco per tutti i partecipanti. Se parliamo oggi di rivoluzione digitale è perché questi attori sono stati in grado di reinterpretare e far evolvere il concetto stesso di capitalismo, tanto da rendere necessario parlare di capitalismo delle piattaforme. Attraverso un capolavoro di social engineering ed economia neo-liberale, queste aziende sono riuscite ad ottenere il monopolio su quella che è oggi considerata la nuova fonte di ricchezza per eccellenza, le informazioni. Per capire questo passaggio fondamentale, è necessario tenere presente una cosa: tutta la potenzialità legata all’utilizzo dei Big Data dipende da un prerequisito essenziale, ovvero la capacità materiale di estrarre e raffinare il dato allo stato grezzo, rendendolo immediatamente spendibile sul mercato concorrenziale. La catena di funzionamento è presso a poco questa: quando gli utenti delle piattaforme condividono le proprie informazioni, di qualsiasi genere siano, esse vengono immagazzinate e protocollate in giganteschi server fisici blindati nel deserto di chissà dove (principalmente negli Stati Uniti); da questi server i dati vengono letteralmente dati in pasto a Intelligenze Artificiali che, attraverso l’uso del Machine Learning, ne trarranno informazioni rilevanti al fine del perfetto sfruttamento in termini commerciali dell’utente.
Nella teoria economica classica si ipotizza solitamente la common knowledge: si assume che il mercato produca tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’equilibrio fra domanda e offerta e che non vi siano informazioni rilevanti che rimangono nascoste. Questa impostazione viene spazzata via dal business dell’info-sfera, rendendo il settore Big Data immune a qualsiasi regolamentazione e forma di controllo. Le piattaforme alle quali vengono cedute queste enormi quantità di dati procedono ad una profilazione ossessiva e serrata di ogni utilizzatore: le piattaforme sanno di me cose che nemmeno io conosco, sanno che probabilmente a me piacerà un certo tipo di cibo, un certo tipo di posto, un certo tipo di partner. Nell’economia, anche in quella più predatoria, si è sempre assunto un punto diverso: io sono io, tu sei tu e ci incontreremo sul mercato. Ora c’è qualcuno che sa già, con una ragionevole probabilità di successo, cosa a me piacerà. Probabilmente prima ancora che lo sappia io. In caso contrario sarà comunque nell’invidiabile posizione di poter indirizzare, in modo tutt’altro che trasparente, ma soprattutto in modo esclusivo, la mia scelta. Questo porta inevitabilmente alla scomparsa della privacy come la conosciamo, alla creazione di monopoli mai visti in precedenza, nonché alla necessità di ripensare dalle fondamenta il rapporto di sfruttamento alla base di questa nuova modalità d’estrazione del plusvalore.
Il punto chiaramente non è difendere la concorrenzialità nel mercato liberale, né limitarsi alla difesa del diritto sulla privacy, ma prendere atto una volta per tutte del meccanismo di controllo biopolitico che agisce indisturbato all’interno di questo processo. In precedenza grazie al gap informativo fra la domanda e l’offerta, grazie a questo spazio più o meno individuale di indeterminatezza, era possibile trovare riparo dalle conseguenze psicologiche devastanti dell’avanzata del capitalismo orgiastico; si sapeva che, nonostante tutto esistevano campi non ancora direttamente indicizzati e quindi relativamente impermeabili alla dittatura dell’algoritmo e alla datacrazia, questa consapevolezza forniva un’importante rassicurazione rispetto agli spazi dell’autonomia personale e alle modalità possibili di resistenza, un conforto davanti alla brutalità del mercato. Un argine, se vogliamo di passività, che conservava però in modo agambeniano la possibilità della sovversione a fronte della crescente forza attrattiva del sistema capitalistico. Ad oggi questo spazio sembra essersi chiuso definitivamente. Cosi come analizza lucidamente Mark Fisher nelle prime pagine del suo ultimo libro, Realismo Capitalista (recentemente edito in in Italia da Not), la forza soverchiante del sistema capitalistico ha trovato il modo di ostacolare e soffocare persino l’idea di un’alternativa sostenibile, rendendo più semplice immaginare la fine del mondo piuttosto che quella del capitalismo. Come spiega bene Morozov nei Signori del Silicio: «Il modello data-centrico del capitalismo della Silicon Valley cerca di convertire ogni aspetto delle nostre vite – ciò che di norma costituiva l’unica tregua dagli imprevisti del lavoro e dalle ansie del mercato – in una risorsa produttiva. Per riuscirci non solo fa sfumare la distinzione tra lavoro e non-lavoro, ma ci fa anche accettare l’idea che la nostra reputazione sia costantemente in costruzione, qualcosa che possiamo e dobbiamo perfezionare ventiquattrore al giorno. Di conseguenza, tutto si trasforma in una risorsa produttiva: le nostre relazioni, la vita familiare, le vacanze e persino il sonno».
Dietro la semplice accettazione di termini e condizioni di utilizzo, pre-requisito minimo per usufruire di ogni servizio legato a queste piattaforme, troviamo nascosto ma non troppo, un vero e proprio patto col Diavolo degno della miglior rappresentazione del Faust di Goethe. Quello a cui realmente si acconsente accettando i termini è la creazione di cosiddette ego chambers, all’interno delle quali rinchiudere i nostri interessi, le nostre passioni, le nostre idee e non ultimo i nostri corpi. In queste camere dell’ego, accade quello che quotidianamente e sempre più spesso accade sui social network: la profilazione efficente e sempre meglio ottimizzata delle nostre personalità permette ai proprietari delle piattaforme di costruire una comfort zone, uno spazio chiuso ermeticamente, nel quale ciò che vediamo, ascoltiamo e sentiamo è unicamente ciò che tendenzialmente ci piacerebbe vedere, ascoltare e sentire. L’annullamento di qualsiasi differenza significativa, di qualsiasi criticità, di qualsiasi negazione in grado di portare l’user fuori dal suo circolo ristretto di auto-referenzialità e solipsismo, diventa obbiettivo primario dell’esperienza digitale. Inseguendo l’illusione di un’esperienza libera supportata dal mito della neutralità, si finisce per sperimentare il condizionamento e la sorveglianza più stringenti. Ben oltre il sogno di qualsiasi governo autoritario.
Il risultato, come spiega chiaramente Salvatore Iaconesi in questo articolo magistrale è che «tendenzialmente nulla ha più importanza e significato. Chiusi nelle nostre bolle, perdiamo progressivamente la possibilità di comprendere cosa sia reale e cosa fasullo. Non la capacità o la sensibilità di capirlo, ma proprio la possibilità. Viviamo chiusi in bolle di informazione, in cui ogni sapere, dato o nozione, progressivamente, è personalizzato, aggiustato, adattato, filtrato, per sembrarci rilevante, interessante, per stimolare la nostra partecipazione, attivazione, click, espressione».
La forza di questo dispositivo biopolitico risiede in un funzionamento relativamente semplice e per niente nuovo: tutte le informazioni che vengono assorbite e che vanno ad arricchire gli enormi database di questi moderni leviatani, vengono cedute, come insegna Foucault, in modo completamente consenziente. Questo dispositivo di controllo deve la sua potenza al fatto di non essere percepito come tale, nella stragrande maggioranza dei casi. Fin qui nulla di nuovo. La novità si palesa quando questo enorme apparato di sorveglianza, questo Panopticon post-moderno, raggiunge dei livelli tali di ingegneria sociale tali da consentirgli non solo di non nascondere più la narrazione cancerogena di cui è foriero, ma addirittura di rivendicarla col nome di progresso. Pensiamo in questo senso a fenomeni di massa in grado creare veri e propri trend culturali, come nel caso della sharing economy.
L’affermazione della precarietà come standard nei contesti lavorativi e sociali ha contribuito a rendere l’odierna economia della condivisione qualcosa di simile ad una bacchetta magica: dove non arriva più il welfare state arriva prontamente il nuovo modello di condivisione rigorosamente Made in U.S.A. Il problema centrale di queste soluzioni apolitiche e a buon mercato è che, benché oggettivamente inserite in un percorso sostanzialmente innovativo, in grado di apportare grandi benefici nel breve termine, sul lungo termine esse rischiano di razionalizzare e giustificare tutte quelle patologie tipiche dell’attuale sistema politico/economico capitalista, presentando quindi determinate scelte obbligate come scelte di vita perfettamente consapevoli, e perché no, anche preferibili. Il punto è che attualmente la maggior parte delle persone non può permettersi alternative e perciò ricorrere allo sharing non per vocazione più o meno etica ma sotto ricatto, obbligata da necessità di cui gli stati sempre meno riescono e vogliono farsi carico.
La melensa retorica dello sharing allontana progressivamente un’intera fascia di popolazione, in particolare i più giovani, dall’analisi politica delle origini dei disastri sociali a cui assistiamo.
«Sensori, smartphone, app: sono questi i tappi per le orecchie della nostra generazione. Il fatto che non riusciamo più ad accorgerci quanto allontanino le nostre vite da qualunque cosa abbia anche solo un sentore di politica è già di per sé un segnale rivelatore: la sordità, all’ingiustizia e alle disuguaglianze, ma soprattutto a quanto sia disperata la nostra stessa condizione, è il prezzo da pagare per questa dose di benessere istantaneo» (Evgeny Morozov, I signori del Silicio).
Perciò, per tutti quei movimenti che intendono configurarsi in opposizione ai processi in atto, l’esigenza prima non può che essere quella di spezzare la narrazione profondamente collaborazionista alla radice dei processi di fidelizzazione fra multinazionali e popolazione. Il lavoro di rottura deve avvenire all’interno della narrazione utopica e cancerogena portata avanti in parallelo dalle compagnie e dalle nazioni che sempre più avallano questo tipo di politiche. Favorire implicitamente una sorta di nuovo luddismo, non può che condurre ad una sconfitta decisiva, da cui sarebbe estremamente difficile riprendersi. La necessità di un approccio diverso si fa più impellente nel momento in cui la narrazione favolistica dell’Hi-tech ha già cominciato a dispiegare i propri effetti all’interno delle infrastrutture di repressione classiche. Eventi come questo dimostrano due cose: primo, che l’apparato di sorveglianza tradizionale non intende rimanere indietro nella corsa al progresso, essendo già pronto ad implementare nuove tecniche a fini repressivo/discriminatori; secondo, che alla lunga questo ottimismo ingiustificato, alimentato dalla malsana idea di un’improbabile neutralità dei dispositivi tecnologici, mostrerà la sua vera natura di menzogna.
Basti pensare al modo in cui termini come Big Pharma, Big Oil e Big Food assumono automaticamente un’accezione negativa e al modo invece totalmente innocuo con cui ci si riferisce ai Big Data. A questo proposito pensare che i dati esulino da questo discorso, che siano in grado di difendersi da soli o peggio ancora che non vi sia la reale necessità di difenderli e rivendicarli, potrebbe rivelarsi l’errore più significativo della nostra epoca. Il compito dunque, per tutte le forze anti-sistemiche con a cuore la tutela di quella enorme parte di mondo che inevitabilmente rimane e rimarrà sempre più esclusa da questi giochi di soldi e potere, è quello di riappropriarsi del valore positivo della narrazione utopica, troppo a lungo abbandonata nelle mani delle nuove oligarchie. Affermare a chiare lettere che parlare di tecnologia oggi, vuol dire fare i conti gli aspetti peggiori dell’ideologia neoliberista: rivendicare quindi un terreno di lotta comune, sui temi della povertà, del reddito, del lavoro e della parità di genere, i quali non possono e non devono essere assolutamente lasciati in mano a qualche start-up uscita dal void neo-liberale.
Saper affrontare quindi queste tematiche praticando una lettura schierata, partigiana e spregiudicata, in grado di accelerare ed evitare in ogni modo possibile, di rimanere indietro nella corsa essenziale all’immaginario politico e sociale.