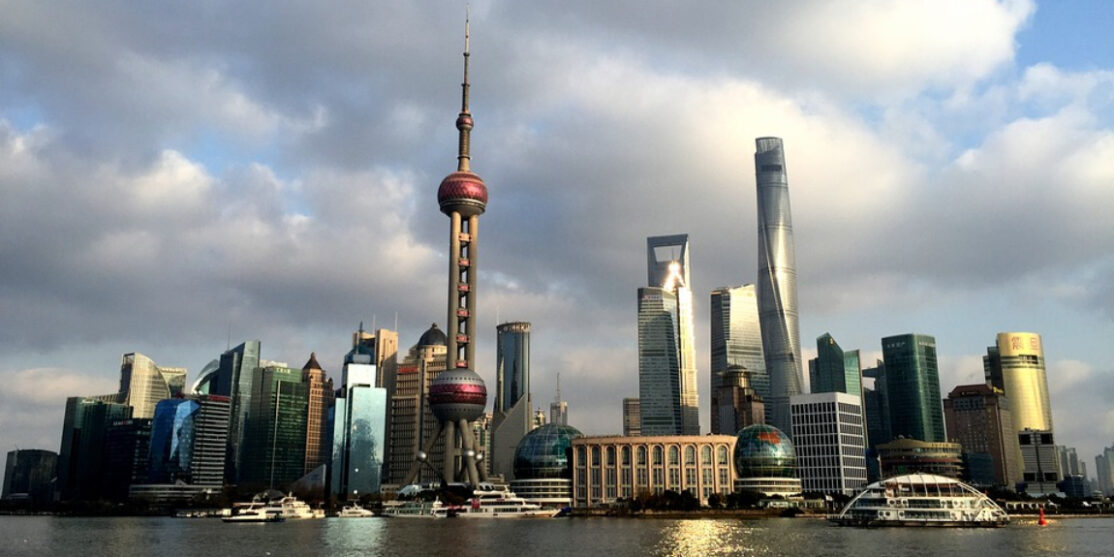ITALIA

Una, nessuna, centomila proposte di Reddito
Cosa si nasconde dietro al dibattito sul Reddito di cittadinanza, cosa propongono realmente i 5 Stelle e di cosa ci sarebbe bisogno
Finalmente, dopo anni in cui il dibattito era relegato a strette cerchie di economisti, sociologi e attivisti, il Reddito di base (o di cittadinanza, o minimo) appare sul palcoscenico della grande politica. Il Movimento 5 Stelle trionfa nell’ultima tornata elettorale e sbandiera nel suo programma, proprio al primo punto, l’introduzione del Reddito di cittadinanza: nei giorni successivi si scatena lo scherno degli avversari politici che accusano l’elettorato 5 Stelle di essere ingenuo, fannullone e di cercare “soldi facili”, senza lavorare. Contestualmente, si moltiplicano le ricerche in rete sul «Reddito di cittadinanza» e molte persone (fake news o verità?) si rivolgono ai CAF per chiedere il Reddito promesso in campagna elettorale. È stato scritto molto sul razzismo malcelato e sul classismo che i maggiori quotidiani nazionali (Repubblica e Corriere della Sera su tutti) stanno esprimendo; in combutta con i maggiori esponenti del PD, che liquidano il fenomeno dei CAF con lo stigma dell’ignoranza e della pigrizia meridionali. Ed è stato scritto (non) abbastanza sull’incapacità della sinistra lavorista di cogliere il cuore del problema, mentre la “classe” che la sinistra vorrebbe rappresentare lo ha colto in maniera assai lungimirante (ma, si sa, la classe è sempre un passo avanti ai suoi presunti rappresentanti).
Qui vorremmo soffermarci su quanto questo dibattito sia assolutamente falsato e su come la proposta dei 5 Stelle sia in perfetta continuità con le politiche neoliberali europee, scopiazzata dai peggiori modelli di workfare (che al welfare sostituiscono l’attivazione dei soggetti poveri, incentivando l’offerta di lavoro a qualsiasi condizione: Inghilterra con una spolveratina di Germania) e, ironia della sorte, tecnicamente e ideologicamente in linea con l’elemosina chiamata ReI (Reddito di Inclusione) che proprio il PD ha varato in campagna elettorale, sperando di recuperare qualche voto.
Partiamo da un enunciato che a nostro avviso chiarisce molte cose e che tenteremo di spiegare: il Reddito (di base) è il futuro del welfare, il workfare invece è il suo presente (di miseria). Redistribuzione della ricchezza; retribuzione di mansioni (relazionali, affettive, cognitive) squisitamente produttive all’interno dell’economia delle piattaforme e dell’automazione (nuova robotica, internet delle cose, ecc.); strumento di opposizione ai ricatti del “lavoro a tutti i costi” e di contrasto alla contrazione salariale; arma in mano ai precari, ai disoccupati e ai working poor per poter rifiutare condizioni inaccettabili e costringere chi si sta arricchendo in questi anni di crisi a smettere di farlo sulle spalle dei lavoratori; riconoscimento, nonché redistribuzione sociale, del lavoro di cura, domestico e riproduttivo (spesso ancora gratuito e a carico delle donne, italiane e straniere; quando retribuito, sottopagato): questo (e non solo) è il Reddito di base. Non si tratta della panacea di tutti i mali, non è il Messia, ma un mezzo, da combinare con altri e con altre battaglie, di cui non si può più fare a meno. Dunque ci domandiamo: la proposta dei 5 stelle risponde a queste esigenze?
Leggendo gli “auspici” dell’articolato normativo, sembrerebbe di sì: «E’ necessario ridisegnare il nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro […] porre la questione centrale: che cosa sono oggi i diritti sociali? Il livello ideale, futuro e auspicabile è il Reddito di cittadinanza universale, individuale e incondizionato […] il fine del presente disegno di legge è quello di raggiungere un primo livello non ancora ideale». E ancora «lavorare non per l’indice di produttività ma per il benessere e per vivere una vita dignitosa e felice». Come si articola effettivamente, però, questa proposta?
Viene prevista l’erogazione di una somma di denaro utile a raggiungere la soglia della povertà relativa (780 euro mensili) in cambio di una serie di assolvimenti: bisogna iscriversi ai centri per l’impiego e iniziare un percorso di inserimento entro una settimana; è obbligatorio prestare 4 ore settimanali di lavoro volontario (?) in favore dei comuni di residenza, andando così a sostituire prestazioni di lavoro da retribuire (e fungendo quindi da meccanismo di ulteriore contrazione dei salari); dimostrare di cercare attivamente lavoro per almeno 2 ore al giorno (non si capisce bene con quali modalità bisognerà certificare la ricerca) e presentarsi almeno una volta a settimana presso i centri per l’impiego, anche senza nessun motivo o senza alcuna convocazione, pena l’esclusione dall’erogazione del Reddito. Proprio come il ReI del Partito Democratico, i poveri e i percettori vengono trattati come soggetti tendenzialmente inclini al parassitismo, da controllare e da «attivare». Il lavoro volontario poi è uno dei modi migliori per utilizzare forza-lavoro gratuita in quei settori in cui i tagli alla spesa pubblica stanno mettendo in crisi l’erogazione dei servizi (basti pensare alla cultura, al terzo settore, alla manutenzione degli spazi urbani, ecc.). Sarà possibile, secondo questa proposta, rifiutare un massimo di 3 lavori ritenuti congrui (a insindacabile giudizio degli operatori dei centri per l’impiego): la congruità è stabilita rispetto al percorso formativo, alle inclinazioni che emergono dai colloqui (?), alla retribuzione che deve essere pari o superiore all’80% della retribuzione del precedente lavoro e ai chilometri tra il luogo di residenza e il lavoro, che non devono essere più di 55. Questo vale esclusivamente per il primo anno. Dopo un anno, infatti, si sarà costretti ad accettare qualsiasi impiego, per qualsiasi salario, in una qualsiasi città del territorio nazionale, essendo immaginato l’incrocio tra domanda e offerta su base nazionale. In caso contrario non si avrà più diritto a nulla.
In una situazione come quella dell’odierno mercato del lavoro, che impatto potrebbe avere una massa di percettori di Reddito di cittadinanza che dopo un anno sono costretti ad accettare qualsiasi lavoro per non perdere l’erogazione (del Reddito)? Può in qualche modo essere, il Reddito dei 5 Stelle, una misura in grado di liberare dalla povertà e dal ricatto dello sfruttamento? Si tratta, dunque, di uno strumento di liberazione e autodeterminazione? No. Al contrario, si inserisce all’interno della peggiore cultura workfaristica che qualifica la povertà come una colpa e i poveri come soggetti da controllare, disciplinare e costringere al lavoro, a tutti i costi. Fa sorridere come i maggiori detrattori della proposta 5 Stelle, se non fosse per lo scontro politico-elettorale, nella sostanza sarebbero entusiasti di questa misura liberista assai feroce; invece, si affrettano a contrapporre il «lavoro di cittadinanza» (sic) al welfare universale. E in questa situazione, i movimenti che da anni si battono per il Reddito di base?
Lo spazio – sindacale, politico, del conflitto – che si apre è immenso e, come diciamo da tempo, il Reddito di base può essere, oltretutto, un terreno di ricomposizione di tutte le figure del lavoro – retribuito e non – che non conoscono tutele e non riescono a uscire dalla spirale del lavoro povero e dello sfruttamento. Il successo enorme avuto dai 5 Stelle, soprattutto tra precari e disoccupati, testimonia quanto sia chiaro a tutti che la dignità è questione di possibilità di scelta, di poter vivere liberi dai meccanismi di coazione al lavoro a mezzo povertà; la sinistra (di ogni tipo) ha preferito la rassicurante cantilena del “lavoro che restituisce dignità alle persone”, senza interrogarsi su che tipo di lavoro viene offerto oggi.
Reddito di base come futuro del welfare, dicevamo: un reddito incondizionato, da erogare a italiani e stranieri (per rompere una segmentazione utile solo a chi sfrutta manodopera ricattabile a causa del legame tra contratti e permesso di soggiorno), un Reddito che permetta sul serio di autodeterminarsi (così come chiede a gran voce il movimento Non Una Di Meno, facendo emergere in primo piano il carattere non meramente economicista della rivendicazione) e di retribuire tutte le attività produttive e riproduttive – nella loro inedita combinazione e coincidenza – che quotidianamente svolgiamo e non vengono riconosciute.
Non basterebbe, ovviamente: bisognerebbe proseguire rivendicando un salario minimo (almeno) europeo (per fare in pezzi il dumping salariale che la vertenza ultima di Embraco non fa altro che ribadire), rifinanziando e riqualificando Sanità e Istruzione pubblica, imponendo una fiscalità radicalmente progressiva (altro che flat tax!). Ma sarebbe sicuramente un inizio. Un campo di battaglia all’interno del quale far riconoscere disoccupati e precari di tutte le età e generi (l’ISTAT lo ripete con ogni rilevazione trimestrale: la povertà è in prevalenza donna!), e rendere chiari alcuni concetti fondamentali: la povertà non è una colpa e i poveri non sono parassiti. Il fatto che negli ultimi dieci anni sia aumentata la polarizzazione della ricchezza sta a testimoniare il contrario: parassita è quell’1% che detiene quasi il 25% delle ricchezze del paese; i colpevoli quelli che si arricchiscono mentre tutti gli altri non arrivano a fine mese. Mai come in questi giorni un vecchio slogan dei movimenti andrebbe rispolverato, perché in grado di fotografare la realtà meglio di mille parole…
O la ricchezza è per tutti o lavorare non ha senso.