cult

CULT
Il neoliberismo tra depoliticizzazione ed expertise
Se la pandemia sembra aver reso evidenti i disastri prodotti dal neoliberismo, il suo spettro continua ad aggirarsi tra le nostre vite. Tre libri usciti recentemente, “Neoliberismo. Teorie e problemi” di Giulio Moini, “Esperti. Come studiarli e perché” di Davide Caselli e “Understanding Politics and Society” di Fabio De Nardis, ci aiutano a entrare nella logica neoliberista e a disfarcene
Nell’aprile del 2013 ero in Inghilterra perché invitata a relazionare sul femminismo italiano ad un convegno interdisciplinare dal titolo “Remembering the impossible tomorrow. Italian political thought and the recent crisis in capitalism” organizzato da alcuni colleghi inglesi presso il St Hilda’s College di Oxford. Finito il convegno decisi di andare a Londra per restarvi una settimana. L’8 aprile c’era uno strano sole per il clima solito della città. Mentre camminavo e fotografavo alleggerita dal peso del convegno cominciai a vedere gruppi cospicui di persone che sbucavano da tutte le strade stappando bottiglie in allegria. In prima battuta pensai che fosse una manifestazione della working class, invece era solo una festa spontanea di ex minatori, studenti, operai, donne, famiglie intere con bambini che esultavano accompagnati dallo slogan: “Maggie, Maggie, Maggie! Dead, dead, dead!” Margaret Thatcher, il primo ministro inglese dal 1979 al 1990 che amava definirsi al maschile, era morta proprio quella mattina. Sentendomi improvvisamente parte di un grande evento mi recai presso la sua abitazione privata e poi anche presso il n. 10 di Downing Street dove risiedeva l’allora primo ministro Cameron per capire e curiosare. Niente, non c’era niente. Solo transenne protettive, molta polizia e un silenzio tombale. Alla lady di ferro nessuno portava un fiore, un saluto, come di solito si fa quando muoiono i grandi protagonisti della storia. Al contrario, tutta la città festeggiava la sua morte proprio come in quei rituali collettivi e catartici attraverso cui ci si redime simbolicamente per rimuovere la catastrofe, una liberazione. Questa morte festeggiata dal popolo inglese, questo fortissimo simbolico dimenticato presto da tutti i media e dai dirigenti politici, non è solo il racconto di un episodio esperienziale, men che meno uno di quei noiosissimi aneddoti con cui spesso si intrattengono gli accademici old school durante le loro prolusioni, bensì un semplice fatto sociale reale, materiale, che ci fornisce qualche indicazione di massima: i grandi processi storici che mirano a trasformare radicalmente gli assetti della politica, dell’economia e della società, come il neoliberismo thatcheriano, non si comprendono solo mentre si dispiegano, ma vanno verificati anche e soprattutto a partire dalle rovine, dagli spettri e dai disastri che lasciano.

Con questo spirito Giulio Moini, nel suo volume Neoliberismo. Teorie e problemi, appena edito da Mondadori Università nella collana Lessico democratico diretta da Manuel Anselmi (pp. 185, euro 14) prova a tracciare sia i fili della storia politica incarnata dal neoliberismo (Thatcherismo, Reaganismo, il Cile di Pinochet e dei Chicago Boys), sia le trame concettuali (a partire dai lavori canonici di Friedman, von Mises e von Hayeck), nonché la costellazione degli effetti profondi, trasformativi, istituzionali, tanto quanto sociologici e antropologici di diretta derivazione neoliberista. Cambiamenti effettivamente avvenuti e ancora esaltati dagli stregoni dell’innovazione, nonostante la verità sia un’altra: il neoliberismo ci lascia in destino una scia infinita di scorie e macerie che, oltre a rovesciarne l’intento originario – segnato da una sorta di fideismo utopistico nei confronti del mercato, della libertà individuale e d’impresa i quali avrebbero dovuto magicamente trasformare il pianeta nella terra di Bengodi – ha finito con il generare una concatenazione di rovesci paradossali. I rovesci, come ci dimostra Moini, peraltro oggi acuiti anche dalla pandemia, sono ormai sotto gli occhi di tutti e vanno dal ritorno degli autoritarismi ai “populismi senza popolo”, oserei dire (si pensi al primo Boris Johnson, ad Orbán in Ungheria o alla Polonia, al successo di Marine Le Pen, a Erdoğan, a Bolsonaro o ai nostrani Salvini e Meloni, a Trump e al trumpismo negli Usa); dai processi di scomposizione sociale al culto del prestazionalismo e del performativismo, nonché di un’agency sempre più determinata dall’individualismo competitivo e dal “dover essere”; dall’acuirsi delle forme di controllo sociale basate sull’ossessione per la valutazione e la conformità agli “standard” della produzione e dell’estrazione del valore – al punto da trasformare l’umano stesso, la sua psiche, in una merce – sino ai nuovi assetti di potere determinati dagli oligopoli del capitalismo finanziario e dal capitalismo delle piattaforme, per finire con la crisi del welfare e l’aumento esponenziale delle diseguaglianze sociali.
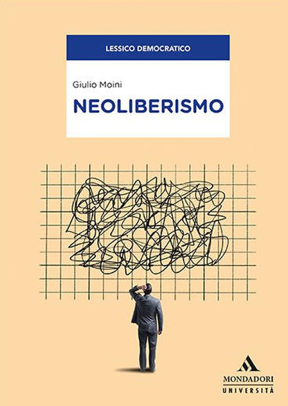
A fronte di una costellazione ormai cospicua di testi che criticano il neoliberismo, girando spesso intorno al sintomo, il volume di Moini ha il grande pregio di spiegarci bene cosa è e come si è dispiegata questa ideologia nel corso del Novecento, sino a divenire un vero e proprio modello dominante dagli anni ’90 in poi, soffermandosi soprattutto sugli effetti che ha avuto sulle trasformazioni della forma Stato e dell’azione pubblica più in generale. Non è un caso, ad esempio, che i fautori del modello neoliberista sostengano la tesi secondo cui le sinistre criticano un modello che non c’è mai davvero stato, ignorando quasi del tutto gli studi sull’impatto che esso ha avuto nell’azione pubblica e nella società. Se è vero, infatti, che l’utopia del libero mercato non è mai riuscita a liberare e a liberalizzare veramente tutto come avrebbero voluto originariamente i suoi sostenitori, è altrettanto vero che questa ideologia ha finito con il generare dei veri e propri rovesci di quell’idea di libertà finendo con l’imbrigliare, attraverso una moltitudine di regole burocratiche, di indicatori e standardizzazioni, quello stesso libero mercato ormai insinuatosi, come un virus, in ogni anfratto dell’ esistenza sociale e individuale.
Per citare Moini, infatti, potremmo dire che la neoliberalizzazione debba essere intesa «come un processo di progressiva istituzionalizzazione del neoliberismo» , una sorta di «tessuto connettivo delle moderne società capitalistiche».
Il neoliberismo, in sintesi, da pensiero anti-Stato non ha fatto altro che divenire esso stesso la nuova “forma Stato” attraverso una sorta di perenne “mercatizzazione” dell’azione pubblica e istituzionale con evidenti rovesci paradossali di de-democratizzazione da un lato e di iper-regolamentazione burocratica dall’altro. Un’altra trama molto interessante e per certi versi anche nuova che questo libro ha il coraggio di far emergere è il ruolo svolto dalla famosa “terza via” di Giddens e dalle politiche di Tony Blair, tradotte in Italia dall’Ulivo intorno agli anni ‘90. Per Moini, queste politiche che inizialmente si presentavano come anti-Thatcher, di fatto hanno solo generato una sorta di ratificazione in salsa soft del grande cambiamento di scala già avvenuto con la lady di ferro. Nessun vero cambiamento, quindi. Solo l’avvio di un regime misto che avrebbe voluto liberalizzare e redistribuire insieme mantenendo un piano di azione politica già profondamente orientata dalla logica delle privatizzazioni e dalla progressiva de-statalizzazione e privatizzazione del welfare. Un innesto micidiale tra pubblico e privato divenuto egemonico, ma fallito dopo poco, stando ai dati sulle nuove povertà e sulle diseguaglianze. Una specie di modello “rattoppante” che ora, dopo un trentennio, tenta di ripercorrere anche Biden negli Usa.
 Ma il neoliberismo non è solo questo, ormai è anche una “costellazione egemonica a geometria variabile” animata da nuovi professionisti e agenti del mercato che rispondono pienamente al culto delle competenze: expertise, opinion makers, manager, stakeholders, couch che ormai agiscono su scala transnazionale coniando, a loro modo, anche una neolingua. Questi attori della governance neoliberista gestiscono grandi e piccoli fatti sociali sostituendosi progressivamente all’alfabeto dei diritti. A studiarli di recente è stato Davide Caselli in un bel volume dal titolo “Esperti. Come studiarli e perché” (Il Mulino, pp. 207, euro 20). Attraverso un interessante innesto teorico che tiene assieme Foucault, Bourdieu e Gramsci, nonché attraverso una ricerca empirica basata su interviste, osservazione partecipante e analisi dei testi, Caselli entra nelle maglie delle politiche sociali e nel gioco di rimandi del rapporto tra pubblico e privato restituendoci un quadro molto interessante, oltre che preoccupante.
Ma il neoliberismo non è solo questo, ormai è anche una “costellazione egemonica a geometria variabile” animata da nuovi professionisti e agenti del mercato che rispondono pienamente al culto delle competenze: expertise, opinion makers, manager, stakeholders, couch che ormai agiscono su scala transnazionale coniando, a loro modo, anche una neolingua. Questi attori della governance neoliberista gestiscono grandi e piccoli fatti sociali sostituendosi progressivamente all’alfabeto dei diritti. A studiarli di recente è stato Davide Caselli in un bel volume dal titolo “Esperti. Come studiarli e perché” (Il Mulino, pp. 207, euro 20). Attraverso un interessante innesto teorico che tiene assieme Foucault, Bourdieu e Gramsci, nonché attraverso una ricerca empirica basata su interviste, osservazione partecipante e analisi dei testi, Caselli entra nelle maglie delle politiche sociali e nel gioco di rimandi del rapporto tra pubblico e privato restituendoci un quadro molto interessante, oltre che preoccupante.
L’expertise, infatti, si pone come un freddo “sapere-potere” che mira a gestire il disagio sociale e le asimmetrie di posizione basandosi su almeno tre modalità di azione pubblica e sociale: la dipendenza nei suoi confronti; la sollecitazione al “dover essere”; l’oggettivazione.
Il tutto in un quadro in cui se spariscono i diritti sociali, sparisce anche la dignità degli attori coinvolti trasformando questi ultimi in “vittime” e “bisognosi”, “soggettività assoggettate”, per dirla con Foucault. Il welfare come impresa, l’intreccio tra la dimensione cognitiva e normativa dell’expertise genera, in sintesi, una modalità dell’azione sociale basata solo sulla “competenza”, sull’“empowrement” e sul risk management per estrarre valore dal disagio sociale bypassando completamente la necessità di ripensare alla base la relazione, il legame sociale, il conflitto, i diritti sociali. Eppure, come ci ricorda Caselli, il nostro paese grazie all’esperienza delle “150 ore” e al laboratorio politico costruito da Franco Basaglia tra gli anni ’70 e ’80, disporrebbe già di saperi in grado di ripensare le questioni sociali attraverso il conflitto e la riappropriazione, anche istituzionale. Infine, questo proliferare di esperti ci indica anche un altro trend preoccupante ovvero la trasformazione reticolare e onnipervasiva di una “gestione del sociale” che tende a de-politicizzare e ad azzerare il conflitto attraverso il mantra di un nuovo sol dell’avvenire: la “coesione sociale” intesa più che altro solo come dipendenza e obbedienza.
La de-politicizzazione e la de-ideologizzazione dell’azione pubblica e degli attori sociali, come diretta conseguenza del neoliberismo è anche una traccia, tra molte altre, che percorre Fabio De Nardis nel suo completo e utilissimo volume uscito da poco per Palgrave Understanding Politics and Society (pp. 475, euro 44). Se Moini traccia il frame generale nel quale siamo, se Caselli si sofferma sui suoi “professionisti”, De Nardis ci conduce più sugli effetti e le asimmetrie della distorsione neoliberista che ha subito il sistema politico o, se vogliamo usare una vecchia espressione, l’autonomia del politico, nonché il rapporto storicamente costitutivo (e ora asimmetrico) tra politica e società. Anche qui la metodologia di analisi si avvale di una prospettiva storico-sociologica che ripercorre le origini del pensiero moderno attraverso i classici – da Tocqueville a Marx, dalla prospettiva del materialismo storico a Durkheim sino a Weber e altri – ma certamente non sottovaluta le nuove variabili con cui leggere e interpretare questo presente così asimmetrico, come il ruolo svolto dalla psicopolitica, dall’antropologia, dalla geografia, specie per leggere i tantissimi fenomeni, ad oggi purtroppo ancora sparigliati, di ri-politicizzazione dal basso. Se lungo tutto l’arco del ‘900 la partecipazione politica era determinata dal ruolo dei partiti politici, dai movimenti sociali e dalle altre istituzioni intermedie, primi tra tutti i sindacati, oggi ci si ritrova a dover comprendere una scomposizione sociale che tenta sicuramente di ricomporsi, ma non più attraverso il solo filtro dello status di lavoratore, bensì attraverso altri posizionamenti micro come la cittadinanza, la difesa del territorio dalla speculazione delle grandi opere ecc. Il tutto in un quadro complessivo che ha radicalmente mutato il ruolo e il rapporto tra gli Stati, in uno scenario in cui la violenza politica, la guerra, i neo-terrorismi internazionali sembrano determinare sempre più una sorta di normalizzazione delle politiche emergenziali.
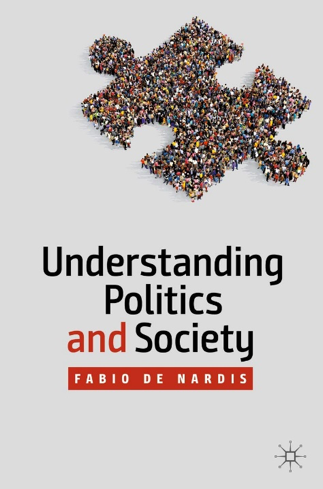 Per anni ci hanno detto che alla base dei populismi contemporanei c’era solo la crisi della rappresentanza, in realtà i dati elettorali non sembrano avallare questa ipotesi, semmai il vero dramma è un altro ed è, appunto, ciò che De Nardis chiama “crisi della politica”, specie quando, cedendo troppo alla società post-ideologica e post-moderna nella quale siamo, essa finisce con lo sterminare i suoi stessi nuovi germi conflittuali piegandoli agli standard della de-materializzazione governata dal capitalismo delle piattaforme o dal tempo accelerato della rete che certamente connette, ma non sedimenta mai niente. Molto dense e fitte, nonché attraversate da una cospicua letteratura internazionale, anche le pagine in cui l’autore ricostruisce la variegata geografia dei movimenti sociali, già suo oggetto/soggetto di studio negli anni passati, le loro “forme” di lotta, la centralità dei linguaggi e delle emozioni, potenti connettori di socializzazione sensata, nonché il rapporto –spesso assai problematico – tra politica e media, tra politica e canali di comunicazione, così come tra politica e cultura.
Per anni ci hanno detto che alla base dei populismi contemporanei c’era solo la crisi della rappresentanza, in realtà i dati elettorali non sembrano avallare questa ipotesi, semmai il vero dramma è un altro ed è, appunto, ciò che De Nardis chiama “crisi della politica”, specie quando, cedendo troppo alla società post-ideologica e post-moderna nella quale siamo, essa finisce con lo sterminare i suoi stessi nuovi germi conflittuali piegandoli agli standard della de-materializzazione governata dal capitalismo delle piattaforme o dal tempo accelerato della rete che certamente connette, ma non sedimenta mai niente. Molto dense e fitte, nonché attraversate da una cospicua letteratura internazionale, anche le pagine in cui l’autore ricostruisce la variegata geografia dei movimenti sociali, già suo oggetto/soggetto di studio negli anni passati, le loro “forme” di lotta, la centralità dei linguaggi e delle emozioni, potenti connettori di socializzazione sensata, nonché il rapporto –spesso assai problematico – tra politica e media, tra politica e canali di comunicazione, così come tra politica e cultura.
È vero, oggi scontiamo una deculturazione politica di massa avallata dalla grande trasformazione antropologica cominciata con il berlusconismo e infine consolidatasi attraverso il Movimento 5 stelle e i processi di digitalizzazione, però questo libro sembra anche indicarci più vie per non cedere allo sconforto: intanto l’importanza che può avere nuovamente oggi l’organizzazione, ovvero la necessità di connettere tutte le micro-politiche di resistenza e di lotta alla governance neoliberista; in secondo luogo una rimessa in discussione radicale del rapporto tra legalità/illegalità e legittimazione in merito alla necessità impellente di re-immaginare nuovi diritti e nuove forme di redistribuzione in grado di ridurre l’asimmetria della forbice delle diseguaglianze sociali; infine, il bisogno di favorire nuove forme di istituzionalismo in grado di stare nella società per riconnettersi ad essa.
Non si tratta, evidentemente, di cancellare il presente per tornare nostalgicamente al passato, ma di generare una nuova discontinuità politica che entri nelle crepe e nei paradossi della storia e del neoliberismo per fecondare una nuova contro-egemonia.
Se sino a qualche anno fa i protagonisti del decostruzionismo e della post-modernità facevano circolare volumi sugli “spettri” o sul “fantasma” di Marx per disfarsene, la pandemia ci fornisce l’occasione di dimostrare empiricamente la nefandezza degli spettri del neoliberismo. Ora è tutto più visibile e chiaro, come sempre accade quando si vive un lutto, una perdita o un grande trauma, ma questo persistere collettivo nella morte e nella malattia può anche tornare ad essere una festa, magari accompagnata dal canto della working class inglese: “Maggie, Maggie, Maggie! Dead, dead, dead!” o dallo slogan “Remembering the possible tomorrow”.
Foto di copertina di Gwydion M Williams via Flickr
