cult

CULT
Neoliberismo dal basso ed economie popolari: intervista a Verónica Gago
In questa intervista Verónica Gago affronta alcune delle questioni del libro Neoliberismo dal basso (Tamu Edizioni), alla luce della fase di crisi latinoamericana, interrogando le trasformazioni del lavoro, delle soggettività popolari e dei conflitti sociali
Tradotto finalmente in Italia il libro Neoliberismo dal basso di Verónica Gago, pubblicato da Tamu Edizioni, con una presentazione di Sandro Mezzadra e la traduzione di Laura Abbruzzese e Sara Senese. Dalla quarta di copertina del libro: “Una “globalizzazione dal basso” mette a valore la comunità – la cura nello spazio domestico, lo scambio di saperi e favori che occorrono per portare le traiettorie di migrazione al successo. Attraverso la “disputa tra obbedienza e autonomia” non solo le città cambiano forma, ma anche le tattiche di conquista di diritti e l’azione nello spazio pubblico. Verónica Gago indaga le trasformazioni del lavoro e della produzione – come nota Sandro Mezzadra – creando sorprendenti «effetti di risonanza con le condizioni prevalenti in altre regioni del mondo, e in particolare nei paesi mediterranei dell’Europa».
Partiamo dal titolo, può essere il neoliberismo la chiave economica di una dominazione sociopolitica globale? Può essere visto e concepito dal basso?
Neoliberismo è una parola che può sembrare logora e abusata. Questo non credo abbia a che vedere con il fatto di essere stato parte di una certa moda teorica né che venga utilizzato nel discorso comune per parlare di un’epoca che si vorrebbe mettere da parte. E perché il neoliberismo, in quanto regime globale, sembra estendersi, modellarsi e modificarsi senza sosta. Quindi tutto quel che accade ha a che vedere con il neoliberismo?
Forse dovremmo riformulare la domanda: come fa il neoliberismo – come dice Wendy Brown – a essere un Frankenstein o come segnala William Callison, divenire “mutante”? Ci si ripropone una domanda storica nell’analisi del capitale: come riesce a subordinare e sussumere ciò che gli si oppone, che emerge come antagonismo? La mia prospettiva si basa su due approcci: da una parte, fare una lettura della razionalità neoliberista che Michel Foucault ha concettualizzato, ma lo ha fatto con una visione euro-atlantica. Io credo che l’America Latina sia il luogo del “neoliberismo originario”, per dirla in una cerca maniera. Contrappunto provocatorio con le letture che cercano la sua origine in termini dottrinari e istituzionali in Europa e negli Stati Uniti d’America.
Il neoliberismo come regime violento situa nei nostri paesi latinoamericani il suo scenario primordiale in quanto imposizione. Voglio situare il neoliberismo per non pensare al nostro continente come “caso” o “luogo d’applicazione”, ma come momento storico che porta alla definizione storica del neoliberalismo associato alle dittature e alle forme di repressione statale e para-statale delle lotte popolari e dei movimenti rivoluzionari armati.
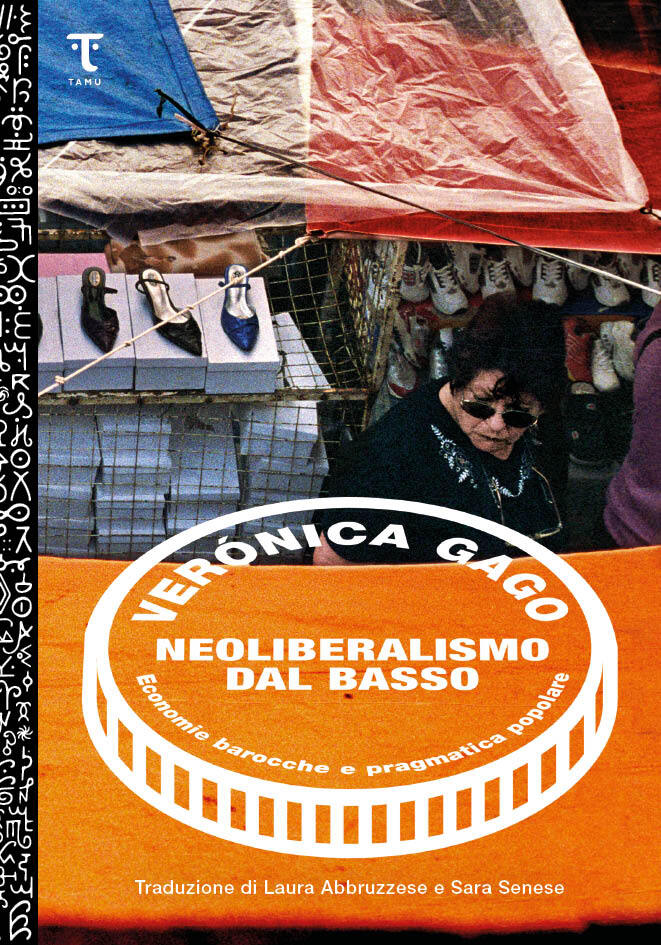
Da questo punto di vista, il neoliberismo non è solo uno strumento di pacificazione, né un dispositivo comprensibile sono in seguito alle sconfitte politiche delle soggettività rivoluzionarie. Poi, cerco di capire come alcuni settori siano stati effettivamente costretti a fare politica, a lavorare e a prosperare all’interno di questa razionalità, e mi riferisco agli anni ’90 e all’inizio di questo secolo. Per questo cerco di evitare di parlare del neoliberismo come della totalizzazione vittoriosa del capitalismo, come fosse l’annullamento soggettivo definitivo con cui ne abbiamo introiettato le premesse.
Sono questi stessi settori più precari, composti principalmente da lavoratori informali, migranti e fortemente femminilizzati, a confrontarsi con la logica dell’austerità neoliberale. In questo senso, ho lavorato con la nozione di “neoliberismo dal basso” per spiegare come il terreno della riproduzione sociale sia stato un luogo espropriato dalle politiche di aggiustamento strutturale degli anni ’90 e allo stesso tempo reinventato dalle infrastrutture popolari e dalle lotte comunitarie che lo hanno negoziato, contestato e affrontato. Questo apre a esperienze che sfidano e sfuggono alla distribuzione delle soggettivazioni consentita dal neoliberismo, secondo il binarismo per cui o si è vittime o si è imprenditori di se stessi.
C’era un’economia popolare prima della crisi del 2001? Come è cambiata da allora?
Innanzitutto, è necessario collocare le economie popolari all’interno della questione generale delle forme assunte dal lavoro di una maggioranza crescente della popolazione che non rientra nelle modalità del lavoro salariato stabile e formale. Possiamo dire che questa è una realtà storica del Terzo Mondo, che non è necessariamente una novità. Tuttavia, la specificità delle economie popolari di cui mi occupo in questo libro si colloca in un arco temporale che è quello del neoliberismo contemporaneo. Non è una storia lineare.
In generale, le economie popolari si confrontano con le forme di esclusione dei mezzi e delle risorse di gran parte della popolazione per garantirne la riproduzione. In Argentina, ciò assume due caratteristiche particolari, poiché la costituzione politica di questo soggetto proletario che popola le economie popolari e si organizza al di fuori delle coordinate tradizionali del movimento operaio, emerge pubblicamente e con forza con la crisi del 2001. Da un lato, ciò implica la connessione delle economie popolari con un momento di crisi di legittimità del neoliberismo, raggiunto dalla mobilitazione collettiva contro i mandati dell’austerità e la sua traduzione in impoverimento e precarietà. Dall’altro lato, evidenzia l’emergere di movimenti che hanno fatto della disoccupazione il loro segno distintivo di identità e di lotta, spingendo il dibattito sul lavoro verso nuovi orizzonti.
Questi movimenti hanno dimostrato la natura politica dei lavori territoriali, di vicinato e cooperativi nella produzione di un valore comunitario capace di organizzare risorse, esperienze e richieste che hanno sfidato di fatto la categorizzazione politica di “esclusione”. Così facendo le pratiche riproduttive hanno sconfinato, andando più in là del nucleo sociale inteso come sfera “privata”. Ciò che inizia con le dinamiche del movimento sociale e poi si stabilizza sotto il nome di economie popolari non è a priori una modalità di gestione della povertà o un dispositivo di pacificazione. Questo legame con il conflitto fin dalle sue origini non è quindi secondario, poiché qualifica politicamente la visibilità di queste esperienze, il loro spessore storico. Insisto e riassumo: ciò che si consoliderà, dopo la crisi di inizio secolo in Argentina, come economia popolare riesce a combinare una serie di saperi e di modi di fare che permettono la riproduzione sociale in territori fortemente segnati dall’espropriazione neoliberale e, allo stesso tempo, reinventa e connette le forme di conflitto e la capacità concreta di guadagnarsi da vivere, riformulando in una certa misura la questione operaia, le dinamiche del lavoro e anche i territori e i compiti storicamente considerati non produttivi.
L’economia popolare può diventare un elemento di costruzione di comunità che rompono gli schemi patriarcali, razziali e coloniali?
Le economie popolari collegano, a partire dalla dinamica stessa della crisi, le ribellioni dei movimenti sociali con la questione operaia, smantellando la divisione tra le pratiche di azione e rivendicazione che dagli anni ’80 classificava in modo diverso queste strade: i movimenti sociali – compresi quelli contadini e indigeni – da una parte, il movimento dei/delle/ lavoratori/lavoratrici/ dall’altra. Questo non vuole essere un racconto romantico o di una soggettività combattiva alternativa.
Questa enfasi sulla chiave del conflitto non è sempre esplicita nel tempo, non adotta necessariamente grammatiche permanentemente riconoscibili. Inventare modalità di produzione e di circolazione che prevedono la gestione di sussidi statali, la ricostruzione di imprese produttive, mettere assieme dinamiche autogestite con forme di imprenditorialità popolare, intersecare traiettorie migratorie con modalità di commercio solidale, così come adattarsi a modalità di inserimento lavorativo discontinuo in settori preesistenti ma sottoposti a processi di forte transnazionalizzazione e informalizzazione (ad esempio, il settore tessile), organizzando forme eterogenee di contestazione, negoziazione, sfruttamento, cooperazione e lotta.
Può indubbiamente “disilludere” chi cerca soggetti puri e continuamente radicalizzati. Per me è uno spazio politicamente produttivo. Ad esempio, in tempi recenti, grazie al movimento femminista di massa in Argentina, sono emerse delle ridefinizioni sostanziali nelle economie popolari. Le spazialità lavorative della riproduzione sociale, dell’assistenza, della cura, dell’educazione, della gestione dell’ambiente e della violenza nelle case e nei territori delle comunità e dei quartieri sono diventate politicamente visibili come forme di lavoro che emergono nelle rappresentazioni politiche delle economie popolari.
Si può ritrovare l’esempio argentino anche altrove?
Credo sia necessario sottolineare che queste economie non sono marginali né riducibili ai confini nazionali. Sia per la loro crescente estensione territoriale sia per la loro capacità di articolarsi su più scale. Tanto per il loro dinamismo politico come per la loro capacità di sollecitare l’immaginario pubblico, sia per i numeri che sempre più spesso cercano di monitorare e misurare l’impatto dei lavori e della composizione del lavoro di chi li svolge, è chiaro che si tratta di un fenomeno di maggioranze. Soprattutto per la sua persistenza nel tempo e per il suo modo di creare infrastrutture popolari in contesti difficili, dove la pandemia è stata un enorme acceleratore della capacità di risposta, vediamo affermarsi la sua «centralità periferica», per usare la formula di Julián D’Angiolillo.
E questo non è certo qualcosa che accade solo in Argentina: è sempre più difficile pensare alle società e alle economie latinoamericane senza considerare questi settori popolari, le loro organizzazioni e i loro modi di operare e di confrontarsi con il mercato. Si tratta di una cartografia regionale che si collega ai dibattiti storici sul popolare e sul subalterno, sulla classe, sulla razza e sul genere, nell’Abya Yala o Amefrica ladina, come la femminista nera Leila Gonzalez ha chiamato questa geografia.
Immagine di copertina di Gastón Bejas
