cult

CULT
“Milkman”: grammatica della violenza
“Milkman” di Anna Burns (trad. it. di Elvira Grassi, Keller) ambientato nella Belfast degli anni ’70 è una storia sul conflitto tra cattolici e protestanti, irlandesi e inglesi, ma anche la storia della violenza maschile su una donna a cui tutta a comunità prende parte. Un grande romanzo sul rapporto tra violenza e linguaggio, che indirettamente ci interroga anche sul presente
Milkman è il romanzo di una scrittrice irlandese, Anna Burns, che si svolge in un imprecisato luogo e tempo facilmente identificabili con la Belfast degli anni ’70, il periodo dei Troubles. Vincitore del prestigioso Man Booker Prize nel 2018, è uscito in Italia per Keller nella bellissima traduzione di Elvira Grassi. La protagonista è una ragazza di diciotto anni che percorre le strade di questa città leggendo libri del Diciannovesimo secolo, perché «il Ventesimo secolo non mi piace». Questo camminare-leggendo desta sospetto, non è considerato normale, in un posto che di normale ha solo la violenza. Il conflitto tra cattolici e protestanti, tra irlandesi e inglesi, è pervasivo, opprimente, monotono e normale. Le strade formano un reticolato regolare e grigio, la geometria è netta e camminare in una città divisa è un esercizio meccanico, non serve guardare ma solo conoscere il tracciato a memoria – sbagliare di una strada può significare capitare nel distretto sbagliato. L’effetto di un conflitto permanente, dei suoi codici – maschili, virili, militari – è l’estraniazione: la violenza impone un ordine che è alienante, non tanto impersonale quanto spersonalizzante. Le strade non hanno nomi e neanche le persone – in Irlanda e in Inghilterra ancora oggi il nome di una persona tradisce il luogo, la religione e la classe sociale di provenienza. I personaggi che popolano il romanzo sono Sorella di mezzo (la protagonista), Sorella numero uno, Cognato numero tre, Qualcuno McQualcuno, forse-fidanzato e via dicendo. Poi ci sono i difensori-dello-stato e i rinnegatori-dello-stato, ci sono “noi” e “loro”. Infine c’è il Lattaio, Milkman, che non è un lattaio ma un paramilitare, un uomo di quarantun anni, sposato, ossessionato da Sorella di mezzo. La segue per strada, la bracca, insiste per farla salire in macchina, tanto che si sparge la voce che tra i due ci sia una relazione. Alla violenza delle bombe e delle retate da parte dell’esercito si aggiunge la violenza maschile che fa il paio la cultura del sospetto, del pettegolezzo, della morale, della convenzione – la stessa madre della protagonista, che la vorrebbe vedere sposata, accusa la figlia di una relazione che non esiste, di essere connivente di quello che invece subisce.
La ricezione da parte della stampa e dei critici è stata quasi unanimemente entusiasta, declinata sull’”attualità”: i due temi più menzionati sono il #Metoo e la questione irlandese, al centro del romanzo. Uno presente, l’altro rimosso, almeno nell’Inghilterra della Brexit – e che spiega, in parte, il premio, nella misura in cui in ambito letterario l’assegnazione di grandi premi sembra spesso seguire una logica riparatoria. Del #Metoo ha parlato un membro della commissione del Booker Prize, lo stesso che però ha definito il romanzo «difficile», sperimentale e ha aggiunto che oggi «molte persone si avvicinano ai romanzi attraverso gli audiolibri». Commento strano, per un romanzo da molti ritenuto essere non affatto sperimentale – cosa dire allora di romanzi marcatamente sperimentali, come Lincoln in the Bardo, vincitore dell’edizione del 2017, per non parlare di grandi classici come l’Ulisse di Joyce? La stessa autrice ha risposto, d’altronde, che «non va letto nell’ottica del #MeToo. Milkman non è un flusso di coscienza, perché la voce narrante ingloba tutto ciò che la circonda».

Viene da pensare che la difficoltà sia, ancora una volta, quella di catalogare una voce femminile che si esprime in prima persona singolare, ma che neanche può essere definita “intimistica”, “introspettiva”, “personale”. La voce narrante di Milkman è monologante ma non introspettiva, e la sua potenza deriva proprio dal suo essere una riflessione in prima persona di tutto quanto sta fuori: il racconto è innanzitutto scandito dalla geografia urbana, si svolge in un costante esterno, nel corso del camminare-leggendo che dà il ritmo al romanzo: ripetitivo, a tratti ossessivo, ma anche leggero, quasi canzonatorio, al modo di una filastrocca, o di una cantilena. La voce scandita da questo camminare diventa una narrazione in prima persona di queste stesse strade, della loro disposizione regolare, monotona e chiusa. A tratti è sincopata: osserva, registra, frammenta, rompe, spezza ed è interrotta dai luoghi in cui non si può andare – e dalle cose che non si possono dire.
Milkman è a tutti gli effetti una grande riflessione sul rapporto che c’è tra la violenza e il linguaggio. Per questo non ha molto senso cercare di accostare il #Metoo al conflitto dell’Irlanda del nord, trattare le due cose come temi, tentare operazioni di “attualizzazione”, che vanno sempre di pari passo alle grandi “rimozioni” con cui si affronta il tema del conflitto – perché il romanzo è il racconto di come sia difficile racchiudere la violenza in una sfera intima, personale, quando la struttura su cui si innesta è sociale. E di come, per converso, la maggior parte delle guerre siano decise dagli uomini, articolate in logiche tribali, identitarie, di possesso e appartenenza, ordinate da norme che regolano le sfere più intime. Il romanzo invita, in altre parole, a far saltare i nessi con cui la violenza è catalogata, smistata, gestita, a ridisegnare i rapporti tra sopruso “privato” e aggressione “pubblica”. Il rimuginino costante a cui è sottoposta l’ordinarietà opprimente della vita e del territorio – il camminare-leggendo è un modo abile di farsi scudo con le parole, quasi a voler inserire testo, significato, in una dimensione tutta cosale, scarna, tagliente e compatta che è quella del conflitto armato – sembra indicare che la costante, ciò che accomuna tutte le forme di oppressione, è che dove c’è violenza c’è sempre una carenza di linguaggio.

C’è un episodio importante nel romanzo che apre uno squarcio improvviso, comico e, a suo modo. toccante. Sorella di mezzo studia francese, e racconta di come la sua insegnante si sia incaponita a ottenere dalla classe una descrizione del cielo che non sia «blu». Il cielo ha un’infinità di colori ma la classe semplicemente rifiuta di ammetterlo. È indicativo che sia un’insegnante di una lingua straniera a provocare un simile scompiglio. «Ovviamente sapevamo bene che il cielo poteva essere più che solo azzurro, poteva essere di altri due colori, ma per quale motivo avremmo dovuto ammetterlo?». Perché ammettere una cosa simile significa contravvenire alla «coscienza collettiva sulla questione dei colori», al di fuori della quale si apre qualcosa che è intollerabile, perché privo di mediazioni. «Se forze e sentimenti non mediati avessero fatto irruzione nella mia coscienza, non avrei saputo cosa fare».
L’episodio fa pensare a un passaggio molto citato di Maglia o uncinetto di Luisa Muraro, scritto negli stessi anni in cui il romanzo è ambientato, il cui l’autrice racconta della sua esperienza di insegnante in una classe di ragazzi e ragazze che lei definisce «fedelissimi al luogo comune». Prova, usando la poesia, a rompere alcune connessioni abituali, ordinarie, preformate, che sono, ad esempio «il prato è verde». Come l’insegnante di francese, che si oppone con tutte le sue forze al le ciel est bleu, anche la Muraro cerca di dimostrare che non è sempre vero che «il prato è verde» o che «la vita è bella» – certamente non nella periferia di Milano dove insegna. La fatica di uscire dalle espressioni e dalle frasi fatte, dal pensiero preformato, è il tentativo di scardinare connessioni che non corrispondono al vero e che soprattutto non riescono a nominare l’esperienza che se ne fa – in causa non è la verità oggettiva, la verità che la collettività ha riconosciuto essere oggettiva, ma la verità di un sentire, che se sprovvista di una mediazione sociale si situa sul versante di tutto ciò che è falso, o di ciò che non esiste.
In apertura del libro la protagonista di Milkman, parlando del Lattaio, dice: «A quel tempo, a diciott’anni, essendo cresciuta in una società dal grilletto facile dove le regole di base erano che se nessuna mano violenta era stata alzata su di te, e se nessuna offesa verbale ti era stata scagliata addosso, e se nessuno sguardo provocatorio di chicchessia s’era posato su di te, be’ allora non era successo nulla, quindi come potevi sentirti attaccata da qualcosa che non esisteva? A diciott’anni non avevo gli strumenti per capire i modi che costituivano l’oltrepassare-il-limite». Se l’affronto non è esplicito, se non è detto, se il limite non è visibile, allora non esiste.
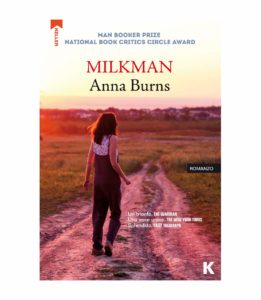 Si tratta chiaramente dei passaggi che fanno pensare al #Metoo, e che richiamano i testi di autrici femministe che più hanno lavorato sul linguaggio a partire dagli anni ’70. E sull’idea di verità («le donne mentono»), sulla scissione tra sentire e dire che è articolata, costruita, e che sta alla base di una serie di divieti e di assenze: a forza di far dipendere la lingua dall’esistente si finisce non solo per non poter più accedere a tutta una serie di porzioni di realtà, ma si finisce anche per essere assenti a se stesse. «Io stessa ho finito per trovarmi inaccessibile», dice la protagonista, in un momento del romanzo in cui ogni cosa è diventata corpo, cosa, sintomo. Prima che arrivi l’intuizione, lenta, costante, prepotente, che l’uscita dal non detto avviene annunciando l’esistenza di ciò che non è previsto – e per questo alla fine si capirà che il camminare-leggendo è una forma di produzione, un lavorio, una trama che separa e che rimette in ordine i rapporti tra esterno e interno, tra fuori e dentro, tra un io e un “noi” e un “loro”.
Si tratta chiaramente dei passaggi che fanno pensare al #Metoo, e che richiamano i testi di autrici femministe che più hanno lavorato sul linguaggio a partire dagli anni ’70. E sull’idea di verità («le donne mentono»), sulla scissione tra sentire e dire che è articolata, costruita, e che sta alla base di una serie di divieti e di assenze: a forza di far dipendere la lingua dall’esistente si finisce non solo per non poter più accedere a tutta una serie di porzioni di realtà, ma si finisce anche per essere assenti a se stesse. «Io stessa ho finito per trovarmi inaccessibile», dice la protagonista, in un momento del romanzo in cui ogni cosa è diventata corpo, cosa, sintomo. Prima che arrivi l’intuizione, lenta, costante, prepotente, che l’uscita dal non detto avviene annunciando l’esistenza di ciò che non è previsto – e per questo alla fine si capirà che il camminare-leggendo è una forma di produzione, un lavorio, una trama che separa e che rimette in ordine i rapporti tra esterno e interno, tra fuori e dentro, tra un io e un “noi” e un “loro”.
Se Milkman richiama alla mente i percorsi di liberazione femminile che hanno preso forma attorno alle pratiche linguistiche – a partire da un’indagine attorno alle gerarchie che decidono dell’accesso al linguaggio, della verità delle esperienza e dunque della possibilità della nominazione – c’è un altro versante di questo stesso problema che il romanzo porta in primo piano – e che forse spiega l’affermazione dell’autrice secondo qui ragionare in termini di #Metoo sarebbe riduttivo, anche nella misura in cui nominare un tema è spesso anche una maniera per liquidarlo. Perché si tratta di un aspetto legato alla violenza, al sopruso e al dominio che non si esaurisce in una “questione femminile” (che fa della violenza maschile un problema delle donne), così come non riguarda un periodo e un luogo circoscritti (la Belfast del passato). Se si tiene a mente che tempo e luogo non hanno nome nel romanzo, ovvero se si vuole, alla lettera, generalizzare, o parlare di ciò che il libro ha di più attuale, se proprio di attualità bisogna parlare, è possibile dire che il secondo aspetto importante della relazione tra linguaggio e violenza è che la povertà linguistica non solo rispecchia ma produce povertà di esperienza. E che è su questo meccanismo che lavora il dominio di un ordine che si tiene sulla coincidenza tra l’esistente e il reale – che ha espugnato ogni idea di possibile.
Su questo tema hanno indagato moltissimo autori che hanno guardato alla violenza anche fuori dai suoi confini storici, come Benjamin, Adorno, Orwell, per citarne solo alcuni, che hanno declinato lo stesso concetto di dispotismo – potere, dominio, ecc. – anche, e forse soprattutto, al di fuori dei confini delle forme storiche del totalitarismo, guardando a come la violenza – e la guerra, per esempio nel breve saggio Povertà ed esperienza di Benjamin – non è che l’inizio di una «miseria», di una «impossibilità di fare esperienze in maniera diretta» per dirla con Adorno, che caratterizza la modernità tutta. Come a dire, il mutismo – in Benjamin è il mutismo degli uomini che tornano dal fronte, che anticipa un’incomunicabilità di altro tipo – non è l’unica forma che assume l’impossibilità di parlare. La stessa lingua, la nostra maniera di parlare, la «comunicazione», può essere ciò che, se usata in una maniera impoverita, svuotata, dunque efficiente, di fatto impedisce di fare esperienza – di produrre esperienza. Adorno parlerà di una ideologia del fare, di una «volontà of doing things», e di una «efficiency», completamente «indifferente al contenuto di tale operare» malata di «realismo», che caratterizza la violenza sia fascista che quella meno appariscente dell’America del dopo guerra. Slogan, frasi fatte, parole composte e luoghi comuni (già Adorno diceva di Heidegger che non si consegue alcuna conoscenza separando il prefisso da un verbo e riunendoli poi con un trattino, e una stessa operazione avrebbe fatto Orwell con le parole composte in inglese) servono a che nulla venga detto, a che il sentire sia impedito, e dunque a che non si produca nulla di diverso da quello che c’è già – il “così è”.
Questo aspetto, che nel libro sta come traccia sotterranea, onnipresente, pervasiva, innominabile e allo stesso tempo ovvia, è ciò che rende la narrazione claustrofobica e ossessiva, schiacciata, ma è anche ciò che dà alla voce narrante la sua urgenza, il suo ritmo, la sua insistenza e la sua forza. È ciò che rende la violenza qualcosa di vivo e allo stesso tempo reversibile – è una voce che impara, camminando, a inceppare la ripetizione della città, il suo ordine sordo e la sua disposizione cieca, a partire da poche ma efficaci descrizioni, sfidando, per esempio, il codice che regola i colori e i «guardiani del vocabolario». A partire da una lingua che non è quella ufficiale, del posto, “nazionale”, ma da una lingua straniera, quella di un’insegnante che promette: «cambiate una cosa, miei cari allievi, basta una sola cosa e vi assicuro che anche tutto il resto cambierà».
