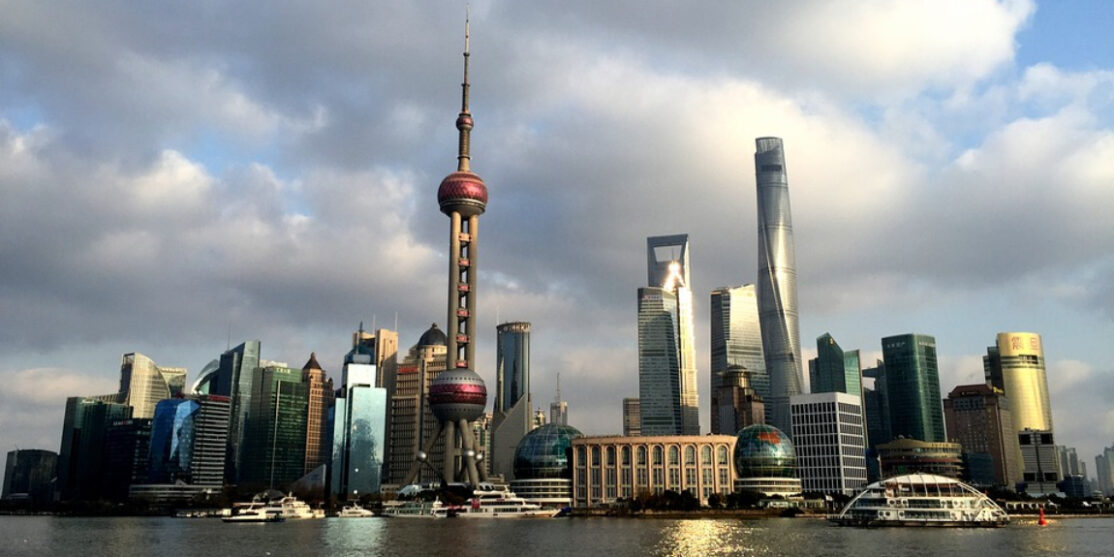OPINIONI

«Le stanze dove i soggetti neri non entrano». Intervista a Nadeesha Uyangoda
L’autrice di L’unica persona nera nella stanza parla del suo libro, di minoranze e del 25 aprile. E si interroga sulla traduzione come «potere e privilegio che ha effetti concreti sulla lingua e sulla cultura»
Uscito a marzo, L’unica persona nera nella stanza è il primo libro della giornalista e scrittrice Nadeesha Uyangoda. Mémoire, saggio, reportage, è la storia dell’autrice che cresce in Brianza, di cosa voglia dire essere l’unica persona nera a scuola, negli ambienti di lavoro, “nella stanza”. Ma c’è molto di più, in questo libro breve ma denso: in particolare l’incontro e il trovarsi con altre soggettività migranti e/o appartenenti a minoranze, le sfide quotidiane per contribuire allo sviluppo di nuove sensibilità e una serie di questioni aperte che forse solo in questo periodo stanno diventando più concrete e discusse.
Una scrittura secca, priva di orpelli e estremamente gradevole, quasi didattica ma senza mai essere banale o didascalica. Forse la cosa migliore del libro è proprio la sensazione di work in progress che traspare, non l’intenzione quindi di fornire risposte chiare e assolute quanto un processo che parte dall’autrice per incontrare altre persone e provare a mettere in comune saperi e esperienze.

L’autrice cura anche, con Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso, il podcast “Sulla razza” che in maniera chiara e semplice traduce, interpreta e problematizza una serie di termini provenienti dal dibattito anglofono. L’abbiamo raggiunta al telefono per parlare di L’unica persona nera nella stanza.
Mi pare che il tuo libro sia uscito al momento giusto, c’è un rinnovato interesse per questioni razziali, per identity politics e via dicendo.
Il libro è stato commissionato in un periodo completamente diverso ed è uscito invece quando queste questioni sono all’ordine del giorno, a livello mediatico ma anche all’interno delle comunità delle minoranze etniche. Mi pare stiano anche intercettando brand e grandi multinazionali, che provano anche in Italia a incorporare tematiche antirazziste.
Su questo ti chiedo subito se questi interessi diciamo commerciali non rischino di brandizzare l’antirazzismo?
C’è sicuramente il rischio che la potenza anche simbolica delle rivendicazioni di Black Lives Matter e altri movimenti venga annacquata quando arriva in aziende e multinazionali. Sicuramente l’interesse, specie delle grandi corporation, aiuta ad arrivare a più gente (avendo loro davvero un potere comunicativo notevole), ma non è detto che non rimanga solo un’operazione cosmetica: la diversità è a livello di immagine, senza che si provi a fare un vero tentativo di inclusione.
Abbiamo invece bisogno di un reale cambiamento. Mi pare che in parte questo sia già successo con i tentativi di queste aziende di incorporare il femminismo, con degli aggiustamenti che però non cambiano davvero il sistema.
Che poi è il rischio del diversity management in generale, molto comune in ambito anglofono ma che si sta diffondendo anche da noi.
Sì, negli ultimi tempi ho avuto a che fare con molte persone che si occupano di diversity e inclusion per le aziende in Italia. Sono tutte/i bianche/i. Che per carità, va bene, però è anche sintomo di qualcosa che ancora non va, di un opportunismo invece che di una reale voglia di cambiamento strutturale.
Nel tuo libro, ma anche nel podcast “Sulla razza”, mi pare cerchi un equilibrio tra istanze che arrivano dal dibattito anglofono e altre proprie del dibattito italiano…
È sicuramente molto complicato. Forse c’è una differenza generazionale. Per chi è più grande rimane fondamentale andare a vedere le storie passate, leggere e studiare il colonialismo italiano e non, nella speranza poi che questo arrivi anche alle nuove generazioni. I e le più giovani invece, una generazione che si è formata sui social network, è più sensibile a quello che arriva dagli Stati Uniti, e in particolare a Black Lives Matter.

Foto dall’archivio DINAMOpress
Non ci sono tra l’altro dubbi che la riflessione su questi temi in ambito anglofono sia molto più avanti. Abbiamo bisogno di entrambi, accettare e fare nostra la carica simbolica di quello che arriva da oltreoceano senza dimenticare però le peculiarità della storia e della società italiana. Ed è qualcosa che tentiamo di fare con il podcast “Sulla Razza”.
Beh in Italia abbiamo una tradizione di intolleranza razziale che non è certo recente, e che include oltre al colonialismo e i suoi effetti, al razzismo verso i migranti, anche l’antiziganismo e l’antisemitismo.
Assolutamente. Mi sembra importante poi notare come in Italia la dicotomia tra bianchi e neri che esiste – con tutti i suoi limiti – negli Stati Uniti non possa proprio funzionare. Su questo è davvero paradossale che si sia parlato di razzismo contro gli asiatici in Italia dopo i recenti episodi in USA, come se questo tipo di intolleranza razziale non sia diffusissimo in Italia da decenni!
In quella dicotomia che stiamo importando infatti non trovano spazio le comunità cinesi, indiane, rumene che sono molto grandi in Italia. Questo è sicuramente uno di quei casi in cui non possiamo prendere quello che arriva da oltre oceano e applicarlo acriticamente in Italia.
Nel libro parli dell’importanza del 25 aprile, delle manifestazioni e di quel noi relativo alla storia italiana che per te si è creato grazie alla memoria della Liberazione. Come si può tramandare questo noi? E ha senso per te tramandarlo?
La mia è una storia particolare che ha a che fare con il mio vissuto, con i miei incontri. Non so quanto per le nuove generazioni sia importante il 25 aprile, di sicuro c’è una difficoltà (e questo vale per minoranze etniche e non) nel far capire perché l’antifascismo sia ancora fondamentale, e quanto sia legato all’antirazzismo.
Per alcuni soggetti razzializzati in più c’è la questione del non sentirsi legati alla storia della Liberazione perché non è la storia dei propri antenati e questo naturalmente è anche più complesso per chi ha radici nelle ex colonie italiane, visto che la storia dei partigiani somali, eritrei ed etiopi non è raccontata nei sussidiari.
Forse recuperare storie, come quella della Banda Mario, un gruppo partigiano attivo nelle Marche e composto da donne e uomini di varie nazionalità e religioni, potrebbe essere utile (ne ha scritto lo storico Matteo Petracci e Rai Storia sta preparando una puntata su questo che uscirà il 23 aprile).
Ti chiedo: è ancora possibile essere l’unica persona nera nella stanza in un paese sempre più multietnico?
In provincia sicuramente! Ci sono ancora molte persone che crescono come sono cresciuta io, non vedendo persone nere per anni e anni. Nelle grandi città è diverso, dove le comunità con un background migratorio sono più numerose e, al di là di problemi di marginalizzazione o segregazione, i bambini e i ragazzi hanno più possibilità di ritrovarsi con coetanei simili a loro, evitando quel senso di isolamento che ci rende le uniche persone nere nella stanza.
Questa condizione, più che nelle scuole, però, è ancora rilevabile in settori come quello della cultura, dell’intrattenimento, della politica: quelle sono stanze in cui soggetti neri non entrano quasi mai – eppure siamo un paese “sempre più multietnico” da molto tempo.

Foto dal profilo Facebook di Nadeesha Uyangoda
Scrivi nel tuo libro che è importante «condividere le nostre esperienze con un pubblico il più ampio possibile, ma farlo senza un pensiero strutturato, una critica ben più delineata, può fare più male che bene». Ecco, come si costruisce questa critica strutturata? E come si costruisce insieme mi verrebbe da dire?
C’è sicuramente ancora bisogno, soprattutto da parte delle giovani generazioni di neri in Italia, di raccontarsi, di raccontare le proprie storie – che spesso sono belle storie. E questo va benissimo, ha anche a che fare con i social network e la capacità che hanno di veicolare queste storie e di far incontrare le persone.
Però non basta, dobbiamo fare un passaggio successivo, evitando di far prevalere una frammentarietà eccessiva di queste esperienze che non permetterebbe, secondo me, di passare a una critica più strutturata.
Ti va di commentare la questione della traduzione delle poesie di Amanda Gorman?
Ci provo, anche se non sono una traduttrice. Evidentemente in questo caso si tratta di un caso di marketing più di ogni altra cosa e di egemonia dell’editoria statunitense, o comunque di lingua inglese, su questo sono d’accordo con quello che diceva Martina Testa nella vostra intervista. E sono pure d’accordo con l’idea che chiunque possa tradurre chiunque.
La questione però non è che le persone bianche hanno le competenze e le capacità per tradurre autori neri, il punto è capire chi è quel chiunque che può tradurre chiunque: spesso sono le stesse identità dominanti a tradurre quelle marginalizzate.
Tradurre, in questo senso, sembra essere un potere e un privilegio che ha effetti concreti sulla lingua e sulla cultura. Allora per interrompere la ripetitività delle identità che traducono e per decostruire gli effetti di quel potere, non credo sia sbagliato trovare il modo di far tradurre di più traducenti appartenenti a minoranze etniche, e va bene che partano dalle scrittrici nere.
Foto di copertina dal profilo Facebook di Nadeesha Uyangoda