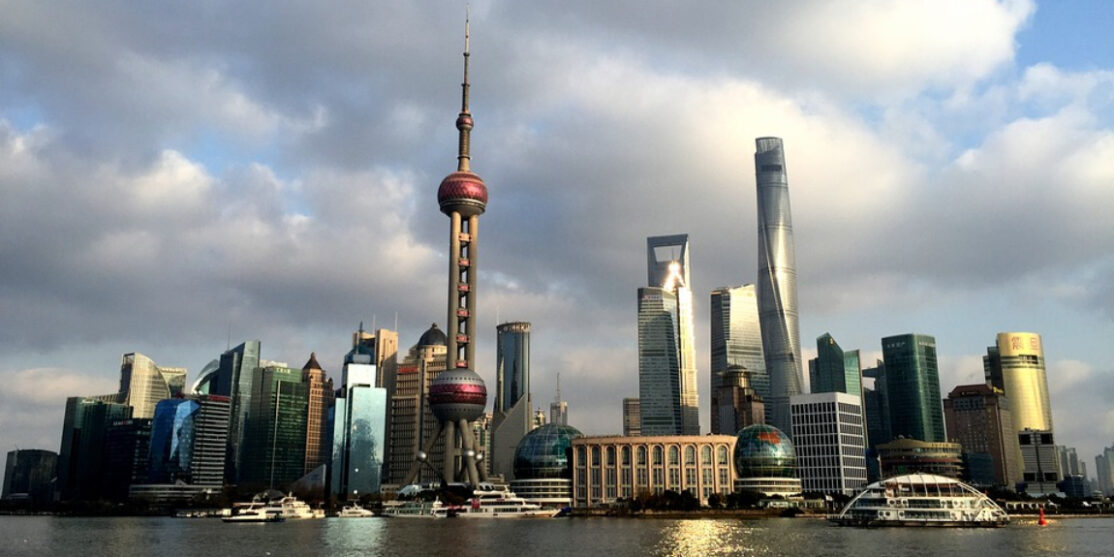ROMA
La rottura della doppia frontiera della Tiburtina

Roma, dove i confini entrano al proprio interno. Roma dove per escludere quello che si vuole rinchiudere si esclude anche chi è fuori. Roma dove la città rifugio è possibile. Per chi arriva. Per chi l’abita.
L’ex Cinema Palazzo, occupato da più di quattro anni, da qualche mese ha strappato alle macchine, oltre lo stretto marciapiede che lo borda verso la piazza, una striscia di asfalto. Una lunga ed abbastanza larga stanza all’aperto dove, a segnare questa liberazione, da subito è stato piantato un piccolo albero.
Conficcato nel suolo si ostina a sopravvivere facendosi forza del rispetto, oltre che dello stupore, di chi passa. E’ormai un segnale. Individua quell’ex cinema che resiste a pensarsi e ad inventarsi diverso da come avrebbero voluto che fosse, una casa per il gioco d’azzardo. Segnala, ora, come, a partire da luglio, sia diventata una grande “bocca” per inghiottire le tante, tantissime confezioni, i tanti, tantissimi scatoloni inzeppati di generi alimentari, vestiti e oggetti con cui i tanti, tantissimi (non solo cittadini di San Lorenzo) hanno voluto dimostrare cosa per loro fosse l’accoglienza.
Il Cinema e quella striscia dove via via vengono stoccate casse, cassette e scatoloni funziona come uno dei diversi punti di raccolta cittadini verso il Baobab, il “centro” dove da luglio si sono ammassati, ad oggi, i ventisettemila “transitanti” nella nostra città.
A San Lorenzo tutto questo ha avuto anche un altro significato, quello di dimostrare che il quartiere era diverso da come lo andava raccontando il Presidente del Municipio che l’avrebbe, impaurito dal Baobab che quel quartiere lambisce, voluto attrezzare a luogo di resistenza (sic!) allo straniero. Terrorizzato dalle migliaia di corpi che si andavano ammassando, tracimando da quel dedalo di strette vie, capannoni, casupole a ridosso della via Tiburtina.
Accadeva in quella melassa edilizia, ormai pronta ad essere preda privilegiata della bulimia del piano regolatore, che individua uno dei confini dell’urbanistica finanziaria, di Roma.
Confini che non hanno certo bisogno di strumenti urbanistici per essere segnati. Non si servono di recinti, ingressi, varchi da passare. Fanno l’opposto tendono a de materializzarsi proprio attraverso la narrazione della “rigenerazione”.
Non è quello che avviene per esempio, con il cosiddetto stadio della Roma(sic) e con il suo milione di metri cubi commerciali/terziari in eccesso taroccati dal racconto di un nuovo parco?
Quello che si intende organizzare attorno la via Tiburtina è di attraversare la vita di tutti quelli che si vogliono tenere dentro questo territorio.
Di chi è assoggettato alla precarietà lavorativa costante per far vivere la “nuova stazione”; di chi, altrettanto precario e sfruttato è legato al lavoro all’interno della nuova cattedrale del potere bancario, che lì sta realizzando il proprio edificio totem. Un lungo scafo dalla carpenteria metallica dalle fattezze di una nave, non certo un servizio cittadino, si appresta a galleggiare sui binari, puntando alle vecchie antichità di una tangenziale che sputa in faccia ad una “nuova” stazione che praticamente ancora deve nascere.
Di chi è costretto a sopravvivere o ad essere cacciato da San Lorenzo, quartiere dove l’Amministrazione comunale ha iniziato ad affrontare il tema della rigenerazione urbana, mortificando l’abitare a furia di demolizioni di parti significative del patrimonio archeologico industriale ed autorizzando un diluvio di permessi di costruire pronti a trasformarsi in incubatori di “posti letto”, neppure stanze, e luoghi del consumo.
Di chi non ha avuto paura di innescare un conflitto resistendo a chi vuole trasformare quei luoghi inzeppandoli con residenze di lusso (la “città del Sole” di Parnasi e le sue palazzine griffate dagli architetti), con l’espulsione di quegli abitanti che rappresentano la sua storia e la sua memoria.
Di chi non intende cedere alla volontà di spingerli alla migrazione verso lontani territori, rendendoli invisibili, allontanandoli dal quell’ area della città.
Quello che sta avvenendo, ora, intorno al Baobab sta facendo saltare il voler fare della vasta area intorno alla nuova stazione, un confine: quello che individua il territorio della colonizzazione dell’urbanistica finanziaria.
Ora quest’ area della città, consegnata al mattone finanziario, si è riempita di corpi di uomini e donne cacciati dai loro territori da fame e guerra, corpi da cui non poter prendere nulla. Lasciarli lì senza nessuna assistenza non è stato sufficiente a renderli invisibili.
Né poteva funzionare quanto fatto solo pochi giorni prima quando da intorno ai piloni, da sotto il nastro della Tangenziale, era stata sgomberata una tendopoli messa su in fretta a ridosso di un altro sgombero, quello di Ponte Mammolo. Qui i cingolati della polizia avevano asfaltato case tirate su alla meglio, tende e baracche che da tanto tempo offrivano un rifugio auto organizzato in una città incapace, da sempre, di declinare la parola accoglienza all’infuori del prontuario del businnes .
Il dispotismo di quello sgombero ha finito con il far arretrare quella frontiera con cui si voleva rendere invisibile quella realtà, portandola fin nel cuore della città.
Così, ora, il tratto iniziale della via Tiburtina è diventato lo spazio di cui ci si serve per alimentare la fantomatica emergenza emigrazione facendo premere su quella stazione a ponte, che avrebbe dovuto unire la “città consolidata” all’organizzazione di quello che sarebbe dovuto essere il sistema direzionale orientale (SDO), i moltissimi corpi dei transitanti, da lasciare al volontariato senza alcun sostegno né economico né di offerta di strutture.
Non ci sono muri, il confine sta proprio nel nastro stradale della via Tiburtina a reggere una sorta di dualismo sospeso. L’accoglienza che non si vuole assumere nel suo significato vero, quale elemento per fare di Roma una città rifugio capace di ripensarsi all’interno del fenomeno dell’immigrazione come evento inarrestabile. La rigenerazione urbana che non si vuole pensare all’infuori della sola densificazione delle cubature in balia del migliore offerente.
Lo spazio della via Tiburtina, quella strada che all’inizio dello scorso secolo aveva rappresentato il collegamento pressoché unico per far arrivare, sbarcandoli direttamente a San Lorenzo, i materiali lapidei e le calci con cui si sarebbe costruita la città, diventa ora un elemento per mettere in fila fatti e azioni che la città distruggono, la sua stessa sopravvivenza.
Ad iniziare dall’ evidente considerazione che la trasformazione della città non può avvenire attraverso atti autoritari. Che il confine tirato su lungo la Tiburtina, teso intorno al Baobab, finisce con escludere quello che lì appena fuori era stato apparecchiato.
Fino a quando la solidarietà popolare potrà sostenere il loro lavoro e fino a quando sarà possibile reggere questa situazione, oggi “tenuta” dai volontari del Baobab costretti a muoversi negli interstizi edilizi di fabbricati, destinati alla loro valorizzazione economica, ad essere preda dell’investitore di turno, secondo le solite ricette della rendita?
Il Baobab è una grande occasione per ripensarci all’interno della città, ad insegnarci a vedere proprio quello che si vuole rendere invisibile. A riconoscere come lungo questa strada sia avvenuta in effetti la rottura di tutte e due i confini, quello tracciato dalla finanza immobiliarista, quello tracciato dalle forme del controllo.
Lungo la via Tiburtina a Roma non c’è da scegliere tra solidarietà e forme di contenimento ed opposizione, quanto riconoscere la possibilità della condivisione di un destino non diverso tra migranti, transitanti, abitanti, comunità insediata: creare, attraverso pratiche ed azioni, ciò che ancora non esiste. La città rifugio per chi arriva, la città rifugio per chi l’abita.