cult
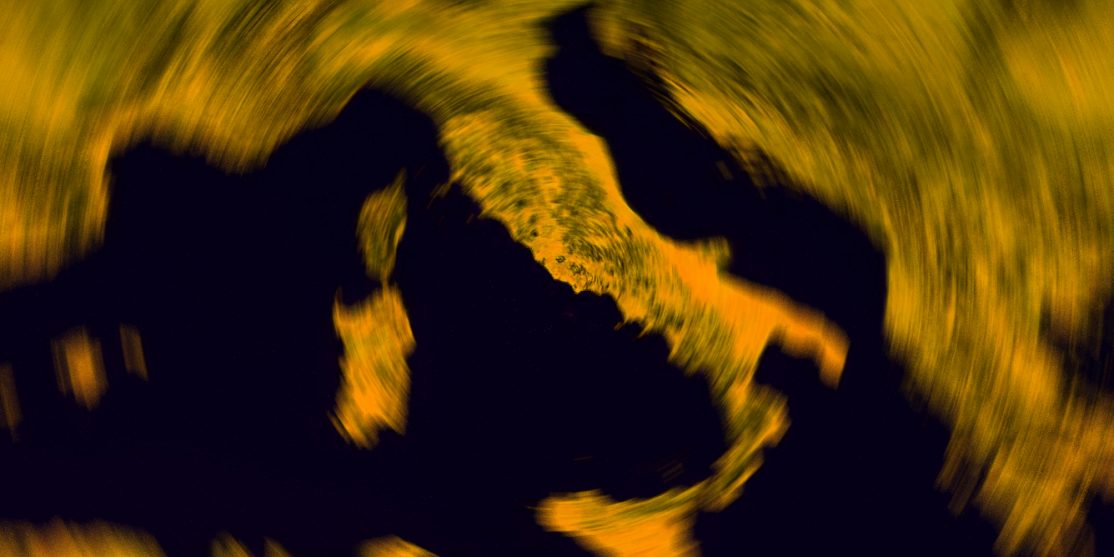
CULT
La nazione vista dal Sud
Ne “Il rovescio della nazione. La costruzione coloniale dell’idea di Mezzogiorno” (Tamu ed.), Carmine Conelli ci porta a riconsiderare la storia che ha costruito l’immagine subalterna del Sud, rifiutandoni le rappresentazioni grottesche tanto quanto il recupero di mitologie reazionarie
L’uscita de Il rovescio della nazione arricchisce il catalogo di Tamu, casa editrice napoletana che prova a sollevare qualche strato di polvere dal dibattito culturale italiano, tirando fuori temi «pericolosi». Il Mezzogiorno, con tutti i problemi che lo stesso significato di questa parola implica è uno di questi.
Da qualche anno, a dire il vero, il tema della disparità di condizioni materiali fra territori di quello che dovrebbe essere uno Stato unitario è di grande attualità ma quasi sempre collocato nella palude che si estende fra il dogma dell’intoccabilità dello Stato-nazione, i rigurgiti «neoborbonici» della peggiore e retriva destra reazionaria e la storiografia da discount. Questo volume si smarca nettamente da tutta questa melma ponendo, invece, interrogativi importanti.
Sono innumerevoli gli esempi possibili di questa disparità fra aree del Paese, leggibili dai dati relativi a tutti gli aspetti del vivere civile, questo testo ferma l’obiettivo, però, su come questi processi materiali siano sorretti da un architrave ideologico che ne permette la stabilità interpretando la storia italiana in modo da nasconderne la materialità dei processi storico-politici. Una «questione culturale» che attraversa tutta la storia unitaria, non solo quella remota, come mostra il volume La questione meridionale di Friedrich Vöchting, uscito nel 1955 con i fondi della Cassa del Mezzogiorno, nel quale l’autore descrive l’«immutabile passività» della «razza mediterranea» che avrebbe una «funzione storica […] quella di chi è dominato e mai di chi domina, di chi riceve e che mai riesce a dare, e, soltanto gli incroci con altre razze, o meglio la forza di questi incroci con gruppi etnici più robusti […] sviluppa in essa la disposizione per le attività civili superiori». È significativo osservare quanto fossero radicate, in Italia e in Europa, la sfiducia e il pessimismo nelle possibilità di trasformazione sociale delle popolazioni meridionali, appena 70 anni fa, così come la tradizione lombrosiana della «razza maledetta», per ricordare un testo di Vito Teti (La razza maledetta. Origini del pregiudizio antimeridionale, Manifestolibri, Roma [1993] 2011).
Ancor più significativo, poi, andare all’immanenza di questa contraddizione all’interno della classe operaia in lotta. In Napoli: il terremoto quotidiano. Miseria, disoccupazione e lotte sociali negli anni ‘70 (Loffredo, Napoli 1982) Conrad Lay riporta una frase che ben riassume la profondità della contraddizione: «In un’osteria di Bologna nell’autunno del 1978 un operaio quarantacinquenne, membro del partito comunista da moltissimi anni, mi ha detto quanto segue: “se non avessimo il Sud, non avremmo preoccupazioni”». L’idea della sostanziale irredimibilità del Sud ma anche la stessa costruzione ideologica di un meridione come entità territoriale e antropologica indistinta, quindi, non era un elemento culturale proprio delle classi dirigenti, anzi. Quella visione era ben presente e radicata anche nella stessa classe operaia che provava ad assaltare il cielo nel «lungo ’68 italiano».
Il testo di Conelli, in questo senso, è importante perché segna una linea, dietro alla quale deve posizionarsi chi rifiuta questa impalcatura ideologica ma nel contempo ritiene che siano da avversare le forme grottesche di iniziativa politica degli «apologeti del Sud», fascisti o meno, sempre ascrivibili a un parterre reazionario.
Posizionarsi in opposizione a tali letture vuol dire affrontare il problema con gli strumenti analitici della storiografia, senza lasciarsi prendere da suggestioni «di destra».
Il rovescio della nazione, quindi, nel recuperare la complessità della questione, a partire dal rifiuto dell’idea di un meridione borbonico come un’epoca aurea pone come primo elemento utile al dibattito l’abbandono dell’idea stessa di Mezzogiorno, reductio ad unum ben presente, invece, nel discorso di chi oppone all’unità della Nazione quella di un fantomatico «Sud» sovrano, che permane nel piano dell’autorità statuale senza soluzione di continuità. Confini contro confini, in un gioco perverso nel quale si risponde alla Lega con un identitarismo opposto, un sovranismo locale. Una via senza uscita che getta, peraltro, la questione nel campo del tragicomico: dove tracciare i confini settentrionali di questa fantomatica «Repubblica del Sud». Piazziamo le dogane al Garigliano? E il Lazio dove va? Ma esiste il Lazio? Che hanno in comune Viterbo e la Ciociaria? E gli abruzzesi dove li mettiamo? Roba da ridere se non ci fosse da piangere.
Tralasciando l’avanspettacolo è evidente che l’unica risposta politica sia l’autonomia dei territori su cui però, occorre costruire un discorso politico laddove hanno balbettato la sinistra rivoluzionaria degli anni ’70 e i movimenti dei ’90, lasciando il tema alla sponda reazionaria dell’orrendo localismo diseguale ed egoista guidato dagli interessi della borghesia settentrionale, proprio come nel 1861. Anche rispetto a questo, però, e Conelli lo tiene ben presente, bisogna fare chiarezza.
Il processo di costruzione del Sud come «altro» rispetto al resto d’Italia, infatti, non è stato orientato in maniera unidirezionale sull’asse Nord/Sud. Le élites meridionali formatesi su modelli culturali nordeuropei vi hanno partecipato a pieno titolo alleandosi con la borghesia settentrionale, per convinzione o per convenienza.
Le stesse popolazioni meridionali, d’altro canto, non sono state passivamente aderenti al modello borbonico, anzi e infatti fu consistente la partecipazione al garibaldinismo proprio in nome della speranza di una trasformazione di quella società oppressiva. Altro è quello che è accaduto dalla vittoria militare in poi, che il romanzo di Anna Banti, Noi credevamo (Mondadori, Milano 1967), portato sugli schermi da Mario Martone nel 2010, racconta chiaramente. A partire da quel punto della storia possiamo leggere in maniera critica gli avvenimenti che hanno determinato la nascita del nuovo Stato italiano solo analizzandoli nella loro natura di processo di sviluppo capitalista, che puntava, fin dalle origini, a «ridurre la differenza imperiale con gli altri paesi d’Europa e riportare all’interno del discorso nazionale gli stessi meridionali», posizionando l’Italia dentro il contesto del capitalismo europeo, in cui sarebbero altrimenti evaporati il piccolo stato sabaudo come l’arcaico regno feudale dei Borbone. È dentro quel discorso nazionale che «i meridionali» hanno assunto il proprio ruolo subalterno, di riserva di forza lavoro utilizzata attraverso la migrazione interna ma anche esterna, nell’avventura coloniale italiana, rispetto alla quale il Meridione è stato un «laboratorio di immaginario coloniale» ma anche riserva di braccia per le politiche di conquista ed espansione di una «nazione globale» fondata su «legami di cultura, nazionalità ed etnicità tra le “colonie” di emigrati e la madrepatria». In questo senso appare chiaro come «l’osservazione della filigrana del colonialismo nel processo di formazione dello stato italiano» faccia constatare come «l’esclusione del Meridione dall’idea di Italia» rappresenti un elemento costitutivo di quello stesso processo di edificazione dell’entità statuale. L’elemento analitico in grado di fornire una visione concreta di questi processi storici, quindi, è l’analisi di classe – nella versione riveduta e corretta rispetto alla polverosa «scolastica» marxista – che permette di tenersi a debita distanza dalla proposizione di mitologie venefiche come quella neoborbonica che, nella sostanza, assolve le classi dirigenti che hanno gestito il potere in questi territori addossando le colpe di ogni male all’Unità.
Molto più interessante invece, ripercorrere la storia delle rivolte proletarie che hanno acceso fuochi nelle terre del Meridione, dal 1861 in poi, per alcuni versi anche nella storia del brigantaggio – lontano da qualsiasi agiografia – ma soprattutto nel secondo dopoguerra.
A partire da quel periodo, infatti, una serie di rivolte, più o meno organizzate, provano a mettere in crisi la compattezza del discorso politico dominante e la loro frammentarietà è l’effetto delle condizioni materiali in cui si trovano ad agire, dei rapporti di forza esistenti ma anche il segno di un ritardo della storiografia nel saperle leggere e collocare in un panorama di lotte di classe che ha una sua continuità, tutta da ricostruire, dalle lotte contadine a quelle operaie degli anni ‘60 fino alle rivolte dell’«operaio sociale», cioè del mondo del lavoro precario metropolitano, negli anni ’70.
E proprio al lungo decennio post-’68 guarda in conclusione questo volume, alla stagione politica che matura lungo tutti gli anni Settanta ma ha radici nel decennio precedente, quando dall’incontro tra militanti politici di varia estrazione e i baraccati, nascono esperienze di autorganizzazione che avranno un posto importante della storia della lotta di classe a Napoli. È da quelle esperienze seminali che nascono i Comitati di quartiere, esperimenti di autorganizzazione di quel proletariato urbano di cui il Pci diffidava e che la borghesia locale ancora oggi teme e disprezza, in quanto diavoli impropriamente abitanti un Paradiso destinato alle classi abbienti.
Quelle esperienze di democrazia diretta attraversarono il decennio promuovendo battaglie come quella per l’autoriduzione delle bollette, incrociando il movimento dei disoccupati organizzati e le esperienze di lotta armata in una lunga stagione politica nella quale i «paria» della città trovavano finalmente un protagonismo politico. Questo tipo di autonomia – un processo e non una sigla – è l’orizzonte storico-politico su cui soffermarsi, perché delinea uno spazio di riflessione che agisce dentro coordinate di classe e non su feticci come confini e identità. A partire da questa base è necessario uno sforzo collettivo per la ricerca di elementi di una possibile trasformazione del presente, senza agitare bandiere con lo stemma reale. Tra tutto quello che c’è da fare, di sicuro non c’è alcuna dinastia regnante e nessun tiranno da difendere o riabilitare.
Immagine di copertina da Wikipedia, rielaborazione grafica di Dinamopress
