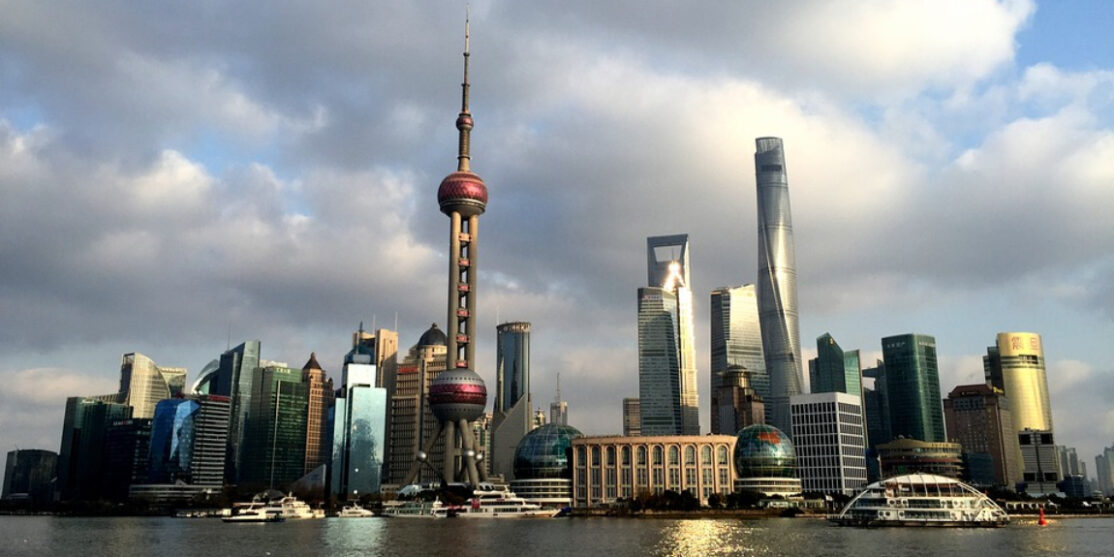MONDO

La Bolivia e l’America Latina di fronte al neoliberalismo golpista
Mentre in Bolivia continua la brutale aggressione di polizia e militari, i media locali e la stampa internazionale continuano, come prevedibile, a negare la svolta reazionaria innescata dal golpe. Meno scontata è invece la posizione di parte della sinistra latinoamericana e globale, e di una parte di quella femminista, che sembra aderire a questa narrazione
Il massacro in Bolivia non si ferma: dall’inizio del golpe contro il governo di Evo Morales il 10 novembre scorso, si contano almeno 34 morti, 1000 feriti (in buona parte a causa di proiettili sparati dalle forze dell’ordine) e un numero imprecisato di desaparecidos. Ultima in ordine di tempo, la brutale aggressione di polizia e militari contro un blocco stradale a Senkata, zona de El Alto, qualche giorno fa: 10 morti, almeno 500 feriti, e anche qui restano i desaparecidos dopo la repressione.
Il bilancio di questa nuova edizione del “terrorismo di stato” in America latina si fa sempre più pesante. Ma se la repressione è sempre più brutale è anche perché la resistenza popolare al golpe continua.
Nonostante le persecuzioni e le violenze inflitte a militanti, sindacalisti e giornalisti, la militarizzazione del paese e l’impunità istituzionale garantita alle forze dell’ordine dal governo “fantoccio” di Jeannine Añez, proseguono le manifestazioni e i blocchi stradali in diverse zone del paese. Mattanze e resistenze oscurate dai media locali e anche globali, che attraverso il silenzio non solo continuano a riprodurre l’ordine neoliberale del discorso, legittimando la svolta neofascista interna al neoliberalismo stesso per consentirne poi una sua futura capitalizzazione a seconda delle contingenze, ma stanno chiaramente gettando le regole del futuro gioco politico.
Non un “golpe di stato”, ma “una crisi istituzionale”; non un governo “civico-militare”, razziale e fondamentalista, che ha usurpato il potere con la forza e la violenza, ma un “esecutivo” di garanzia e di “transizione” fino a nuove e legittime elezioni. È questa la narrazione politico-mediatica dominante attraverso cui si cerca di riportare la Bolivia alla “normalità democratica” internazionale.
E tuttavia appare sempre più imbarazzante parlare di governo di transizione, non solo di fronte alla violenza esplicitamente razzista dispiegata dal governo auto-proclamato di J. Añez, ma anche nel momento in cui il suo ministro di economia annuncia misure urgenti di liberalizzazione finanziaria e di apertura al capitale globale, mentre quello degli interni agita violenta e minacciosa l’incriminazione penale di “sedizione” contro politici, sindacalisti e militanti dissidenti e concede impunità alle forze dell’ordine nell’esecuzione di vere e proprie, nonché anche del tutto mirate, “caccie umane”.
Può apparire chiaramente scontato che dentro l’ordine neoliberale-globale del discorso si continui a negare l’esistenza di un golpe di stato, meno prevedibile risulta però l’adesione a questa narrazione di una parte della sinistra latinoamericana e globale, in particolare di quella femminista.
Condividiamo molte delle critiche al modello instaurato dal MAS di intellettuali-militanti come Raul Zibechi, di femministe radicali come Rita Segato e Silvia Rivera Cusicanqui e abbiamo imparato moltissimo in passato dalle loro riflessioni sulla violenza dell’estrattivismo e dello sviluppismo acritico sulle comunità indigene, sull’intersezione di patriarcato e colonialità nel dispositivo sessista dell’attuale logica capitalistica di accumulazione e sulla potenza del femminismo popolare e indigeno come pratica di trasformazione radicale e di costruzione di modelli comunitari alternativi, ma il loro posizionamento «oltre ogni binarismo» (vedi Segato) in questa particolare congiuntura boliviana, ci appare assai poco comprensibile.
A lasciarci particolarmente stupiti nelle critiche di Segato e Cusicanqui è non solo il non-riconoscimento di altri posizionamenti femministi e indigeni, comunitari e antipatriarcali, nel conflitto come posizionamenti altrettanto legittimamente femministi e indigeni (vedi Korol e Adriana Guzman qui), ma soprattutto una sorta di rivendicazione-riappropriazione del femminismo come movimento super-partes, per così dire. Come è stato notato da diverse femministe latino-americane intervenute nel dibattito, difficile non vedere in questo atteggiamento una contraddittoria compressione del femminismo in un presunto (ed essenziale) femminile, proposto per di più non solo in una chiave identitaria, ma anche a partire da un’ambizione chiaramente egemonica. È quanto ci dice in proposito Adriana Guzmán, militante boliviana femminista e comunitaria: «Questa idea che tutti sono la stessa cosa ci colloca le femministe al di là del bene e del male, poiché non possiamo posizionarci da nessuna parte del processo, crediamo che anche questa sia un’eredità del femminismo coloniale. Le femministe non sono al di sopra di quello che sta accadendo, poiché stanno assassinando le nostre sorelle e i nostri fratelli. Dire che tutto quanto è la stessa cosa non ci appare soddisfacente, né sembra apportare nulla alla risoluzione del conflitto qui e ora. Siamo di fronte a un golpe di stato razzista, patriarcale, ecclesiastico e imprenditoriale. Non possiamo ritirarci di fronte a questa forma di fascismo».
Sul sito decoknow abbiamo tradotto una serie di analisi sul golpe in Bolivia dai quali, sia da quelli più filogovernativi (García Linera) sia da quelli più critici all’esperienza “populista” del governo del MAS (Stefanoni, Korol), si può chiaramente comprendere non solo che di «golpe di stato si è trattato» – nel senso che la destra oligarchica è riuscita ad assumere il coordinamento di diverse forze sociali di opposizione per attuare una rottura violenta e razzista dell’ordine costituzionale, stimolata e supportata dall’esterno dagli Stati Uniti, dalla UE e da tutte le istituzioni da essi controllate – ma soprattutto che la tesi di una mera complementarietà tra Morales e Camacho appare alquanto azzardata e priva di fondamenti materiali.
La redistribuzione delle risorse sociali, simboliche e materiali, operata nei 14 anni di governo del MAS, nonostante tutti quei limiti che abbiamo già ri-sottolineato in un precedente dossier, non può non essere considerata come un importante momento di cesura nella storia della Bolivia e del suo «delirio bianco»: non si può dunque minimizzare il significato politico dell’avanzamento in questi anni delle classi popolari, indigene e contadine dentro la struttura coloniale di classe, di razza e di genere tradizionale della società boliviana. È qualcosa che certamente fa una differenza, soprattutto per chi oggi può godere di questi avanzamenti in ambito economico, sociale, sanitario, giuridico, nel campo dell’istruzione pubblica, ecc. Morales e Camacho non sono dunque l’espressione di un unico modello. Un’affermazione di questo genere non vuole significare nemmeno “pulire la faccia al MAS”. Anche in questo caso, possiamo riprendere l’atteggiamento critico di una femminista come Adriana Guzmán: «Ciò che non ha fatto è toccare i privilegi dei grandi proprietari terrieri e dell’oligarchia di Santa Cruz, il vero fuoco di questo golpe razzista…la matrice economica è rimasta dunque la stessa, nel senso che la Bolivia resta un paese estrattivista di cui i ricchi continuano a trarre ampi benefici. È questo il limite di questo Stato: volendo governare per tutti deve anche governare per ricchi e stupratori». Anche tenendo presente questo panorama, come suggerisce comunque Adriana Guzmán stessa, sostenere una mera equivalenza tra i due “Machos” (uno indigeno, l’altro bianco), resta non solo una semplificazione un po’ superficiale, ma, dal nostro punto di vista, un grave errore politico. Soprattutto perché rischia di diventare un cattivo punto di partenza per continuare a ragionare e a lavorare alla costruzione di un modello politico alternativo anche a quello del MAS.
Qualunque posizionamento politico, per poter essere efficace, deve tener conto del più ampio quadro di rapporti di forza entro cui agisce: è questa una delle migliori lezioni da trarre da Gramsci.
Può dunque non piacere la figura di Morales, può non piacere il MAS, si può anche ritenere dannoso e problematico, anche “mafioso”, il suo modello “estrattivista”, “burocratizzato” e “machista” di gestione. Ma di fronte a una controffensiva neoliberale e fascista di queste dimensioni, e con i cadaveri del popolo che resiste ancora caldi nelle strade, occorrerebbe difendere in modo esplicito ciò che questi 14 anni hanno rappresentato. In primo luogo, perché sono stati possibili grazie all’insorgenza e alla soggettivazione politica dei movimenti sociali, indigeni e femministi. E poi perché il golpe in Bolivia, in mezzo alle insurrezioni di massa in corso contro il saccheggio neoliberale in Ecuador, Cile e ora anche in Colombia e nell’imminenza di nuovo governo “populista” in Argentina, si presenta come un preoccupante punto di inflessione in tutta la regione; come un evento-spartiacque che costringe tutti i movimenti a pensare seriamente sulla nuova congiuntura politica.
Ancora meno comprensibili ci appaiono le adesioni a questo tipo di critiche “anti-binarie”, per così dire, del conflitto in Bolivia imbracciate da una parte della sinistra radicale in Europa. Difficili non vedere in questi posizionamenti non solo una mera e vuota proiezione, narcisistica e identitaria, del proprio luogo di enunciazione politica, ma soprattutto un resto non-secondario di colonialità e di eurocentrismo. Diverse volte abbiamo insistito sul fatto che la tanto invocata decolonizzazione, come pratica teorica e politica, individuale e collettiva, consiste prima di tutto nell’aprire costantemente domande e interrogazioni sul proprio posizionamento rispetto a ciò che si muove nel Reale.
La decolonizzazione come metodo radica nell’assunzione intransigente dell’esistenza di uno scarto costitutivo, di ciò che si può anche chiamare un principio di non-identità, tra le nostre categorie di lettura e il Reale in quanto tale. Questo presupposto diventa ancora più necessario, una sorta di imperativo decoloniale si potrebbe dire, quando si tratta di comprendere fenomeni che accadono al di là della linea dell’Equatore. L’esistenza di questa storica divisione coloniale del mondo, richiede infatti un esercizio costante di «decolonizzazione della mente», per dirla con le famose parole di Ngugi Wa Thiong’o. Si sa, gli stessi fenomeni sociali e politici, da un lato e dall’altro di questa linea, possono assumere sembianze e significati profondamente diversi, a volte anche opposti. Nulla è ciò che appare: a partire da Marx, potremmo definire la proprietà ideologica costitutiva di questa linea-esperienza demarcatoria come “feticismo del colonialismo-imperialismo”. È proprio a questo che alludeva Frantz Fanon quando invocava una necessaria distensione del marxismo come chiave interpretativa della società, della storia e della lotta di classe nei contesti coloniali. La pulsione narcisistica rappresenta il limite più serio di ogni pensiero politico, la colonialità, specie da questa parte del mondo, una sua storica aporia bianca.