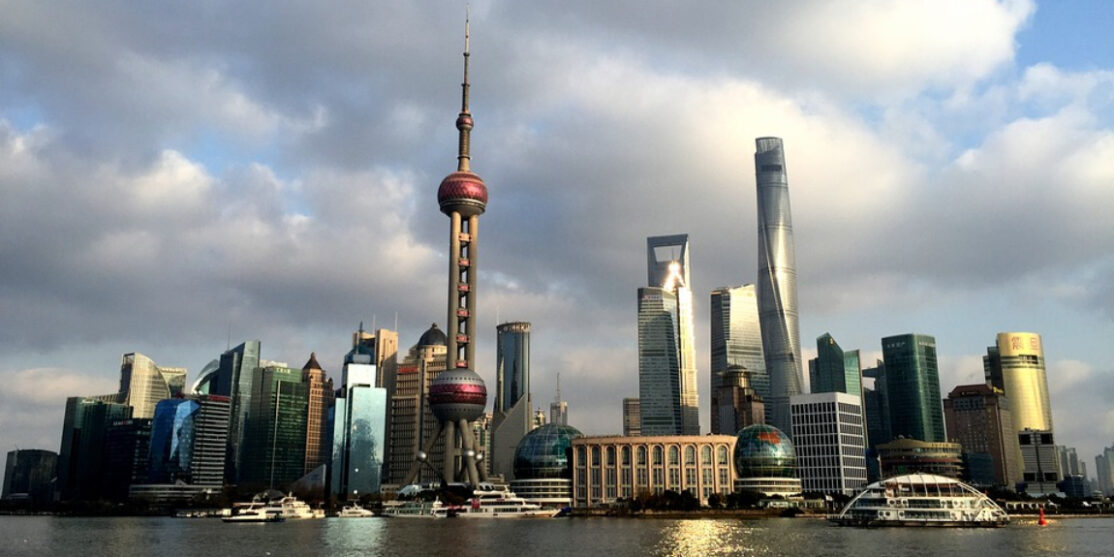EUROPA

In fuga dalla guerra. Una testimonianza dal confine polacco
Milioni di persone stanno scappando dal conflitto iniziato da Putin, ricevendo accoglienza in contesti come quello polacco che negli ultimi tempi non sono stati affatto solidali coi migranti
Quando arriviamo in Polonia sembra che il tempo si sia fermato. Il viaggio, organizzato dall’associazione no-profit torinese Pulmino Verde, è stato lungo – la prossima volta andiamo in aereo, ci diciamo. Un ragazzo incontrato in una stazione di servizio polacca ci aveva parlato di un centro umanitario di accoglienza, dove lui stava andando per offrire passaggi verso l’Austria. Dopo aver scaricato gli scatoloni al punto di raccolta della Caritas, ci siamo diretti lì.
Tutto sembrava perfettamente organizzato, quasi surreale. Una donna sorridente con la pettorina gialla ci indica il capannone dove avremmo dovuto registrarci come volontari. Lì ci dicono di tornare in serata, per poter dare il nostro contributo solo al mattino successivo. Questa organizzazione logistica mi sorprende, positivamente credo. Un sistema concreto e funzionante di soccorso umanitario può esistere. Mi guardo intorno.
Siamo circondati da autobus provenienti da tutto il mondo per portare donazioni e offrire passaggi alle persone in fuga. Ci sono decine di giornalisti con le telecamere puntate sui banconi con thermos di tè e pentole di goulash bollente.
«Ho provato delle sensazioni particolari», mi racconta Roberto del Pulmino Verde. «Il nostro ultimo viaggio al confine è stato prima della pandemia, in un mondo letteralmente differente. Andammo in Bosnia, un piccolo stato che rappresenta l’imbuto in cui si fermano decine di migliaia di persone provenienti dall’Afghanistan, dall’India, dalla Tunisia, dall’Egitto… Attraversano la Croazia e la Slovenia per arrivare in Italia e in Germania. In Bosnia abbiamo incontrato il tentativo disperato di persone che hanno perso tutto, attraversato a piedi i confini per trovare un futuro e non ricevono la giusta accoglienza. Abbiamo visto anche i segni di calci, pugni, manganellate, provocati dai militari croati al confine. Abbiamo visto persone deprivate della dignità».
Le immagini che inconsciamente si sovrappongono e scorrono veloci davanti ai miei occhi sono quelle a cui la narrazione mediatica ci sottopone di continuo. Quelle stesse immagini di dolore e lontananza che contribuiscono a dare forma a un immaginario comune: chi scappa da una guerra porta ferite visibili sul corpo, indossa abiti deteriorati – per cui accetterebbe qualunque straccio “donato” – e, soprattutto, non è bianco. Attribuire al disagio dei connotati fisici ben precisi, diversi e distanti. Empatizzare con un dolore che ha un aspetto più simile al nostro. Perché?
Dopo pranzo, ci dirigiamo verso la stazione di Przemysl. Mentre camminiamo, Fernanda Torre (presidentessa dell’associazione) mi dice: «I migranti ci sono ma non si vedono». Ai binari, però si vedono eccome.
«Gente che corre, su e giù, che spaziano tra la folla per prendere il treno. Io l’ho trovato caotico e mi ha ricordato la stazione di Dobova, in Slovenia», continua Fernanda. «Lì, i migranti arrivavano e venivano divisi in categorie: donne, uomini e bambini. A Przemysl ho visto un uomo con un bambino, poi ho notato che non aveva due dita». Una coppia siede sulla panchina; ha con sé un gatto anziano come loro. Sono stanchi, tutti e tre. Parlo con Anna, una volontaria per la Società di Cura degli Animali in Polonia. «Gli animali sono membri delle famiglie che scappano dall’Ucraina e anche loro hanno bisogno di supporto, oltre che del passaporto».

Una famiglia curda viene respinta e, a un centinaio di chilometri di distanza, cioccolata calda viene offerta ai bambini ucraini. Una ragazza polacca regala un libro a un bambino con una giacca blu e il cappellino di lana rosso. Lui esulta e saltella intorno alla mamma. Sono tante le donne che fuggono dalla guerra con i figli. Pochi gli uomini che sono lì con loro. Incontro Sabino, un operatore del Servizio di Emergenza Sanitaria di Frigento, in provincia di Avellino: «Siamo arrivati stamattina a Medyka con beni di prima necessità, medicinali, vestiti e alimenti. Poi, ci siamo spostati a Przemysl per offrire un passaggio alle persone che vogliono venire in Italia. Per il momento sono 15. Nessuno di loro ha conoscenti o parenti in Italia e sono principalmente donne e bambini».
Siamo saliti sul nostro van, diretti anche noi verso Medyka. Ci sentiamo confusi, anche un po’ interdetti. Ripenso al goulash e alla famiglia curda. Arriviamo al confine con l’Ucraina, a Medyka. Fa freddo, c’è un odore acre che punge alla gola. Più di 1500 persone attendono il loro autobus in una fila composta, ordinata.
Una bambina seduta sul retro di un bus – grigio come i capelli della signora che le siede a fianco – mi saluta agitando lievemente la mano. Io ricambio il gesto, sorridendo. So che quella bambina potrà, pian piano, ricostruire la sua vita altrove. Un improvviso senso di nostalgia mi travolge al pensiero che la signora con i capelli grigi potrebbe aver perso tutto ciò che aveva già costruito.
Spazio al mutuo supporto: Foundation UNITATEM
Il giorno seguente, la sveglia suona alle 7.30. Mezz’ora dopo saliamo sul pulmino per raggiungere Jarosław, a pochi chilometri dal confine. Letti a castello, materassi e piumoni acquistati con le donazioni, sono stati inviati alla Foundation UNITATEM, un’associazione che offre ai rifugiati di guerra una casa sicura e supporto a lungo termine.
Saliamo due rampe di scale e percorriamo un corridoio con tante stanze su entrambi i lati. Gli stendini fuori le porte e i passeggini vuoti. Entriamo nell’ufficio dove Kamil lavora con Patrik, Sir John Laundry – nome d’arte di Mitch – e gli altri volontari. Gli occhi sorridenti, le battute irriverenti – «essenziali per poter fare questo lavoro», dice Kamil – e sei tazzone di regular coffee ci accolgono in una stanza ampia. Il tavolo in legno, i divanetti bassi, le foto alle pareti colorate e Beautiful l’iguana, la mascotte della casa.
Kamil fa un’eccezione e ci porta a vedere le altre due strutture della warehouse. Non lo fa quasi mai, perché non vuole far sentire le persone «come delle scimmie in gabbia», ma ha voglia di condividere con noi il lavoro che stanno portando avanti tutti insieme. Chi ospita insieme a chi viene ospitato.
«Tutto è cominciato tre settimane fa, quando l’invasione dell’Ucraina è iniziata», mi racconta Kamil. «Il mio amico Patrik ha deciso di aprire casa di sua nonna, adattando le stanze alle esigenze delle persone che cercavano accoglienza. Quando la situazione ha cominciato a degenerare, avevamo bisogno di più spazio. Il comune ci ha dato in concessione l’edificio di una scuola – dove ci sono al momento 220 madri con i loro bambini. I bisogni erano però sempre più grandi ed era necessario aprire un altro spazio. Abbiamo ristrutturato un dormitorio in disuso da 20 anni, che può ospitare più di 700 persone. Per fortuna, Patrik conosce dei professionisti nel campo dell’edilizia che hanno fatto i lavori più importanti, dall’elettricità al riscaldamento. Poi, un gruppo di volontari si è impegnato per fornire servizi alle persone accolte, dall’animazione per i bambini all’arredamento delle stanze per renderle il più confortevoli possibile».

Camminiamo per i corridoi affollati. Un bambino sistema con serietà il latte in polvere sugli scaffali; due ragazze entusiaste scaricano alcuni materassi da un camion; una signora bionda tiene suo figlio sulle gambe e fissa il vuoto. Matias monta uno dei letti a castello in legno chiaro. Un mese fa, è venuto in Polonia per pochi giorni, a portare beni di prima necessità con il suo furgoncino. Ritornato a casa, sull’isola d’Elba, ha capito che il suo posto era a Jaroslaw. Ed eccolo lì, con un foglietto arancione su cui ha appuntato le frasi in polacco essenziali. «Ho visto il confine, ho parlato con i rifugiati… Quando sono tornato a casa, non stavo bene. Uscivo a bere una birra e non facevo altro che ripetermi che qui sarei potuto essere d’aiuto. Per questo ho deciso di tornare», mi dice. «Questo edificio era abbandonato. Hanno pitturato tutto, riempito le stanze, rifatto i bagni e la cucina… L’hanno reso vivibile in pochissimo tempo. Alcune donne ieri hanno organizzato un karaoke; poi puliscono, cucinano… Questa è casa loro adesso e se ne prendono cura».
In questo posto, l’assistenzialismo ha fatto spazio al mutualismo. Oltre ai letti e alle cure mediche, l’associazione si impegna a offrire supporto psicologico, sostegno linguistico, educazione scolastica, laboratori extracurriculari, attivazione professionale e corsi di formazione retribuiti.
«Se non investiamo attivamente in questa area, ci saranno ulteriori problemi in futuro. Sogniamo una realtà in cui le aziende assumano donne polacche e ucraine, senza distinzioni. Vogliamo creare nuovi posti di lavoro e offrire corsi di formazione retribuiti, così da non creare una situazione ghettizzante per le persone in arrivo dall’Ucraina, coinvolgerle attivamente e dare loro degli stimoli per iniziare una nuova vita», continua Kamil.
L’obiettivo che l’associazione persegue nel lungo periodo è evitare l’esclusione sociale per entrambe le comunità locali coinvolte, quella ucraina e anche quella polacca. «Se la situazione perdura a lungo, ci sarà una tragedia umanitaria anche in Polonia, non solo in Ucraina. La società polacca è estremamente povera e sarà difficile spartire l’ultimo pezzo di pane con le migliaia di persone che arriveranno. Per questo motivo, è essenziale la collaborazione», racconta Kamil con sguardo fiero e dolce. «Patrik ha donato molto per i lavori, ma il resto è stato raccolto grazie alle donazioni delle persone. Due settimane fa, avevamo un gran bisogno di materassi. Ho chiamato un amico che ha un’azienda che produce materassi e lui mi ha risposto: “Scusa, è piena notte e non posso parlare”. Dopo tre minuti, mi chiama per dirmi che non poteva parlare perché stava caricando 140 materassi sul suo camion. Otto ore dopo era qui e aveva portato anche 200 pagnotte di pane. Tutte le persone si sono attivate, in base alle loro possibilità… Alcune signore anziane hanno donato chili di mele e centinaia di camion dall’Italia sono arrivati con scatoloni pieni di beni di prima necessità. Ma non possiamo contare solo sull’aiuto spontaneo degli altri; è necessario avere un supporto istituzionale, che possa rendere il tutto più sostenibile e agile. Dobbiamo poter avere la possibilità di reagire velocemente ai bisogni delle persone. Preparati al peggio e spera per il meglio. Noi speriamo che la guerra finisca presto e non vogliamo privare le persone di questa speranza. Oggi, aiutiamo i rifugiati; domani, potremmo essere noi a chiedere aiuto. Dobbiamo essere preparati».
Da Jaroslaw, ci siamo spostati a Cieszanow, al punto di raccolta del cibo. Confezioni di bottiglie d’acqua incorniciano l’ingresso al capannone. Scarichiamo il nostro pulmino: pasta, olio, omogeneizzati, legumi e carne in scatola. Il sole inizia a tramontare, c’è un’aria fresca e serena. Gli operatori e le operatrici sembrano instancabili.
Un sottofondo musicale accompagna i loro movimenti precisi, ormai meccanici. Scattiamo una foto insieme e la inviamo a uno dei volontari che ci ha aiutato con i pacchi. «Siamo felici di condividere sui nostri social la solidarietà».

Aiuti umanitari: tra interesse e cura
L’ultima tappa della nostra breve permanenza in Polonia è Korczowa, un ex centro commerciale adibito a centro umanitario per chi fugge. L’edificio dista pochi minuti di auto dalla frontiera ed è enorme: può ospitare più di 7mila persone e l’unico modo per raggiungerlo è con mezzi privati, perché non c’è una stazione.
Molte persone provenienti da tutta Europa offrono passaggi verso l’Italia, la Germania, la Finlandia, la Svezia… Ma non tutti i rifugiati hanno intenzione di andar via. Più ci si allontana, più la guerra diventa reale. La percezione che molti hanno è di temporaneità. Alice, un’operatrice medica, spiega che il passaggio in Polonia è rallentato negli ultimi giorni proprio per questo motivo. Le persone hanno scelto di rimanere a L’viv, nella speranza di poter riappropriarsi presto del loro diritto alla quotidianità. «Nei primi giorni c’erano 7 mila persone; la maggior parte, restava poche ore per riposare e poi ripartire. Altri si fermavano due o tre notti. Adesso la situazione è molto cambiata».
Un bambino gioca a calcio, da solo. La maggiore di tre sorelle coccola la più piccola e le dà un bacio sulla testa, mentre le accarezza il viso. Tre uomini passeggiano nei corridoi affollati, tra le brandine e le coperte di lana. In un passeggino, un neonato dorme e sembra sereno. Sono residenti in Ucraina, ma pochi sono ucraini.
Ci sono molte persone di etnia rom e di nazionalità uzbeka e armena. Impossibile non avvertire un’atmosfera diversa da quella del centro di Medyka, dove chi aspettava in fila sapeva che, prima o poi, un autobus lo avrebbe portato lontano da lì. «Il centro di accoglienza di Korczowa è molto più simile a quello che abbiamo visto in Bosnia due anni fa», mi dice Chiara, raggiungendo la macchina a passo svelto.
Dopo il viaggio, non ho trovato risposte ma solo nuove domande. Il piano emotivo si intreccia con quello socio-politico e porta alla luce una complessità che deve necessariamente essere indagata per garantire la libertà di tutti e restituire dignità a chi, a causa della guerra – ogni guerra – ne è stato privato. Ripenso alle decine di autobus nei centri di accoglienza, ai giornalisti e ai gruppi Telegram dedicati esclusivamente all’Ucraina. Alle donazioni e alle manifestazioni per la pace.
Mi chiedo che senso abbia avvolgersi nella bandiera della pace e urlare motti al megafono. Mi dico che, per me, è un bel modo per rivendicare il diritto alla quotidianità, quando questa viene interrotta dalla guerra. Ripenso alla famiglia curda e al goulash caldo.
Alle donne e ai bambini provenienti da Siria, Iraq, Yemen e Afghanistan, bloccati al confine con la Bielorussia, al freddo. Nella stazione di Przemysl, Marco ha incontrato un volontario polacco dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che gli ha detto: «If you are white and Ukrainian, it’s okay».
Tutte le immagini di Benedetta Pisani