approfondimenti
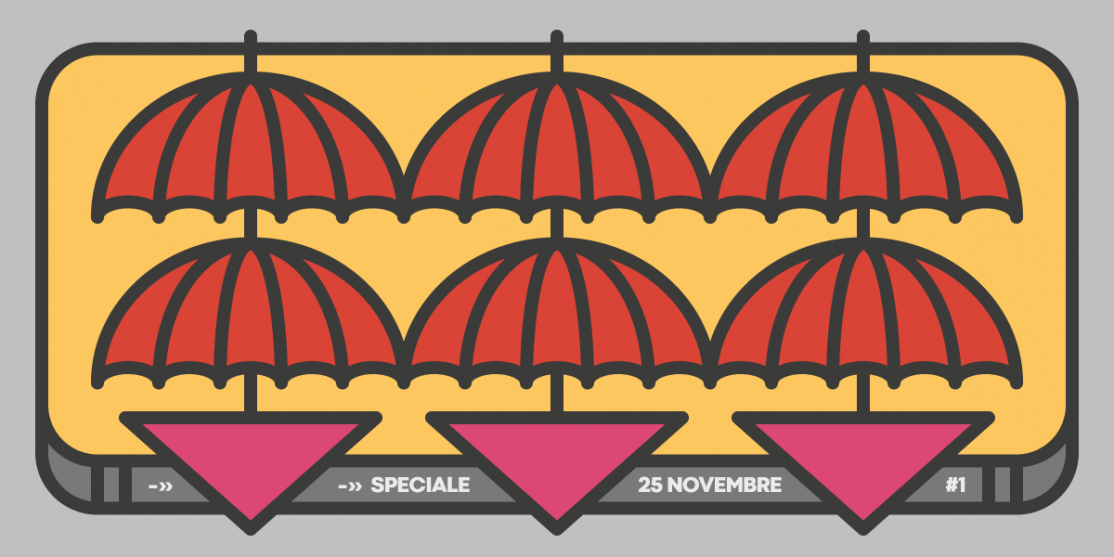
CULT
Il sesso al lavoro
Di sex work si parla poco e male, un lavoro che non viene considerato tale, continuamente stigmatizzato, criminalizzato e privo di diritti. Per questo “Prostitute in rivolta” di Molly Smith e Juno Macè un libro necessario per aprire una nuova discussione sul lavoro sessuale. Una recensione che apre lo speciale verso la manifestazione del 26 novembre contro la violenza patriarcale
Nel 2022 finalmente è arrivato anche in Italia uno dei testi cardine dei movimenti di lavoratrici del sesso di tutto il mondo, scritto nel 2018 da Molly Smith e Juno Mac, professione sex worker. Tradotto da Chiara Flaminio, con prefazione di Barbara Bonomi Romagnoli e Giulia Garofalo Geymonat e con postfazione di Ombre Rosse, edito dalla casa editrice Tamu.
È uscito da poco e già questo libro crea scompiglio! È di pochi giorni fa infatti la notizia dell’identificazione e della minaccia di segnalazione e conseguente denuncia per occupazione toccata a un’attivista che avrebbe dovuto tenere la presentazione del libro nello spazio del Campetto Occupato di Giulianova, organizzata tra gli altri dal collettivo femminista “Le malelingue”. La polizia ha cercato dunque, come da tradizione, di bloccare o in ogni caso ostacolare un momento pubblico di discussione a partire da un libro che tratta di sex work in un’ottica pro-sex, critica e intersezionale, mettendo al centro della sua analisi chi fa lavoro sessuale adesso, nelle sue tante e ramificate sfumature, condizioni materiali, linee di privilegio, genere, colore e classe.
Perché mai il volume Prostitute in rivolta fa così paura? Qual è la sua portata innovativa e radicale nel campo delle lotte sul sex work?
Il libro dello scandalo apre così:
«Le sex worker sono dappertutto. Siamo le tue vicine di casa. Ti passiamo accanto per strada. I nostri figli vanno a scuola con i tuoi. Siamo in fila dietro di te alla cassa (…). Ci sono persone che vendono sesso nella tua mensa aziendale, all’interno del tuo partito politico, nella sala d’attesa del tuo medico di famiglia, nel tuo luogo di culto. Ci sono sex worker incarcerate nei centri di detenzione per migranti e sex worker che protestano al di fuori di essi».
Eppure, sebbene le nostre vite, anche inconsapevolmente, siano immerse nel lavoro sessuale, parlare di prostituzione ci provoca ancora inquietudine, voglia di cambiare discorso o di liquidare il tutto con semplici analisi che odorano di abolizionismo, maschilismo di ritorno e di una certa timidezza nel prendere un vero e concreto posizionamento a fianco di chi, da Civitanova a tutto il mondo, sostiene e lotta a partire dalle proprie condizioni di vita materiali e non da simboli astratti e maledettamente teorici.
La prostituzione infatti si può definire come un prisma[1], un cristallo dalle mille facce che rimanda continuamente ad altri focus come il corpo, il fantomatico ruolo della Donna, il patriarcato, il sistema riproduttivo capitalista, le frontiere e le politiche migratorie, la violenza, la povertà, la guerra alla droga, le politiche sul lavoro e via così…
Come detto anche nella prefazione del libro il lavoro sessuale è da intendersi come «una cassaforte in cui la società ripone le proprie ansie e paure più profonde». Non è affatto un caso se il vecchio San Tommaso D’Aquino definisse la donna pubblica (la prostituta) come cloaca[2], indispensabile perché pattumiera di tutte le sporcizie della casa, o meglio dell’uomo. Fedele a questo ragionamento la Chiesa cattolica ha da sempre condannato e cercato di limitare la prostituzione ritenendo però impossibile sradicarla del tutto, perché in realtà necessaria a placare gli istinti bassi e turpi degli uomini.
Un tempo, e a volte ancora, le prostitute erano segnate da determinati simboli o colori che le identificassero e le tenessero lontane dalle altre. Lo stigma definisce un limite tra ciò che si può e ciò che non si può essere o rappresentare, dunque per evitare il pericolo di essere trattate come una puttana le altre donne si terranno a distanza da una supposta lavoratrice sessuale, pena lo stigma, simbolo da cui non si scappa e che isola e uccide.
Spesso chi parla di sex work, dai contesti istituzionali alle pubblicazioni accademiche, dagli spazi di movimento alle chiacchiere private lo intende dunque come luogo metaforico e non come luogo di lavoro materiale.
Partendo dallo schierarsi dalla parte di chi di sex work vive Prostitute in rivolta si pone fuori dalla vecchia, ma sempre rinnovata, diatriba tra femministe carcerarie o puritane SWERF (sex worker escludenti) e femministe sex positive che a volte rischiano di invisibilizzare, minimizzare o negare con i loro vissuti da “imprenditrici di se stesse” le esperienze di abuso vissute da altre nell’industria del sesso.
Se le une si rifanno all’immagine della prostituta immaginaria, sporca e malata per definizione, fonte di pericolo per le donne per bene, le altresi riattaccano all’idea altrettanto astratta di professionista erotica che vive il sesso come vocazione e come produttività, dunque che non parla di salario o di diritti, perché rischierebbe di rovinare l’armonia con il cliente apparendo cinica e troppo materiale. Pare brutto parlare di diritti sul lavoro se quel che faccio è dettato dalla passione, no?
Questo scritto invece finalmente sposta il focus sulle conseguenze materiali dei tanti e diversi posizionamenti ideologici e dei sistemi legislativi e repressivi che hanno cercato di gestire e regolare il lavoro sessuale nel mondo, spesso ispirati e giustificati proprio da idee e interessi tinti di femminismo. Parliamo dunque di puttane infelici, soggettività a cui lo spazio di parola e di lotta è precluso perché predominano sempre le retoriche sempliciste della puttana felice – e senza problemi – e della donna ex-prostituta, unica vera vittima da opporre invece a chi sceglie – per circostanze, direbbero le autrici del libro – questo lavoro.
Affascinante poi notare come i programmi di fuoriuscita messi su da Ong anti-prostituzione siano spesso volti a ricostruire la purezza – e bianchezza – della donna salvata, sempre votata alla gratuità del proprio lavoro, indirizzata a corsi di yoga, cura della casa, cucito, creazione di candele e oreficeria[3], o pagati meno del salario minimo o direttamente gratuiti[4]. Che strane invece queste sex worker che lavorano innanzitutto per soldi, ma che mercenarie signora mia!
Il punto è che, comunque la si pensi, la sex worker infelice, per determinate condizioni e necessità economiche, sceglierà sempre di tornare al suo lavoro, sebbene sappia benissimo che il contesto materiale e strutturale in cui insiste la propria professione siano fonte di violenza, come sa benissimo che la propria attività se criminalizzata – o legalizzata solo per alcune e seguendo strettissime regole – diventi sorgente di conseguenti ricatti da parte dello Stato e della Polizia, due entità che invece, secondo alcuni sistemi legislativi di controllo sul sex work (e anche secondo alcune femministe!) dovrebbero proteggerle.
Si sceglie sempre la sopravvivenza invece di un’uscita nobile dal mercato del sesso, consapevoli che il capitalismo non scomparirà grazie un incantesimo populista e dalla patina femminista che non guardi innanzitutto al benessere, alla tutela dei diritti e della sicurezza di chi ora svolge lavoro sessuale alle varie latitudini del mondo.
«Credermi quando racconto di essere stata violentata significa anche credermi quando insisto che non è successo»[5].
Un altro punto, tra i tantissimi, che mi preme ricordare è la possibilità per una persona che fa sex work di dare o togliere il proprio consenso, rivendicazione propria dei movimenti transfemministi in giro per il mondo, ma affatto scontata se si tratta di lavoro sessuale. Se le femministe abolizioniste intendono la prostituzione sempre e solo come stupro, è importante ribadire che vendere sesso non equivale a far acquistare il consenso della lavoratrice al cliente. Non si cessa di far rispettare i propri diritti e i propri limiti in cambio di denaro, che si tratti di lavoro sessuale o di qualsiasi altro lavoro, no?
Il fatto che difficilmente una persona che fa sex work vada a denunciare un cliente è legato a molti fattori: in primis il fatto che, lavoratrice sessuale o no, in ogni caso non veniamo mai credute e prese sul serio dagli apparati statali – come dai contesti familiari o amicali – in più il peso dello stigma della puttana sommato a quella della vittima di stupro, il rischio concreto di subire perquisizioni, denunce o sfratti da parte della Polizia che in teoria dovrebbe tutelarci. Allo stesso tempo una denuncia potrebbe portare a rallentare o bloccare le procedure per il proprio permesso di soggiorno o addirittura agevolare quelle di rimpatrio forzato.
Se non intendiamo il sex work come lavoro ma come mero atto di penetrazione che di per sé degrada la persona penetrata (dunque dominata, secondo questo sistema di pensiero) allora gli abusi sulle sex worker saranno sempre normalizzati. Allo stesso modo, se intendiamo una cagna non a pagamento[6], cioè una donna sessualmente libera e emancipata, come una ragazza con cui puoi provarci sempre e comunque perché “tanto ci sta”, il fatto che prima o poi venga stuprata fila, è coerente con come è fatta, e da lì al “se l’è andata a cercare” il passo è breve.
Ritenere dunque il sex work come lavoro, serve anche a permettere alle sex workers di avere la visibilità e la legittimità per prendere parola e denunciare gli eventuali abusi subiti.
Allo stesso modo anche le sex workers consumatrici di sostanze illecite rischiano su due fronti e spesso proprio le pratiche di mutuo aiuto, come stare in gruppo attirano l’attenzione della Polizia o di regolamenti locali o statali che le spingono sempre più in spazi di lavoro isolati e pericolosi. Rischiano l’arresto portando con sé materiale sterile (come le siringhe, gli aghi…) o un numero elevato di preservativi (spesso anche solo più di due).

Immagine da pagina fb OmbreRosse
Non per ordine di importanza c’è infine il tema dei confini.
Spesso quando si parla di prostituzione si tende a marcare una linea chiara tra sex work così detto “volontario” e tratta del sesso, questo confine è invece più poroso di quel che sembra. Non si può parlare di sesso commerciale senza prima parlare di migrazione illegale o irregolare (non più regolare).
L’assunto di Prostitute in rivolta e delle rivendicazioni dei gruppi organizzati di sex worker, tra cui Ombre Rosse in Italia, è proprio che non si può guardare al sesso commerciale senza prima considerare i confini e le frontiere e chi e come li costruisce e rafforza. La retorica sulla tratta che vede come vittime le donne trafficate al fine di sfruttamento sessuale, prive di volontà e inermi, non aiuta di certo chi è rimasto intrappolato in queste dinamiche di ricatto e di mancanza di alternative concrete, dato che innanzitutto non riconosce la loro volontà e il loro progetto di migrare. Basterebbe intanto permettere di muoversi legalmente e con dei diritti, senza innalzare frontiere che rendono le persone sempre più vulnerabili e dunque facilmente ricattabili da trafficanti, passeurs o scafisti fuori dal paese di arrivo, o da daddy, manager, affittuari o dalla polizia una volta arrivate a destinazione.
La criminalizzazione dell’immigrazione illegale, le pene sempre più pesanti e lo spendere fior fior di soldi in nuove frontiere non protegge anzi rende più fragili e senza voce chi si trova in queste situazioni. Esattamente come funziona per l’aborto: criminalizzare la pratica dell’IVG non fa scomparire gli aborti, li rende solo più pericolosi e sempre più costosi, costruendo una continua scala tra chi può e chi non può. Continuare a parlare di vittima di tratta senza rendere più complesso il quadro è anch’esso un fare astratto che non aiuta e anzi mina la possibile agency di chi è caduto in reti di sfruttamento e violenza.
De-criminalizzare – e non legalizzare – il sex work, oltre la linea della cittadinanza, e riconoscere il diritto universale alla libertà di movimento invece sarebbe un primo passo per tutelare, far sopravvivere, far acquisire dei diritti e delle tutele a chi fa sex work, rendendo lecita finalmente la solidarietà tra colleghe, vera e propria fonte di potere per le sex worker: reti di sorellanza sempre osteggiate da qualunque sistema legislativo che non de-criminalizzi il sex work.
Un potere che però sfugge dal concetto di empowerment femminile, visto come un vero e proprio depistaggio da Mac e Smith che infatti propongono un sistema di depenalizzazione del sex work basato su risorse concrete, diritti del lavoro, servizi di assistenza, previdenza sociale, alloggi dal costo basso, supporto per madri single, servizi di riduzione del danno e sussidi.
C’è da chiedersi cosa succederà nei prossimi tempi nel nostro paese, quando fino a pochi mesi fa si parlava dell’introduzione del modello di criminalizzazione nordico anche qui. Proprio oggi vediamo una Ministra antiabortista alla Famiglia e alla Natalità o un Prefetto agli Interni, per citarne solo due. Sempre oggi infatti le femministe radicali nostrane (sostenitrici del modello citato), con in testa Marina Terragni, esultano e fanno gli auguri alla prima donna Presidente del Consiglio del Governo italiano. Il cerchio si è chiuso.
Rompiamolo tuttə insieme!
1 Gail Pheterson, The Prostitution Prism, Amsterdam University Press; First edition, 1996
2 San Tommaso d’Aquino, De Regimine Principum IV, 14
3 Si vedano i progetti Escape to Peace o The Butterfly Project
4 Nel 2013 Turn Off the Red Light, consorzio di ONG anti-prostituzione, offriva stage retribuiti per meno del salario minimo
5 Nikita, sex worker all’assemblea generale annuale di Amnesty International Uk nel 2007
6 Diventare cagna, Itziar Ziga. D Editore, 2000
Immagine di copertina Vittorio Giannitelli
