cult

CULT
György Lukács, Lenin
Delle pagine, assai potenti, che Lukács dedica a Lenin nel febbraio del 1924, ne scegliamo solo alcune. Quelle in cui viene tratteggiata la nozione di ‘attualità della rivoluzione’: «l’idea fondamentale di Lenin», chiarisce Lukács, «il punto che lo collega decisamente a Marx». Per il materialismo storico, infatti, l’attualità della rivoluzione è il presupposto, «la base oggettiva dell’intera epoca e insieme il necessario punto di vista per la sua comprensione». Ciò significa che si può realizzare la rivoluzione proletaria «a piacere in qualsiasi momento»? Evidentemente no. Sia per Marx che per Lenin, però, l’attualità della rivoluzione è stata «l’unità di misura per la risoluzione di ogni questione particolare», «lo sfondo di un’intera epoca». Non una norma, o una necessità, ma una tendenza che dilania materialmente il capitalismo. Forzando un po’, ma neanche troppo: l’epoca del capitalismo – dello sfruttamento senza posa della forza-lavoro, del furto di pluslavoro, dell’estrazione di plusvalore assoluto e relativo – è quella in cui la rivoluzione è «imminente», «all’ordine del giorno».
Ecco allora che, alla luce di queste definizioni, Lukács presenta la teoria leniniana dell’organizzazione, del partito. Contrariamente a quanto la vulgata (con o contro Lenin) ancora oggi non smette di blaterare, «anche il più grande e il migliore partito del mondo non può ‘fare’ da sé alcuna rivoluzione». Proprio perché, invece, «il carattere fondamentale del periodo è rivoluzionario, una situazione acutamente rivoluzionaria può presentarsi in ogni momento» [corsivo nostro]. Ovvio, le circostanze non possono essere anticipate (dal partito) con precisione. Palesi semmai sono le forze che ostacolano l’avvento della rivoluzione, così come «le linee fondamentali di un’azione adeguata a tale avvento». In questo campo polemico, in cui nulla è necessario ma in cui nulla compare dal nulla, si inserisce l’organizzazione. Il partito non fa la rivoluzione, ma la prepara. La produce – accelerando le tendenze già in campo, già inscritte nei comportamenti di classe, nelle rotture singolari – e, al tempo stesso, da essa viene prodotto, sempre di nuovo ridefinito.
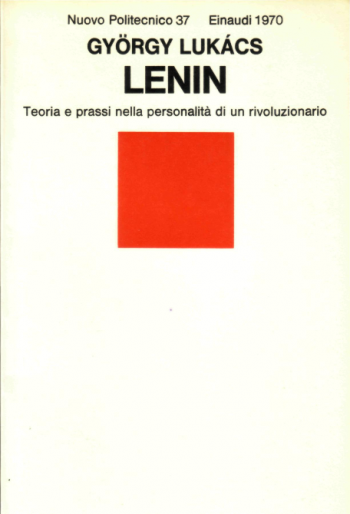
Il riferimento costante di queste pagine è L’estremismo malattia infantile del comunismo, le tante indicazioni che sul concetto di rivoluzione (e di partito) Lenin in quel pamphlet ci offre. E ce ne è una che più di altre colpisce, Lukács allora quanto noi tutti oggi. Si chiede Lenin: quando una rivoluzione può vincere? «Soltanto quando gli ‘strati inferiori’ non vogliono più il passato e gli ‘strati superiori’ non possono fare come per il passato». Ci vuole un trauma, una crisi trasversale, del basso come dell’alto. Una frattura che sia in grado, per un verso, di spostare il desiderio proletario, di esibire la violenza dello sfruttamento, di renderla insopportabile; per l’altro, di far vacillare e scomporre l’omogeneità del comando capitalistico. Nella faglia, l’azione di partito: pragmatica, mai ideologica, di certo non utopica. L’azione capace di cogliere le potenzialità di una piccola breccia, di una deviazione imprevista.
«In realtà non vi è un solo attimo che non rechi con sé la propria chance rivoluzionaria – essa richiede soltanto di essere intesa come una chance specifica, ossia come chance di una soluzione del tutto nuova, prescritta da un compito del tutto nuovo»: così ha scritto un altro filosofo che della Jetztzeit ha fatto l’elemento decisivo del suo materialismo storico, Walter Benjamin. La ‘novità’ della rivoluzione coincide con l’interruzione del sempre uguale dell’oppressione capitalistica – o, altra faccia della medesima medaglia, dell’epopea cuorcontenta degli adoratori del progresso. Eppure, la possibilità stessa di una tale cesura critica non è data da una completa liquidazione del passato, ma da un rapporto «del tutto nuovo» con esso. In questione è uno sguardo, selettivo e di classe, capace di sbirciare nella stanza del determinato frammento del già stato che, nella situazione rivoluzionaria, riemerge per comporsi secondo ordini inediti con l’attimo presente. È lo sguardo che lascia retroagire il possibile sull’accaduto, che fa sì che il passato medesimo – un capitolo, una scheggia della storia degli oppressi – possa riaprirsi alla variazione, al riscatto. Questo sguardo si alimenta infatti dell’immagine degli «antenati asserviti», e mai dei «discendenti liberati». Un’immagine al tempo stesso carica di odio per gli sfruttatori e di amore per le generazioni di sfruttati. La «classe vendicatrice» non aspetta allora il tempo (infinito) della sua maturità, è, al contrario, in ogni momento matura per afferrare una simile congiuntura, per inserirsi nella piega di questo incontro (in)attuale e introdurre la differenza nella ripetizione, lo scarto traumatico della rivoluzione nell’eterno ritorno della catastrofe capitalistica.
