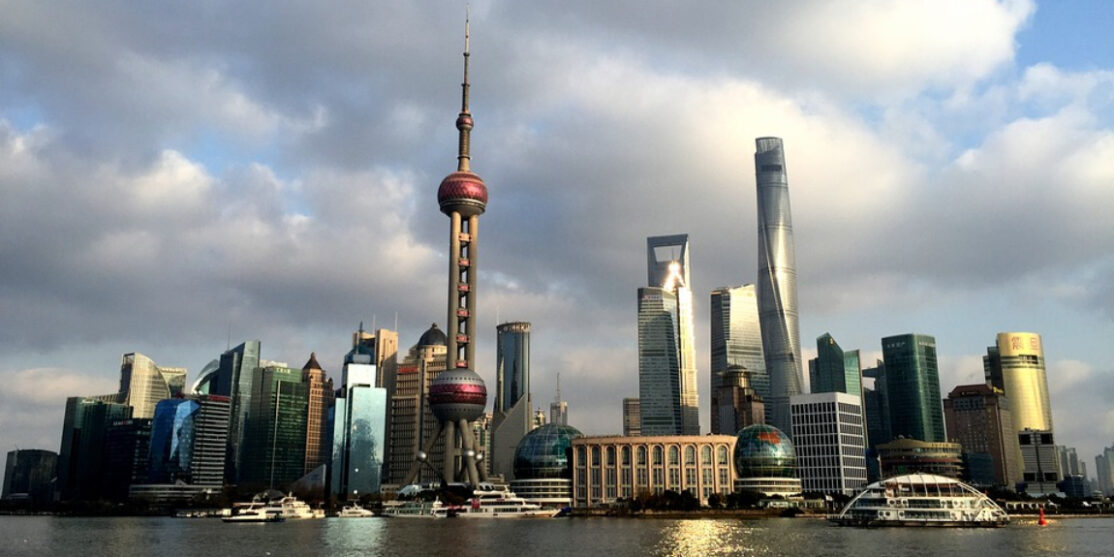ITALIA

«Il futuro del movimento ecologista è la convergenza tra disillusi e disincantati»
Emanuele Leonardi è ricercatore all’università di Coimbra e attivista di lungo corso sulle tematiche ambientali. Lo abbiamo incontrato al festival Alta Felicità in Val di Susa, in cui è stato protagonista di un panel sui movimenti sociali impegnati a fermare la catastrofe climatica. Gli abbiamo fatto qualche domanda sui temi caldi che il movimento ambientalista affronta in questo periodo
Avresti mai pensato, un anno fa, che il problema della giustizia climatica sarebbe diventato in così poco tempo da tema di nicchia (almeno in Italia) a movimento globale di queste proporzioni?
Non mi aspettavo un’esplosione di queste dimensioni, no. Si tratta di un evento che definirei epocale, anche se il processo di sedimentazione di questo movimento – anche della sua istituzionalizzazione – sarà un passaggio complicato e in un certo senso molto rischioso. Invece non mi ha troppo sorpreso la crisi della governance climatica, cioè l’innesco di questa mobilitazione. Chiunque si sia occupato di politica del clima nel contesto della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici dell’Onu aveva chiaro sentore delle difficoltà del sistema delle Cop (Conferenze delle Parti) a mantenere la “promessa” del Protocollo di Kyoto.
 La promessa era che il calo delle emissioni sarebbe stato prodotto da un aumento dei profitti nei settori “verdi”. L’idea di base – il supporter principale fu Al Gore – era questa: benché il riscaldamento globale sia stato un fallimento del mercato – storicamente incapace di contabilizzare le esternalità negative (in questo caso le emissioni di anidride carbonica) – a esso si può porre rimedio solo attraverso un’ulteriore ondata di mercatizzazione. Il fatto che dopo un decennio di implementazione questa idea-forza avesse mostrato la corda – un po’ di profitti nella sfera finanziaria c’erano, ma le emissioni erano aumentate enormememente – era chiaramente percepibile durante la Cop 21 nel 2015. Tuttavia l’Accordo di Parigi rilanciò la stessa scommessa. Fuori tempo massimo, però: era impossibile predire che il punto di rottura si sarebbe dato a Katowice durante la Cop 24 (da un lato il fronte negazionista guidato da Trump che sconfessa l’Ipcc, dall’altro Greta che simboleggia il ritiro della delega in bianco da parte del ceto medio globale che innerva le Ong), ma le criticità erano tutte lì.
La promessa era che il calo delle emissioni sarebbe stato prodotto da un aumento dei profitti nei settori “verdi”. L’idea di base – il supporter principale fu Al Gore – era questa: benché il riscaldamento globale sia stato un fallimento del mercato – storicamente incapace di contabilizzare le esternalità negative (in questo caso le emissioni di anidride carbonica) – a esso si può porre rimedio solo attraverso un’ulteriore ondata di mercatizzazione. Il fatto che dopo un decennio di implementazione questa idea-forza avesse mostrato la corda – un po’ di profitti nella sfera finanziaria c’erano, ma le emissioni erano aumentate enormememente – era chiaramente percepibile durante la Cop 21 nel 2015. Tuttavia l’Accordo di Parigi rilanciò la stessa scommessa. Fuori tempo massimo, però: era impossibile predire che il punto di rottura si sarebbe dato a Katowice durante la Cop 24 (da un lato il fronte negazionista guidato da Trump che sconfessa l’Ipcc, dall’altro Greta che simboleggia il ritiro della delega in bianco da parte del ceto medio globale che innerva le Ong), ma le criticità erano tutte lì.
In Italia il movimento ambientalista che vuole affrontare l’emergenza climatica ha attualmente due sviluppi. Uno è la versione italiana del Fridays for future, l’altro è una rinnovata coalizione tra i comitati in lotta contro le grandi opere. Qual è a tuo parere la ragione di questa biforcazione e quali margini vedi per una saldatura non solo tattica, come è stato nella primavera scorsa, ma anche strategica tra queste due anime?
Tenendo come sfondo la crisi della governance climatica accennata sopra, credo che all’interno del movimento si debba distinguere tra i disillusi del sistema delle Cop, cioè coloro che avevano creduto alla promessa della green economy e dopo quindici anni d’implementazione sono costretti ad ammetterne il fallimento, e i disincantati del governo climatico globale, cioè donne e uomini che non hanno mai nascosto il proprio scetticismo ma le cui ‘soluzioni’ al riscaldamento globale erano state oscurate dall’entusiasmo mainstream per i mercati verdi. Questi due sviluppi, per riprendere il termine che hai usato, sono parecchio diversi e la loro convergenza non può essere data per scontata.
I primi, guidati da Greta, propongono un triplice messaggio: delegittimazione delle élites; inversione del rapporto tra economia ed ecologia; incitamento all’azione diretta. Si tratta di un messaggio dirompente. Un messaggio che in Italia e nel mondo è stato rilanciato dai Fridays for future ed è risuonato fortissimo il 15 marzo, data del primo climate strike che ha visto scendere in piazza più di un milione e mezzo di persone in oltre 120 Paesi. Da notare la composizione generazionale: la nuova cultura ecologica emerge tra le pieghe comunicative e le reti sociali dei millenials. Sempre tra i disillusi possiamo annoverare il movimento Extinction rebellion, particolarmente attivo in Gran Bretagna ma ormai presente anche qui, la cui composizione è più variegata in termini generazionali, con maggiore esperienza militante (si scorge una linea di continuità con il ciclo alter-mondialista degli anni Duemila) ma piuttosto omogenea da un punto di vista sociale, essendo in gran parte animato da appartenenti al ceto medio altamente istruito (almeno per ora).
Il secondo sviluppo lo conosciamo meglio. Chi lo anima esprime una composizione sociale variegata il cui collante sono comitati locali molto legati a questioni specifiche ma ormai pronti a “comporsi” su scala allargata, come ha mostrato la riuscitissima manifestazione del 23 marzo. Sarebbe forse utile, a questo proposito, riflettere sul perché il primo tentativo di “composizione” – il Patto di mutuo soccorso contro tutte le nocività (2006/2007) – si sgonfiò quasi subito pur essendo nato sotto i migliori auspici. Spero che i collettivi che in Italia si occupano di ecologia politica trovino il tempo per affrontare questo nodo: ho l’impressione che si tratti di una questione importante, anche nell’ottica di quella saldatura non solo tattica ma pure strategica cui hai fatto riferimento.
Torno dunque alla domanda: la separazione “sociale” tra i due sviluppi mi pare essere nell’ordine delle cose. La loro convergenza “politica” è il terreno su cui credo si giocherà la tenuta del movimento. Due elementi mi sembrano rilevanti a questo proposito: da un lato lo scambio piuttosto fruttuoso che in alcune realtà si è già dato tra Fff e lotte territoriali – pensa solo al dibattito proprio qui al Festival dell’Alta Felicità, in cui esponenti Torinesi dei Fff hanno posto le basi per la costruzione di un fronte inclusivo di lotta climatica. Dall’altro la capacità (o meno) di inserire in questo fronte il mondo del lavoro: senza lavoratrici e lavoratori difficilmente il movimento per la giustizia climatica raggiungerà in tempi ragionevoli la massa critica necessaria per incidere sui processi decisionali.
La vicenda dei Gilet jaunes è emblematica della necessità di coniugare istanze ambientaliste e istanze sociali ed economiche. Se il conto da pagare per l’emergenza climatica lo pagano solo i poveri, non solo i risultati sono scarsi, ma pure il consenso sociale diminuisce. Quali sono i margini, dalla tua posizione di osservatore attento, affinché il movimento climatico italiano assuma anche la questione sociale e la prospettiva di classe?
La tua lettura del fenomeno dei Gilets jaunes mi sembra corretta – Reporterre li definisce “il primo movimento sociale ecologista di massa” – ma al momento assai poco diffusa. Conviene forse riproporne i caratteri salienti, magari facendo riferimento a un articolo molto interessante della Plateforme d’enquêtes militantes, che ha il merito di sgombrare il campo rispetto all’ipotesi più diffusa, quella che legge i gilet gialli come un movimento anti-ecologista, in ragione del fatto che si sia originato per opposizione alla proposta di innalzamento del prezzo del carburante attraverso una tassa sulla benzina. Per prima cosa va infatti segnalata la demarcazione politica del campo ecologista lungo l’asse della diseguaglianza sociale: il crollo della governance internazionale di cui sopra ha dei risvolti a livello di politica interna – specialmente laddove capi di stato e figure politiche di rilievo avevano fortemente investito nella scommessa della green economy. Il caso di Macron è esemplare. Macron, infatti, in seguito a una delle tante uscite negazioniste di Trump (quella del dicembre 2017), invitò gli scienziati americani a trasferirsi in Francia, nazione a suo avviso all’avanguardia nella lotta contro i cambiamenti climatici – memorabile la foto in cui dileggia The Donald reggendo un manifesto che recita: «Make our planet great again».
Meno di un anno dopo, a fronte dell’impossibilità di tradurre in pratica la scommessa teorica della green economy (cioè: salvaguardia ambientale come strategia di accumulazione capitalistica), Macron si è trovato nella situazione di dover scegliere a chi far pagare l’inizio di una transizione non più procrastinabile (e comunque molto nebulosa, allora come oggi). Senza sorpresa per nessuno, ha scelto gli strati più bassi della scala sociale. I gilet gialli sono dunque i sacrificati della crisi del governo climatico globale e quel che in sostanza dicono è che se si vuole fare la transizione ecologica sulla pelle di chi è già impoverito, questa transizione non interessa e verrà osteggiata. Interessa, eccome, se invece la pagano i ceti più abbienti, che sono poi quelli che stanno all’origine del problema. Insomma, mi sembra che i gilet gialli esprimano con fermezza un punto politico fondamentale: c’è una linea di demarcazione sociale nella causalità del cambiamento climatico, tale linea si riverbera nei suoi effetti ed è bene che la si indichi con esattezza anche laddove si parla (nella lingua del conflitto) di soluzioni. Alcune soluzioni privilegiano determinati interessi, altre li mettono in discussione.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di incanalare queste potenzialità espresse dai gilet gialli, ma anche dagli altri movimenti citati in precedenza, per arrivare a una convergenza che separi nettamente l’ecologia politica di classe dall’ecologia politica delle compatibilità sistemiche. Inoltre, è sempre attorno a questo nodo che si può porre in termini adeguati all’era del cambiamento climatico la questione del rapporto tra questione sociale e crisi ecologica, con la consapevolezza appunto che rispetto a quarant’anni fa, quando il tema emerse per la prima volta, le condizioni sono profondamente mutate. In questo senso il secondo punto discusso dalla Plateforme è decisivo perché mette in evidenza le forme di lotta dei gilet gialli (il blocco dei flussi, l’utilizzo del territorio in una forma alternativa rispetto a quello del sistema di circolazione e produzione delle merci) come un tentativo di assumere la centralità dei territori nella produzione di valore (e come una conseguenza del divenire politicamente rilevante della questione ecologica). Il loro obiettivo è quello di aggredire la produzione e la circolazione di valore laddove queste si danno in maniera più evidente che altrove. Una forma di lotta che aggredisce le modalità produttive contemporanee nei loro snodi fondamentali.
Ciò detto, non mi sottraggo alla parte difficile della domanda: la probabilità che il movimento italiano per la giustizia climatica assuma una prospettiva di classe al momento è scarsa. Tuttavia, due elementi inducono a non demordere: il primo riguarda la sorprendente diffusione del dibattito teorico sull’ecologia politica – impensabile anche solo un anno fa – che sembra indicare che finalmente i movimenti in Italia sono pronti ad assumere il tema come fondativo della propria azione militante. Il secondo è che in un contesto come quello italiano, in cui la lotta di classe si fa ma fatica a trovare rappresentanza politica, la relativa indefinitezza della cornice ideologica dei Fff potrebbe rivelarsi capace di catalizzare efficacemente l’energia dei conflitti sociali (in modi che ancora fatichiamo a immaginare).
Le proteste più grandi in questo anno dal nuovo governo le ha organizzate il movimento femminista, i Fridays for future e, in misura ridotta perché frammentato, il movimento antirazzista e antifascista. Ambientalismo e femminismo hanno molti tratti comuni, a partire dalla critica alla concentrazione del potere, ma anche alle forme e agli strumenti di decisione. Ci sono possibilità di avere una intersezionalità significativa tra questi due movimenti in Italia?
Sarei sorpreso del contrario. Come giustamente rilevi giustizia climatica e femminismo hanno molto in comune, rappresentano cioè quel che si potrebbe definire protagonismo della riproduzione sociale. Oltre agli elementi che richiami, credo sia molto significativo che tali movimenti si presentino immediatamente come globali e internazionalisti, sfuggendo così al dibattito un po’ stucchevole sul sovranismo o, nei casi migliori, riportandolo su binari politicamente espansivi e immediatamente capaci di innervare le mobilitazioni sociali.
Il mondo sindacale non è quasi mai stato un alleato dell’ambientalismo. Tuttavia la Cgil (come pure il Pd e altre anime “riformiste”) hanno corteggiato i Fridays for future, probabilmente per la loro faccia “pulita” e per il bisogno opportunista di intercettare i giovani. Ora però i Fff rilanciano e hanno chiesto ai sindacati di scioperare il 27 settembre. Cosa immagini che accadrà? Forse si metterà fine al gioco di usare Greta Thunberg come specchietto per le allodole?
Il tema è decisivo ma spinosissimo. Comincerei col distinguere due piani, correlati ma molto diversi. Il primo riguarda la memoria storica “di parte”: credo sia giunto il momento di liberarsi della narrazione tossica del lavoro come contrapposto all’ambiente. È un’interpretazione che assume come assodata e a-problematica la sconfitta del grande ciclo di conflitti a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta: niente di più falso. Se riprendiamo in mano la stagione delle lotte contro le nocività ci accorgiamo che in Italia la crisi ecologica è diventata questione politica dirimente grazie e non malgrado l‘azione del movimento operaio. Certo, ci sono tantissimi nodi da sciogliere – furono lotte di minoranze e al loro interno la divergenza tra liberazione “del” e liberazione “dal” lavoro salariato raggiunse il livello più alto – però rivendicare alla lotta di classe operaia un profondo protagonismo ecologico è storicamente vero e politicamente espansivo. En passant, sul tema offre spunti eccezionali la ricerca della storica Elena Davigo. In generale, credo occorra riaprire il campo di potenzialità scoperchiato da quei conflitti che repressione e sviluppo capitalistico hanno tentato di chiudere (fino a ora con un certo successo).
Il secondo piano di ragionamento riguarda la pratica sindacale odierna. Sarà in effetti interessante vedere cosa diranno le varie sigle a proposito del terzo sciopero per il clima del 27 settembre. Dal punto di vista dei confederali, un’adesione non formale potrebbe essere utile anche per rinnovare la base sindacale (sia dal punto di vista dei contenuti che da quello generazionale), quindi mi spingerei fino a esprimere un cauto ottimismo. Aggiungo inoltre che la proposta di un Green New Deal, per quanto non esente da ambiguità e limiti, potrebbe andare decisamente nella direzione di una saldatura ulteriore tra la giustizia climatica e il mondo del lavoro. Va comunque detto che il discrimine della diseguaglianza come fattore di politicizzazione del campo ecologico rimane il terreno su cui si gioca la possibilità del Green New Deal di porsi come discontinuità forte rispetto alla retorica della green economy. E a questo proposito il mio cauto ottimismo tende a scemare, considerata l’inspiegabile insistenza della Cgil (ma non solo) nel proporre parole d’ordine ormai bruciate come “sviluppo sostenibile”. Comunque, come accennato sopra, un campo politico indefinito è un campo politico aperto: a prescindere dal terzo climate strike, sarà la forza dei movimenti a spostare (o meno) il fronte sindacale verso una prospettiva di transizione ecologica dal e per il basso.
A questo link alcune delle pubblicazioni di Emanuele Leonardi