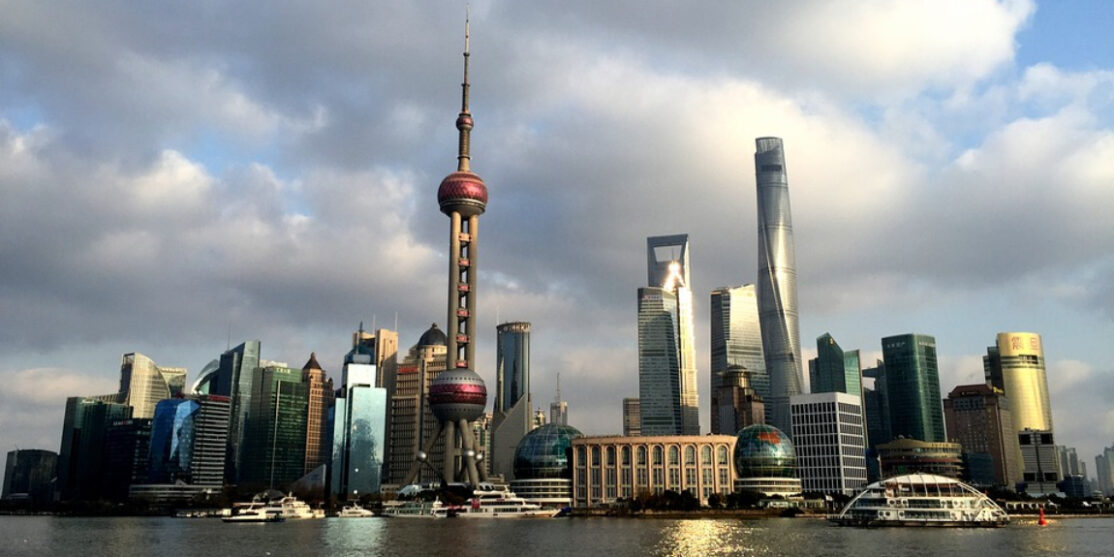ITALIA

Eddi Marcucci: «Una sentenza ideologica contro lo stato di diritto»
Intervista all’attivista torinese, a seguito della sentenza di appello sulla sorveglianza speciale a cui è sottoposta in Italia per il suo impegno nelle YPJ nella Siria del Nord
La sentenza è del 22 dicembre ed è la peggiore che ci si potesse aspettare. La Corte di Appello di Torino ha deciso di confermare la sorveglianza speciale nei confronti di Maria Edgarda ‘Eddi’ Marcucci, attivista rientrata da un periodo di permanenza in Siria del Nord, partecipando alle YPJ, contribuendo alla rivoluzione del Confederalismo Democratico e lottando contro le milizie dello Stato Islamico e dei suoi alleati. Nelle motivazioni, vengono elencati fatti per i quali l’attivismo di Eddi è stato segnalato dalla digos torinese – proteste sociali, antifasciste e in opposizione all’aggressione turca alla Siria del Nord ma che non hanno mai dato luogo a condanne. Eddi vive in uno stato di sorveglianza speciale pur essendo incensurata.
Contro la sentenza di primo grado e contro la persecuzione nei suoi confronti, contraria a ogni stato di diritto e basata su una gestione poliziesca e repressiva dell’attivismo sociale, si sono espressi giuristi, personaggi della cultura e dello spettacolo, ma a nulla è servito. Ad Eddi si applica la sorveglianza speciale perché la si ritiene un soggetto pericoloso in virtù del suo attivismo. La sorveglianza speciale è un residuato del codice fascista, implica un controllo stretto degli spostamenti e delle relazioni. Eddi non può partecipare a riunioni o iniziative pubbliche, deve stare in casa entro le 21 e fino alle 7, le sono stati ritirati passaporto e patente, non può frequentare bar dalle 18 alle 21, deve sempre portare con sé un libretto rosso in cui la polizia annota dove la incontra e molto altro ancora.
Se la Cassazione non si pronuncerà diversamente, Eddi sarà sottoposta a questa condizione repressiva fino al marzo del 2022. L’abbiamo intervistata a seguito di questa sentenza che lascia allibiti, per comprendere con lei i nodi e il significato di questa vicenda.
Anzitutto un po’ volevo sapere proprio come stavi, perché ormai sono nove mesi dalla prima sentenza, nove mesi vissuti in questo regime umiliante e repressivo, che ora si prolungano.
Sto bene, grazie. Non è un atteggiamento inedito, nei confronti miei e di altre persone, quindi non mi stupisco dell’esito. Certo la sentenza è vergognosa, anche per il tribunale torinese. Nel momento in cui si usa la guerra in Siria come fatto accessorio per il proprio impianto accusatorio e repressivo, si offende la memoria delle/dei 12mila martiri e le migliaia di vittime di quella guerra.
La stessa definizione di pericolo sociale che sottende a questa sentenza è preoccupante. Viene considerato un pericolo l’attività politica che io svolgo e non la fornitura di armi alla Turchia, o il numero di femminicidi, o il lavoro non pagato in Italia. Credo di vivere in un mondo diverso da quello di queste persone, credo anche che il mio mondo sia affollato, mentre nel loro c’è posto per pochi.
Un aspetto che mi pare rilevante è l’appiattimento totale tra la quelli che sono indagini della digos e le scelte dei magistrati. Quello per cui ti ritengono pericolosa non sono fatti per cui sei stata condannata, ma attivismo politico per cui sei segnalata dalla digos. È allora una colpa attivarsi politicamente a Torino?
A Torino il Tribunale non vuole o non può sconfessare l’operato della polizia. C’è una sorta di eccezione torinese: i pubblici ministeri possono inquisire persone per terrorismo, con teoremi accusatori che poi cadono, mettere in galera una persona per l’uso di un megafono, dare la sorveglianza speciale con un processo a persone che sono state in Siria, per poi dimenticare la ragione e accusarle per fatti avvenuti a Torino. La difesa ha chiesto di alleggerire alcune restrizioni, ma si è risposto di no, perché «tutte le cose che fa Marcucci sono avvenute in contesti pubblici e per questo lei va allontanata dai contesti pubblici». È chiaro che sotto sorveglianza è l’azione politica tout court ed è piuttosto inquietante. Le carte del processo sono rappresentative dell’atteggiamento di questo Tribunale, sono piene di disprezzo e costituite da un approccio ideologico, che non rende più conto nemmeno allo Stato. Ci sono comparti dello Stato stessi che poi smentiscono l’operato della magistratura torinese, ci sono processi milionari montati che puntualmente poi finiscono in un binario morto, eppure nessuno chiede conto del loro operato, evidentemente c’è una eccezione che è diventata regola.
Questo decreto prefigura un futuro preoccupante perché contravviene ad alcuni presupposti necessari allo stato di diritto, per esempio che si indaghino fatti specifici e attinenti alla materia del processo e non la qualunque, come in questo caso, che si mantenga la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva. Tutto dovrebbe essere tarato per garantire che “chi decide” sia parte terza, esterna al contenzioso.
Evidentemente il Tribunale, a Torino, non è un soggetto terzo, bensì un soggetto politico attivo nel territorio che negli anni ha acquisito un peso lavorando in maniera coordinata con la procura. Quindi in Piemonte Il meccanismo è saltato, possiamo discutere se sia stato mai in piedi, ma di sicuro il modo in cui è saltato in Piemonte contravviene alle stesse basi su cui si fonda la giustizia liberale.
Ci sono strumenti per ristabilirla ed è il caso che vengano utilizzati. Si parla di «reati commessi» e non ce ne è nessuno di commesso, si parla di una contestazione a cui partecipai con il mio collettivo all’università, nei confronti di un gruppo sedicente fascista, che viene definito come «interruzione dell’espressione di libero pensiero». Se il fascismo è un opinione allora stanno sostenendo un assioma un po’ pericoloso. Si traccia un profilo tale per cui chiunque abbia fatto parte di mezzo collettivo o di una forma aggregativa deve guardarsi alle spalle, e questo determina una giurisprudenza, crea dei precedenti. Viene inoltre contestato un episodio all’università in cui un agente della digos disse a me e a un’altra compagna: «se non la smettete vi riempio di schiaffi».
Il mio avvocato aveva fatto emergere quanto non fosse un elemento preso sufficientemente in considerazione. La corte ha risposto «non vediamo come possa essere un elemento rilevante il fatto che durante un momento concitato un agente minacci le persone». Recentemente è stata fatta una indagine parlamentare sulla velocità dei processi a seconda di chi è parte lesa, nello specifico rispetto alla vicenda No Tav. C’è una asimmetria troppo forte su cui intervenire, credo che dovrebbe dire qualcosa anche chi in quelle istituzioni crede profondamente o ci lavora. In fondo è il loro di lavoro che ne esce in cattiva luce, dovrebbe essere un interesse largamente condiviso intervenire in questa situazione.
Non riesco a non collegare la tua vicenda con quella di Dana Lauriola, in particolare con le motivazioni del rifiuto alle pene alternative al carcere, cioè la scelta di rimanere nel movimento No Tav e di vivere a Bussoleno.
Sono assolutamente d’accordo, lo stampo è il medesimo. Non so se ci sia qualcosa di freudiano ma pare proprio che la Procura abbia un problema grosso coi megafoni. Sono rimasta colpita dalla similitudine tra la descrizione della “gravità” dei fatti compiuti da Dana Lauriola, che è in carcere per aver usato un megafono a un’iniziativa No Tav e come viene descritta l’iniziativa che facemmo alla Camera di Commercio di Torino nell’ottobre del 2019 a seguito della invasione turca della Siria del Nordest. In quindici siamo entrati nella Camera di Commercio con dei volantini, abbiamo chiesto dove fosse il direttore e ci hanno indicato l’ufficio.
Pochi giorni prima il ministro degli Esteri aveva dichiarato che si interrompevano i rapporti militari con il governo di Erdogan. L’evento era patrocinato dalla Regione, con partnership di Leonardo, e sponsorizzato dalla Camera di Commercio. La difesa argomentava sulla natura irrisoria del fatto in sé e sul considerarne il contesto di dimostrazione politica, una normalissima dialettica sociale. Il giudice risponde dicendo che l’attenzione al contesto è «fuorviante», perché in quel momento «non stava avvenendo una compravendita d’armi dentro alla Camera di Commercio». Trovo offensivo che un tribunale parli così alla cittadinanza. Questa a me sembra anzitutto una presa in giro paternalista, peraltro è neutralizzante di qualunque azione politica che necessariamente deve muoversi anche attraverso simboli.
Poi sulle misure di prevenzione credo si possa anche fare un discorso a parte, non sono efficaci neanche contro la criminalità organizzata che sarebbe la ragione per cui esistono, magari sarebbe il caso di mettere a verifica queste zone grigie dell’apparato giudiziario; costituite da mezzi che più facilmente di altri possono essere strumentalizzati in termini di controllo sociale. Per il tribunale di Torino in sé penso che la domanda urgente sia: questa macchina sta funzionando? Possiamo avere il dubbio che ci sia un pregiudizio di questi magistrati verso qualunque caso di dissenso sociale, motivato da interessi personali e di dubbio gusto? Le inchieste a loro carico lo farebbero pensare. In fondo la differenza tra noi e loro rimane netta anche vista dalla prospettiva fallata del giustizialismo: da un lato persone che lottano per il proprio territorio, per un futuro migliore, dall’altro una cricca di potere, avida di averne altro, vendicativa e arraffona. Questa è evidentemente una sentenza ideologica – e non è la prima.
Nella sentenza d’appello del Tribunale di Torino vi è un aspetto che colpisce. Non viene quasi mai menzionato il tuo impegno nelle YPJ, ma soltanto fatti relativi alla tua militanza politica in Italia. Come lo interpreti?
Credo che sia un po’ una provocazione. Viene detto che non è un processo alle intenzioni, ma io ero in aula quando il PM ha detto che «queste sono persone anticapitaliste e non può essere che abbiano fatto quello che dicono di aver fatto per la società, come loro stessi dichiarano». Il Tribunale di Torino ha espulso lo scenario siriano, senza argomentarlo. L’unica spiegazione che viene data è che la gravità dei fatti compiuti sullo scenario italiano che rende irrilevante menzionare quello siriano. Ma è stato l’uso delle armi il motivo per cui il processo è iniziato. Forse dovrebbero allora ammettere che a loro bastava una scusa per chiamarci in aula. Non è più importante cosa abbiamo fatto ma chi siamo, come per Dana.
La somiglianza tra i casi è evidente anche come viene trattata «No Tav: confermata sorveglianza speciale» – hanno titolato i giornali mainstream. Il paradigma evidente è quello del nemico pubblico, io faccio parte del movimento No Tav e quindi si esalta quel piano, su cui si è già costruita una cornice negativa e si tace lo scenario in cui si metterebbe in contraddizione il Tribunale con la società cioè la mia lotta contro lo Stato Islamico. Non incontra il senso comune di nessuno dire che quello che è riportato sul mio processo sia pericoloso. E’ tracciato un profilo più diagnostico-psichiatrico che giudiziario, sembro una squilibrata che in concentrazioni pubbliche di persone aggredisce chi non la pensa come lei. C’è un livello di disprezzo e paternalismo ben congegnati e funzionali all’apparato repressivo. Questa corte ha negato in assoluto che la polizia abbia mai caricato a freddo in Italia: mi pare una affermazione oggettivamente falsa.
Immagino che tu sia in contatto con altri attivisti rientrati dalla Siria del Nord. Ci sono altri paesi in cui si vive la repressione giudiziaria che hai vissuto te in Italia?
Non sono persone con cui sono direttamente in contatto ma so che è capitato in altri paesi. In Spagna, in Olanda, in Inghilterra addirittura un ragazzo che stava nelle YPG è stato inquisito e il padre arrestato per avergli mandato soldi durante la sua permanenza in Siria. In Italia è il primo caso ed è un brutto precedente, ma credo sia un problema a livello europeo.
Ci sono tra le 70 e le 100mila persone che si sono mosse in tutto il mondo per unirsi allo Stato Islamico. L’amministrazione della Siria del Nord, nella situazione drammatica che vive non è riuscita a gestire un percorso giudiziario per tutti questi jihadisti, avrebbe dovuto essere costituito un tribunale internazionale, tanto più che molti di loro sono cittadini dei paesi membri della coalizione internazionale che formalmente si è opposta a Daesh.
Nessuno sta facendo nulla, si rimpatriano solo i casi in cui ci sono notizie certe,e nel frattempo passa il tempo e questo mette in pericolo tutte e tutti. Al tempo stesso però come singoli Stati ci si preoccupa di singoli membri dello YPG e YPJ. Non essere in grado di fare la differenza tra chi si è unito allo Stato Islamico e chi ha combattuto contro mi sembra grave e a chi non la capisce non metterei in mano le sorti della nostra società.
State immaginando forme di campagna e ricorsi in Cassazione?
Vorremmo di sicuro ma ora c’è sempre il limite della pandemia, ma è importante rimanere sintonizzati con i prossimi passaggi. Faremo ricorso in Cassazione, anche se siamo consapevoli che interviene se ci sono vizi procedurali. Terremo tuttx aggiornatx