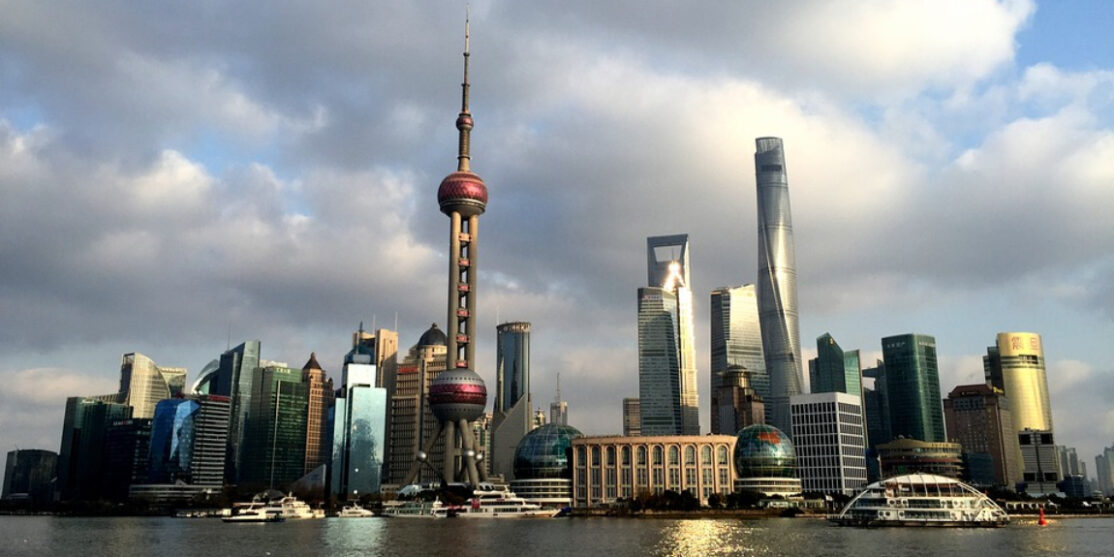MONDO

“Dobbiamo vivere come persone”: cronache da Haiti in fiamme
Il clima sociale ad Haiti continua a scaldarsi, le frustrazioni sociali si accumulano in una polveriera che non può disattivarsi. Dopo le intense mobilitazioni dell’anno scorso, con epicentri massivi e radicali nei mesi di luglio, ottobre e novembre, la tacita tregua di fine anno ha visto un natale materialmente precario, però tranquillo. Le festività sono state però solo un interludio breve.
Subito dopo si sono riannodate le battaglie contro la carestia, la corruzione endemica, la crisi sociale ed economica e l’assenza d’un modello nazionale per la prima repubblica indipendente sorta nella storia di questo lato del Río Bravo. Le proteste sono già arrivate all’ottavo giorno, e niente fa presagire che finiranno.
I primi sintomi di questo nuovo ciclo di proteste si manifestarono nel nostro stesso popolo, quando dei giovani esasperati dal comportamento della polizia in una discordia di terre hanno dato fuoco al commissariato della località di Montrouis, nel dipartimento Artibonite. La risposta, prevedibile, fu la rapida militarizzazione d’un paesino per lo più pacifico. Il giorno seguente, le forze speciali del CIMO facevano la siesta di fronte al mercato del popolo, e nessuno ricordava come si era arrivati a questa situazione, né con quale proposito.
Però il conflitto cominciò a moltiplicarsi in diversi focolai in tutto il paese fino ad arrivare all’esplosiva giornata del 7 febbraio, anniversario della fuga dal paese del dittatore Jean-Claude Duvalier. Da allora cominciò a combinarsi tutto il repertorio di azioni di strada già successe e in potenza: concentrazioni sporadiche, immense mobilitazioni spontanee, carovane di motociclette, scioperi dei trasportatori, commissariati ed edifici governativi dati alle fiamme e soprattutto migliaia di barricate che rapidamente bloccarono la capitale e i dieci dipartimenti del paese.
Sono settimane che la penuria di combustibile non smette di aggravarsi. Le lunghe code che popolavano le pompe di benzina hanno ceduto il passo alle porte chiuse e alle spiagge deserte, senza macchine né transito.
Gli ultimi litri che circolavano legalmente sono stati inghiottiti dal contrabbando, e ormai è solo possibile ottenere carburante nella strada, dopo ardue contrattazioni e a prezzi impossibili. In queste risse è il piccolo consumatore che ha tutto da perdere, dall’autista che deve fare girare la sua moto per comprare la sua razione giornaliera di riso e fagioli, fino alla venditrice ambulante che ha bisogno di accendere la sua candela per continuare a vendere al dettaglio nelle ore senza sole. Le cause della penuria sono legate alle responsabilità del deficitario stato haitiano, su cui pende un debito milionario con l’impresa che ha il monopolio dell’importazione.
I monopolisti, senza nessuno scrupolo, quadrano i conti facendo stringere i denti a tutta la popolazione usando il potere di paralizzare il paese. Le strade sono quasi vuote, e i prezzi di tutti i prodotti, dal trasporto fino agli alimenti, sono schizzati alle stelle. L’economia quotidiana è allo sbando e sta trascinando chi tutti i giorno deve lottare per la propria sussistenza nel paese più povero (o meglio, più impoverito) di tutto l’emisfero.
Mentre l’agenda internazionale si ostina nel girare lo sguardo verso un Venezuela aggredito, la grave crisi haitiana passa, un’altra volta, praticamente inosservata. E ai motivi dell’isolamento che soffre la nazione caraibica, dove i fattori politici ed economici sono ancora più determinanti della sua condizione insulare o della sua singolarità linguistica, si somma un fatto fondamentale.

L’egoistico governo nazionale di Jovenel Moïse, sotto scacco per otto giorni dalle proteste e ripudiato da praticamente tutti i settori della vita nazionale haitiana, ha appena dato un significativo segnale di allineamento alla diplomazia guerrafondaia nordamericana, riconoscendo nella OSA(organizzazione degli stati americani) l’autoproclamato Juan Guaidó. “White dog”, como è stato chiamato il nuovo “presidente” del Dipartimento di Stato. La politica astensionista che Haiti aveva sostenuto con altre nazioni caraibiche, è stata determinante per evitare che gli Stati Uniti e il Gruppo di Lima espellessero il Venezuela dell’organismo inter-regionale nel mese di febbraio 2018. Ora, la politica pragmatica e mendicante di Moise difficilmente potrebbe essere associata con affinità all’ideologia socialista del XXI secolo. Messo alle strette Moise è tornato rapidamente nel gregge, tradendo i vincoli storici che il paese ha con il Venezuela e soprattutto tradendo la generosa politica sostenuta de Hugo Chávez Frias e la piattaforma d’integrazione energetica promossa da Petrocaribe dal 2005.
Ed è così che a quasi nessuno conviene oggi segnalare che si tratta d’una crisi umanitaria, un esodo migratorio, insicurezza alimentaria, repressione statale e assenza democratica, il focus delle preoccupazioni dovrebbe ricadere la devastata Haiti e gli sguardi ammonitori sulla classe politica e sui suoi pilastri internazionali.
Ma è evidente, dato l’appoggio degli Stati Uniti all’apartheid israeliano o all’impazzito regime della monarchia assolutista saudita, che quello di cui si tratta è garantire lo sfruttamento del grezzo venezuelano e di completare il processo di ricolonizzazione continentale inaugurato con il colpo di stato in Honduras esattamente una decada fa. Tutto il resto sono solo coperture più o meno inventate, come le armi di distruzione di massa in Iraq o il patrocinio cubano al terrorismo.
A questa risonante indifferenza davanti alla crisi haitiana, dobbiamo sommare anche un spiegazione legata al secolare razzismo d’un mondo coloniale strutturato dai tempi della schiavitù delle piantagioni e del commercio triangolare. Razzismo che rende possibile che diversi settori, incluso quello progressista o di “sinistra”, si lascino abbagliare “dall’eleganza” con la quale lottano nelle strade parigine migliaia di gilets gialli (certamente degni), però disprezzano le battaglie disperate d’un popolo nero e terzomondista che non ha smesso di mobilitarsi in cento e mille, ma anche in milioni, dall’insurrezione popolare del luglio 2018.
In creolo, la lingua nazionale degli Haitiani, la parola “ladro” ha una connotazione molto più forte rispetto ad altre lingue continentali come il portoghese, lo spagnolo e l’inglese. Non è un termine che si usa molto frequentemente né un vocabolo che si dispensa con leggerezza. Il furto è considerato un’offesa grave a tutta la comunità, al punto che in alcune zone rurali si castiga ancora con severamente, con metodi di giustizia autogestita dalle stesse comunità. Ed è per questo che caratterizzare il presidente della repubblica e tutta la classe politica di vili ladroni, è un fatto meno frequente e ancora più significativo che in molti altri paesi.
L’accusa fa riferimento all’appropriazione indebita di fondi pubblici, comprovato dal Senato haitiano e investigato dallo stesso Tribunale Superiore dei Conti, che incolpano alti funzionari di stato dell’attuale amministrazione e della scorsa gestione presidenziale di Michel Martelly. La somma, dilapidata dalla classe politica locale in accordo con diversi capitali, e di all’incirca 3 800 milioni di dollari, previsti per rispondere alle infinite urgenze infrastrutturali del paese. Si tratta di fondi che la Rivoluzione Bolivariana concede generosamente all’interno del programma di sviluppo della Piattaforma Petrocaribe.
Se a questa corruzione endemica sommiamo la delicata situazione dell’economia e della società haitiana, possiamo capire facilmente i rancori accumulati e le ansie di trasformazione sociale, espresse nelle strade da un mosaico che esprime contraddittoriamente settori sindacali e politici, urbani e contadini, ecclesiastici e imprenditoriali, conservatori e radicali.

Alcuni indicatori economici possono aiutarci a riassumere rapidamente la situazione: una svalutazione della moneta nazionale, il gourde, del 20% lungo tutto il 2018; una inflazione a due cifre che viene stimata da alcuni analisti nell’ordine del 14 o 15 per cento; lo spreco delle risorse pubbliche in prebende di tutti i tipi assorbite dalla classe politica; lo sbando economico di uno stato che non conta neanche su un bilancio ufficiale da quando è stato ritirato quello previsto per il ciclo 2018-2019; i livelli allarmanti della disoccupazione e la completa informalità del mondo lavorativo; la rovina sconcertante della produzione agricola; l’esodo permanente dei giovani, espulsi dalle campagne alla città e da lì fino a paesi dove sono discriminati e super-sfruttati; e infine, la fame che colpisce duramente quasi il 60% della popolazione.
Un carro blindato delle Nazioni Unite, guidato da militari stranieri, ha perso il controllo e investì in pieno un tap tap, il popolare mezzo di locomozione haitiano. Il bilancio, tragico, è di quattro morti e nove feriti. Un incidente involontario, senza dubbio. Però lo sgomento e la rabbia dei cittadini non sembra dovuta alla imprudenza del conducente, ma dal fatto di non poter capire perché un carro blindato, un veicolo da guerra, circola minaccioso per un paese povero e senza forze armate che non rappresenta nessuna minaccia per la sicurezza d’un paese terzo.
15 anni fa cominciò la cosiddetta pacificazione di Haiti, promossa dalle Nazioni Unite e plasmata nell’intervento d’una forza militare e civile multilaterale, la MINUSTAH (oggi MINUJUSTH).
Però fino al giorno d’oggi, la principale minaccia per la popolazione, più che l’insicurezza locale (bassa se confrontata con la sua incidenza con il resto della regione) e ancor di più dell’attuare delle sue proprie forze di polizia, lo costituisce la presenza della forza di occupazione. Oltre gli incidenti si contano numerosi stupri sistematici a donne dei cosiddetti “ghetti”, tra le 7 mila e le 9 mila vittime per l’epidemia di colera portata nel paese dal contingente di soldati nepalesi, e un numero incerto di giovani assassinati nei quartieri della capitale Port-au-Prince. Ad Haiti, come potrebbe succedere in Venezuela, il cosiddetto “aiuto umanitario” non è stato altro che un eccellente alibi per violare la sovranità territoriale della nostra nazione. La piccola nazione caraibica è oggi un esempio di quello il “capitalismo umanitario” potrebbe generare in Venezuela.
Le forze di polizia riconoscono già 10 morti. Una cinquantina, e un numero simile di feriti, per i vari settori dell’opposizione e per i movimenti sociali. Negli ultimi giorni le strade e le reti sociali mostrano una serie di immagini scabrose.
Giovani e bambini a terra, agonizzanti, nelle strade della capitale. Un militante popolare soccorso dai suoi compagni dopo essere stato colpito da un proiettile della polizia nei pressi del parlamento. Una densa nube nera che copre la città in modo quasi permanente, generando un clima irrespirabile. Il mercato di Croix-des-Bossales, mille volte incendiato, mille volte ricostruito, per un’altra volta volta ridotto a un groviglio di ferri contorti.
Ma ci sono anche immagini senza dubbio eroiche, con quest’eroismo proprio della gente semplice, senza margini, che si danno forza. Stare nelle strade di Haiti è oggi molto di più che una opzione politica o un gesto di coraggio: è una necessità vitale, il colpo disperato d’un popolo ormai messo alle corde. Uomini in sedia a rotelle o su carretti marciando sotto il sole cocente del mezzogiorno. Venditori e donne anziane gridando i loro slogan a sguarciagola sfidando la repressione poliziesca. E anche, piccoli gesti di solidarietà internazionale che brillano come tenui luci, arrivando al paese saltando le barriere della lingua e dell’inerzia.
Nou gen dwa viv tankou moun. “Abbiamo il diritto di vivere come persone”, si legge su un cartello che sintetizza il programma minimo, elementare, meramente umano. Il programma d’un popolo che ancora ricorda le sue glorie passate, che ancora crede nella possibilità d’una rigenerazione nazionale e che cerca fanaticamente e per la seconda volta, la sua indipendenza, la sua dignità. Un popolo che soffre, si, ma che non si rassegna, mai.
Pubblicato il 14 febbraio 2019 su Nodal.com. Traduzione in italiano di Milos Skalal per DINAMOpress.
L’autore è sociólogo e membro della Brigada Dessalines de Solidaridad con Haití.