cult
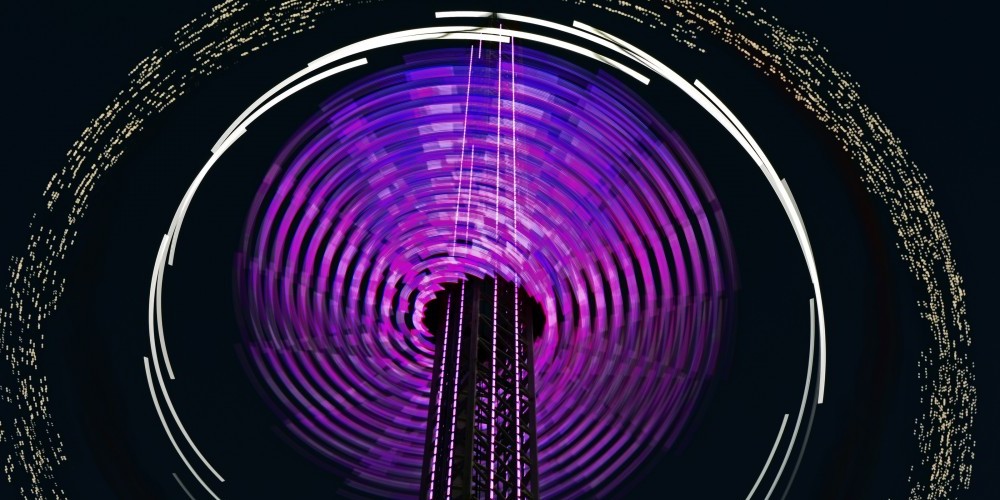
CULT
Il capitalismo ci toglie tempo, sonno e idee
“Cronofagia. Come il capitalismo depreda il nostro tempo”, l’ultimo saggio di Davide Mazzocco pubblicato da D Editore nel 2019, torna sui temi già esplorati da Paul Lafargue in “Il diritto alla pigrizia”, aggiornandoli ai ritmi del capitalismo contemporaneo.
Quando Paul Lafargue scrisse il suo pamphlet Le Droit à la paresse (Il diritto alla pigrizia), tra il 1880 e il 1883, prima come esule a Londra e poi in veste di prigioniero politico, dall’interno di un’umida cella del carcere parigino di Sainte-Pélagie, la classe operaia europea versava in una situazione che, oggi, non faticheremmo a definire di prigionia: lo scotto da pagare per la rivendicazione di un velenoso e illusorio “diritto al salario” era rappresentato dall’accettazione di condizioni di lavoro massacranti che, di fatto, sfociavano nella più completa schiavitù. Dei veri e propri regimi di asservimento volontario che, tuttavia, venivano pienamente normalizzati e istituzionalizzati da quella che il pensatore francese definiva profeticamente religion du capital, ossia la pretesa necessarietà di un capitalismo che, già al tempo, tentava in tutti i modi di imporsi come legge naturale e universale.
Tra i fondatori del Partito Operaio Francese, sposo di Laura e genero di Karl Marx, Lafargue comprese in fretta che le avvisaglie di tempesta descritte dal suocero nel Das Kapital e, ancor prima, da Engels (suo testimone di nozze) nella Situazione della classe operaia in Inghilterra (1845), avevano finito col tramutarsi in una realtà drammatica. Del resto, per rendersene conto, era sufficiente osservare quanto accadeva al di là dei cancelli d’ingresso delle fabbriche: il proletariato industriale parigino – donne, uomini e bambini – lavorava, in media, dodici ore al giorno; lontano dalla zone de confort della capitale, nelle province e nelle campagne, la predazione di tempo ai danni del capitale umano poteva raggiungere picchi di quattordici ore; in Italia il quadro era ancora più drammatico, principalmente in ragione di una più scarsa cultura sindacale. Il dato più preoccupante riguardava la situazione delle donne impiegate negli opifici: nelle filande piemontesi, centinaia di operaie trascorrevano fino a sedici ore al giorno con le mani immerse nell’acqua bollente, costrette a convivere in spazi ristrettissimi, a inalare vapori nauseabondi, a sopportare quotidianamente condizioni igienico-sanitarie pessime e a fare i conti con un’afa insostenibile (per favorire la filatura della seta, le finestre dovevano rimanere chiuse, altrimenti l’aria avrebbe potuto irrimediabilmente rovinare la trama), sacrificando la propria salute per la modica cifra di 45 centesimi al giorno.
Il proletariato europeo accettava passivamente gli abusi dei padroni, che avevano buon gioco nell’imporre le proprie condizioni, complice una posizione contrattuale di preminenza assoluta e un movimento operaio ancora poco maturo, privo di una vera coscienza di classe che, se da un lato fece del “diritto al lavoro” il nucleo essenziale del proprio manifesto rivendicativo, dall’altro raramente sembrava interrogarsi a fondo sul reale significato di quel diritto.
È proprio a partire dall’osservazione di questo esercito di salariati in catene, dall’ascolto dei gemiti di disperazione dei nuovi soggiogati delle fabbriche e degli opifici, che Lafargue compose Le Droit à la paresse, ponendo al centro della propria riflessione la necessità di recuperare il “diritto alla pigrizia”, che veniva inteso come un qualcosa di molto simile al concetto latino di otium: per spezzare le catene della prigionia, i sottoproletari avrebbero dovuto reimpossessarsi di quel tempo che gli antichi dedicavano allo studio, alla cura dello spirito e alla strutturazione del pensiero; una dimensione del vivere di inestimabile valore che la fede cieca nel produttivismo aveva rapidamente costretto alla damnatio memoriae. Solo recuperando il proprio tempo la classe operaia avrebbe potuto individuare un efficace antidoto all’alienazione, curando lo sviluppo di quelle potenzialità umane che il dominio capitalistico stava reprimendo a suon di lavoro a cottimo e premi di produzione.
L’invito a lottare per recuperare il sacrosanto diritto a oziare e a opporre una forte diffidenza nei confronti di un capitalismo predatorio che, il più delle volte, tende a proporsi ai nostri occhi in forma mutevole e ammiccante, attraverso «i volti rassicuranti del progresso, della libertà d’espressione e dell’intrattenimento», traspare con forza anche dalle righe di Cronofagia. Come il capitalismo depreda il nostro tempo, l’ultimo saggio di Davide Mazzocco, pubblicato da D Editore nel 2019. Scorrendo le sue pagine, la forza dirompente del messaggio di Paul Lafargue si riappalesa in tutta la sua brutale attualità, ricordandoci come, ora come un secolo e mezzo fa, le trame del capitalismo siano rimaste sostanzialmente inalterate.
Lo Zeitgeist dominante è lo stesso: abbiamo pochissimo tempo da dedicare a noi stessi. A mutare, invece, sono stati i meccanismi volti a fare incetta dei tempi morti, diventati man mano più subdoli e impercettibili. A differenza di quanto accadeva ai tempi di Lafargue, Marx ed Engels, infatti, l’appetito “cronofago” dal capitale non investe soltanto l’orario di lavoro, ma anche (e soprattutto) la sfera del tempo libero, oggetto di una sempre più aggressiva campagna di colonizzazione. Di conseguenza, se un pensatore come Lafargue poteva concedersi il “lusso” di focalizzarsi unicamente su quanto accadeva all’interno delle fabbriche, un’analisi critica delle attuali dinamiche del tardo capitalismo impone di allargare lo sguardo anche a ciò che succede al di là dei luoghi di lavoro.
La riflessione di Mazzocco prende le mosse dall’opera del saggista francese Jean-Paul Galibert che, nel suo pamphlet I cronòfagi (2015), ha coniato per primo il termine “cronofagia”, configurandolo come una delle colonne portanti dell’ipercapitalismo contemporaneo. Secondo Galibert, l’individuo è «simultaneamente una quantità di tempo disponibile per la cronofagia e una quantità di denaro disponibile per l’ipercapitalismo. Questa regola si erge a condizione della nostra esistenza, al punto di diventare la nuova condizione umana. Nell’ideale di disponibilità, l’uomo diventa un doppio giacimento di denaro e di tempo da prelevare senza limiti ma è necessario che si stabilisca un rapporto di equivalenza tra il tempo di cui lo si priva e il denaro di cui lo si alleggerisce». Riprendendo e attualizzando il lavoro di Galibert, Mazzocco torna ad approfondire il tema della cronofagia, il braccio armato di cui l’ipercapitalismo si serve per autoperpetuarsi, fagocitando il tempo delle masse e procedendo a una progressiva erosione del tempo dell’inattività e, di conseguenza, della non redditività.
Già vent’anni fa Naomi Klein, nel suo No Logo, aveva evidenziato come «i prodotti che si svilupperanno in futuro saranno quelli presentati non come “merci”, ma come concetti», sfruttando il lavoro immaginario dei consumatori attraverso la creazione di una mitologia aziendale che possa «infondere significato agli oggetti apponendovi semplicemente il proprio nome». Il paradosso dello scambio cronofago risiede proprio in questo cortocircuito logico: «lavorare e poi pagare, a colui per il quale lavoriamo, il giusto prezzo del nostro lavoro». Una volta esaurito il proprio “vero” impiego, l’individuo trascorre la quasi totalità del proprio “tempo libero” vestendo i panni del consumatore e, attraverso la propria immaginazione, compie inconsapevolmente una seconda prestazione professionale in favore del capitale, in primis desiderando fortemente un certo tipo di bene (una macchina, un notebook, uno smartphone) e contribuendo, in tal modo, ad aumentarne il valore economico; in secondo luogo, pagando quel sovrapprezzo che la sua stessa mente ha contribuito a strutturare.
Se il quantitativo di tempo che gli individui dovrebbero consacrare alla “pigrizia” di lafarguiana memoria e che, invece, viene puntualmente sacrificato sull’altare del consumo rappresenta il primo ambito di colonizzazione dell’ipercapitalismo, un altro obiettivo strategico di assoluto valore è costituito dall’occupazione dell’unico spazio in cui è ancora consentito rimanere persone, e non consumatori: il sonno.
Non a caso, un’altra ascendenza letteraria ben presente in Cronofagia è un saggio del 2015, Capitalism 24/7. Il capitalismo all’attacco del sonno, in cui l’autore, Jonathan Crary, evidenzia come un bisogno biologico fondamentale sia entrato in netto contrasto con le esigenze volte al raggiungimento dell’utopia di un capitalismo 24/7, un’ucronia che si vorrebbe animata unicamente da zombie sonnambuli e in perenne dipendenza da consumo.
Riprendendo Crary, Mazzocco evidenzia come, nel corso di un secolo, il tempo che gli individui dedicano al sonno sia calato a picco: dalle dieci ore a notte dell’inizio del XX secolo, si è passati alle otto ore della metà del Novecento e, successivamente, alla media attuale di circa sei ore. Non è un caso se il CEO di Netflix, Reed Hastings, durante una conferenza tenutasi a Los Angeles nel 2017, aveva definito il sonno come il principale competitor della propria piattaforma: la sua suggestione è quantomai veritiera. Il tempo che trascorriamo dormendo è un tempo infruttuoso, protetto da ogni bisogno artificialmente indotto, che placa gli appetiti cronofagi dell’ipercapitalismo. Una zona d’immunità di cui, sempre più spesso, tendiamo a sottostimare la portata: il tempo che gli individui dovrebbero dedicare al sonno è sempre più finalizzato a infoltire i profitti dell’industria dell’intrattenimento, attraverso bulimiche sessioni notturne di bingewatching, acquisti compulsivi su Amazon o spese improvvisate nei tanti ipermercati aperti h24 che proliferano a macchia d’olio, contribuendo alla creazione di spirali di precariato macroscopiche nel nostro Occidente simbolo di “progresso”. Abbattere il bisogno umano di chiudere gli occhi per un terzo della giornata è, probabilmente, il tassello strategico più importante che l’economia di mercato intende perseguire nei prossimi anni.
Come evidenziato da Crary, «il sonno pone il problema di un bisogno umano che si può soddisfare solo in un certo intervallo di tempo e non può quindi essere asservito o aggiogato a una macchina per fare profitti, offrendosi così come un’incongrua eccezione, una vera e propria area di crisi nell’ambito dell’attuale globalizzazione».
Un ulteriore spunto di riflessione fornito dal saggio di Mazzocco è quello che concerne il tempo che, di giorno in giorno, viene speso per la burocrazia. Da mezzo secolo, i tecnottimisti hanno impostato il proprio storytelling sul potere salvifico dell’informatizzazione, che avrebbe dovuto liberarci dalla «schiavitù della carta e dalle lungaggini dei processi di trattamento dei dati». Malgrado le previsioni entusiastiche, quello della semplificazione burocratica rischia di diventare un mito: è sufficiente interfacciarsi con qualsiasi sportello dell’amministrazione pubblica per rendersi conto che la tecnologia non ha affatto risolto il problema ma, anzi, in determinati casi ha contribuito ad aumentarne la portata.
Come evidenziato da David Graeber nel suo saggio Burocrazia (citato esplicitamente da Mazzocco nel terzo capitolo), allo stadio attuale, «ognuno di noi sa che dovrà imparare a fare il lavoro che un tempo facevano gli agenti di viaggio, i mediatori finanziari e i commercialisti». Graeber sottolinea come, paradossalmente, l’iperburocratizzazione della nostra società sia avvenuta nel periodo immediatamente successivo la caduta degli apparati della burocrazia socialista.
Quegli oneri che, fino a qualche decennio fa, gravavano sulle spalle di professionisti adeguatamente formati, attualmente pesano sui singoli individui: per un professore universitario è diventato inevitabile dedicare sempre più tempo alla corretta gestione delle borse di studio, così come per un genitore è perfettamente normale riversare ore e ore nella compilazione di moduli infiniti per iscrivere i propri figli a una scuola dignitosa. Le ore che impieghiamo per allinearci alle esigenze di una burocrazia che «ci ha trasformati in amministrativi part time e in segretari di noi stessi» sono ore sottratte allo sviluppo delle nostre potenzialità: la cavillosità e il fiscalismo ci hanno trasformato in una massa indistinta di automi insoddisfatti, indaffarati, preoccupatissimi e sfiniti.
Il saggio di Mazzocco, attraverso l’impiego di un linguaggio volutamente non accademico e i continui rimandi ad aneddoti propri della quotidianità dell’autore (come quello in cui si ritrova ad affrontare file interminabili alle Poste per ottenere l’esenzione dal canone Rai), riesce perfettamente nel suo intento: conferire al lettore la consapevolezza di una contemporaneità drammatica che i poteri che governano la nostra società tendono sempre più spesso a normalizzare, impiegando una narrativa compiacente volta a far apparire come desiderabile un mondo in cui il concetto di otium è, ormai, poco più di una fotografia sbiadita.
Sul tempo di lettura ci rassicura lo stesso Mazzocco nella quarta di copertina del libro: 594 minuti.
E adesso?
Adesso abbonati, genera indipendenza
