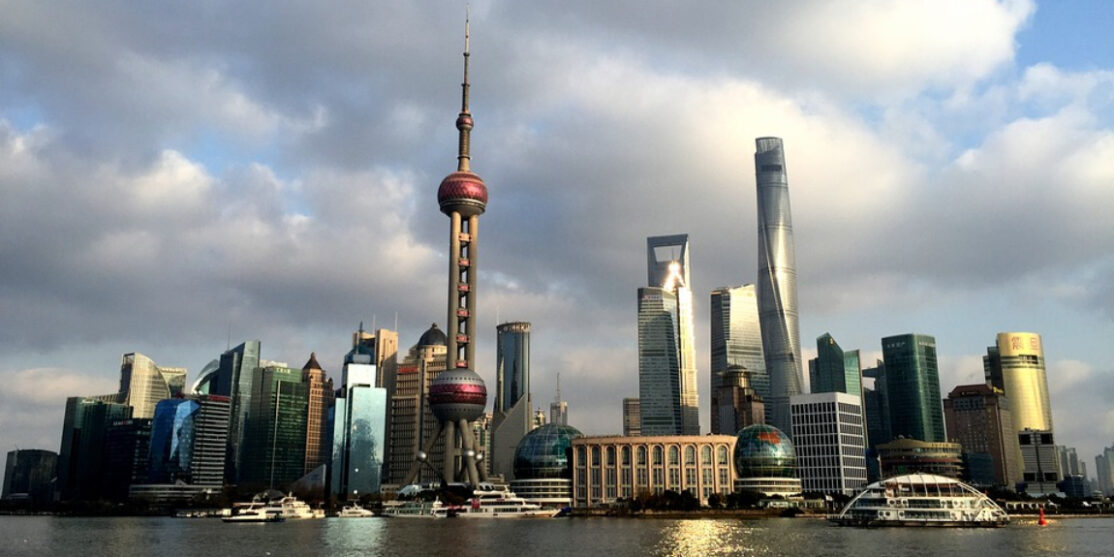NELLE STORIE
2 dicembre: ricordando il Granma

Con la rubrica NELLE STORIE ricordiamo un episodio decisivo della rivoluzione cubana. Il 2 dicembre 1956 il malconcio e sovraccarico battello Granma fa naufragio sulle coste di Cuba dopo essere sfuggito a un fortunale.
Alla fase epica e militare, che si chiude nel 1961 con il rigetto dell’invasione Usa alla Baia dei Porci, seguì la ben più tormentata costruzione del socialismo nell’isola nel difficilissimo contesto dell’accerchiamento diplomatico e militare e dell’embargo americano, cui dopo il 1989 si aggiunse il disimpegno sovietico. Lo stesso gruppo dirigente cubano conobbe contraddizioni e lacerazioni, cui Che Guevara si sottrasse con il disperato tentativo di spostare altrove il fronte della lotta.
Il mito di Cuba perse smalto in Europa come alternativa alla via sovietica, mentre rimase intatto in Africa, per gli aiuti militari e medici ai paesi che avevano tentato la strada di una radicale decolonizzazione, e in America Latina, dove rappresentava la maggiore sfida all’imperialismo americano, con i suoi feroci servi locali, e una fonte di ispirazione e aiuto per i movimenti rivoluzionari.
Il sacrificio del Che germogliò frutti inediti, decenni più tardi, in tutto il continente, a partire dalla Bolivia che aveva visto il suo martirio. Chávez riprenderà dall’alto, in forme certo non previste dai cubani, un programma di emancipazione (subentrando, fra l’altro, all’Urss nel sostegno economico contro l’embargo) ed è difficile non cogliere l’affinità con Cuba e il castrismo nelle pur molto diverse esperienze di Argentina e Bolivia, mentre anche il politicamente lontanissimo Messico apprezzò il ruolo oggettivo di protezione dell’indipendenza regionale svolto dal regime di Castro.
Undici presidenti statunitensi si succedettero senza riuscire a ledere né la vita né il prestigio di Fidel.
Qualcuno, come Kennedy, l’irresoluto padrino della Baia dei Porci, ci lasciò le penne, vittima del risentimento dei boss mafiosi danneggiati dalla pulizia di quello che era stato il bordello e il parco giochi degli Usa. Prima di Vargas Llosa, Panebianco e Saviano c’erano state le lamentele di Meyer Lansky e Santo Trafficante, che notoriamente preferivano usare mezzi diversi dalla penna.
Fidel Castro – a voler raccogliere in un nome e in un mito l’operare di un gruppo dirigente di morti e di vivi che si sono susseguito in questi quasi sessant’anni di esperienza – ha edificato un sistema ineguagliabile di scolarità e assistenza sanitaria, un’economia inevitabilmente fragile sotto il condizionamento delle materie prime disponibili e dell’embargo Usa, una condizione di orgoglio e dignità senza pari nell’area latino-americana e non solo.
Non è riuscito a sostituire un modello alternativo di socialismo a quello “reale” imploso in Europa e ribaltato in Cina, ma sarebbe tanto ingeneroso fargliene un rimprovero quanto assurdo fingere che lo sia.
Dal Granma arenato fra le mangrovie di Playa Las Coloradas alla cerimonia funebre in Plaza de la Revolución la strada è stata lunga e ben più tormentata della leggenda romantica e guerrigliera. E risparmiamoci il sentenziare che con Castro muore il Novecento: con il che si intende dire, con gaudio sfacciato o educato rammarico, che muore la rivoluzione e il “sogno” comunista. Muoiono i protagonisti e pure gli spettatori non si sentono tanto bene, ma i processi rivoluzionari vanno avanti, malgrado limiti, sconfitte e battute d’arresto.
Non è per nulla scontato che il comunismo muoia a Cuba e altrove sia diventato utopia. O, per essere più esatti, che sia destinato a scomparire un regime sociale avanzato a Cuba e dunque la speranza di nuovi assalti al cielo in altre situazioni. Non è inevitabile che Trump riporti alberghi, casinò e basi militari nell’isola, per la gioia degli inviati dei nostri giornali, che oggi si lagnano del mancato accesso ai funerali.
E dovunque tornerà a divampare il fuoco, si ricorderà la piccola scintilla accesa quel 2 dicembre.