cult

CULT
Mi chiamo Fabri Fibra, come tutti
Sfrontato, eccessivo, costantemente oltre il limite del politicamente corretto: il rapper di Senigallia rappresenta un fenomeno trasversale e controverso, che ha raccontato come pochi altri la “mutazione antropologica” della nostra società nell’era delle autofinzioni
C’è un nome che ricorre, in questo periodo di scomposizione sociale e polarità discorsiva, ed è il nome di Walter Siti. Intellettuale, scrittore, curatore dell’opera pasoliniana – figura anche come autore della prima stagione del Grande Fratello-Italia – e oggi pure polemista di un certo successo, critico aspro dei nuovi linguaggi e delle neo-posture da attivismo social di-belle-parole-per-le-buone-cause. Il suo Contro l’impegno. Riflessioni sul bene in letteratura (Bur, 2020) è un attacco diretto a personalità centrali nel dibattito pubblico (Roberto Saviano, Michela Murgia, ecc.) che si risolve, però, in una difesa appassionata (benché, a tratti, sorniona e indolente) del potere ambiguo della scrittura, di una sua intrinseca ambivalenza e “scorrettezza morale”.
Dedicare la propria vita alla letteratura (e non «la letteratura alla vita», come ammonisce Siti nelle pagine di apertura del saggio) è qualcosa che fa male, svuota, forse, le esistenze, per quanto contenga promesse di catarsi: «Ho settantatré anni e nessuna speranza, solo qualche desiderio», ammette in un lamento quasi schivo lo scrittore.
Non che Siti non fosse conosciuto prima di oggi, e non che non lo fosse la sua opera. Resistere non serve a niente, il suo settimo romanzo, è stato insignito nel 2012 del Premio Strega, e già dall’esordio di Scuola di nudo (e con i successivi Troppi Paradisi e Il contagio) si era fatto riconoscere per uno stile debordante, eccessivo, ossessionato dalle nevrosi del sesso e della carne così come dalla mistica nascosta del quotidiano e dei grandi cambiamenti storici. Suo è l’incipit probabilmente più particolare e avvincente degli ultimi quindici-vent’anni di prosa italiana, diventato ormai un “classico”:
«Mi chiamo Walter Siti, come tutti. Campione di mediocrità. Le mie reazioni sono standard, la mia diversità è di massa. Più intelligente della media, ma di un’intelligenza che serve per evadere. Anche questa civetteria di mediocrità, come i ragazzi di borgata che indossano a migliaia le T-shirts con su scritto «original»; notano la contraddizione e gli sembra spiritosa. L’eccezionalità occupa i primi cinque centimetri, tutto il resto è comune. Se non fossi medio troverei l’angolatura per criticare questo mondo, e inventerei qualcosa che lo cambia».
Si tratta della prepotente esplosione sulla scena culturale di una nuova tecnica di scrittura, destinata a diventare poi – attraverso le penne di altri autori e, pure, degli scritti meno riusciti dello stesso Siti – stilema consunto, espediente di maniera.
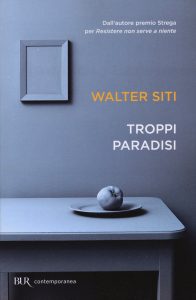
L’autofinzione (o autofiction) – quel movimento per cui in un romanzo l’autore utilizza il suo nome di battesimo, facendo del proprio io biografico un concreto personaggio e mischiando esplicitamente verità e finzion(i) – è infatti divenuto un vero e proprio “sottogenere merceologico”, un esperimento ormai praticato e assunto da molti.
Eppure, in pochi come Siti sono riusciti a portarlo a un livello di elaborazione convincente, e così significativa. Anzi, più spesso, un tale espediente retorico è stato usato più come mascheramento, velo, che come sonda di scavo.
In questo senso, sono esemplari alcuni romanzi di Francesco Piccolo come La separazione del maschio o certe parti di Il desiderio di essere come tutti, in cui il doppio dell’autore (o meglio, “l’uno e mezzo dell’autore”), presente fra le righe, va in fin dei conti a far da filtro, a proteggere l’inconscio invece che rivelarne i tratti più scomodi e inconfessabili. “Mi dico io”, per non dirmi realmente.
Altre volte, la scelta dell’autofinzione crea un eccesso di aspettativa per l’autodafé, che si risolve in ansia da prestazione (non solo letteraria): la realtà è esagerata fino a scoppiare, l’io diventa un simulacro posticcio. È il caso, per esempio, di Kamikaze d’Occidente di Tiziano Scarpa, dove l’autore – per non deludere la promessa implicita di “emozioni forti” e dettagli scandalistici – finisce per ritrarre il proprio sé finzionale come una sorta di macchietta, per nulla provocatoria pur nella voracità del desiderio.
Anche in Siti l’eccesso è cifra costante della narrazione, ma è come se l’autore se ne assumesse quasi sempre il peso e la responsabilità: non c’è autocompiacimento o commiserazione, non c’è distanza ironica o ricaduta nel grottesco. Ogni iperrealismo, anche quello che appare esagerato ai nostri occhi, nasce da una contraddizione reale o, perlomeno, realmente esperita (il che, in letteratura, è la stessa cosa), tanto da far sorgere il sospetto – a farsi strada nella filigrana di una proliferazione aggettivale e sensoriale della scrittura – che sia in fin dei conti la vita stessa del Walter Siti autore ad assumere i caratteri di un’autofinzione e non quella del suo personaggio di carta.
Parallelamente al famoso incipit di Siti – anzi, proprio nello stesso anno di pubblicazione del romanzo – un altro incipit, e ben più famoso, andava a sconvolgere la scena rap italiana. «Oh, io non capisco perché ma / ogni periodo / c’è qualcuno che / se ne viene fuori dicendo che / io sono morto»: sono le prime parole che si sentono nel brano Applausi per Fibra del cantante marchigiano Fabri Fibra, al secolo Fabrizio Tarducci.
Per proseguire, con una virata quasi surreale: «Io / mangiavo lucertole aperte da ragazzino / tornavo a casa e vomitavo in mezzo al giardino», ecc. Doppio disco di platino, record di vendite nel genere hip-hop e segno del definitivo passaggio con una major discografica, considerato da parte dell’ambiente più indipendente e “sotterraneo” da cui proveniva Fibra stesso come una sorta di “tradimento”. E Tradimento è, appunto, il titolo dell’album.
Basterebbe forse già questo cortocircuito fra urgenza espressiva e identità autoriale, fra la sostanza della scrittura e il suo luogo di enunciazione, a far pensare che siamo su territori vicini a quelli dell’autofinzione.
Il tema della carriera del cantante, ma in particolar modo delle reazioni che un tale salto di carriera (un passaggio di status?) provocherebbe nei circoli hip-hop e nel pubblico in generale, è continuamente evocato e rielaborato da un punto di vista narrativo sia all’interno di questo album di svolta che nel prosieguo delle opere successive: «Questo non è un nuovo album di Fabri Fibra / Questa è la morte di mr. Simpatia / Se trovate questa roba troppo volgare / Ritiratela, e andatevene affanculo» (Rap in guerra), «Dopo l’ultimo disco ho ancora il collo che trema / E tu mi domandi qual è il problema?» (Su le mani), «Io non voglio Fibra in giro, non voglio Fibra ai party / Non voglio che ha successo, non voglio quattro infarti […] Hai comprato il mio cd e lo canti tutto a memoria / È uno scandalo quando poi l’hai copiato a metà scuola» (Applausi per Fibra) fino al più recente «Ho fatto cinque dischi major e due indipendenti / Inseguo affari di notte a fari spenti / Sento odore di “Ma sei serio?” / Sempre di corsa io faccio non spero / La gente mi scatta le foto in autovelox / Ancora famoso non mi sembra vero» (Alieno).
Certo, mettere il proprio sé al centro di un roboante storytelling, raccontare il proprio percorso musicale come una storia di riscatto contro tutto e contro tutti, è di fatto uno stilema dell’hip-hop fin dagli albori del genere. In questo senso, Fabri Fibra ricalca molto la poetica messa in campo qualche anno prima da fondamentali figure d’oltreoceano come Eminem che, soprattutto in The Slim Shady Ep e in The Marshall Matters Ep, andava similmente a insistere sulla sua personalità da rapper amato/odiato e a far leva su una rabbia esistenzial-artistica per elaborare dei gridi d’accusa verso la società intera.
Eppure, nel contesto italiano, con Fabri Fibra è come se si entrasse in una dimensione diversa. A parte alcuni episodi più diretti e assertivi (ma pur sempre filtrati da paturnie e paranoie di un io al tempo stesso introflesso ed esagitato: Mal di stomaco, Cuore di latta, In Italia, Non credo ai media, E tu ci convivi), infatti, l’autore di Tradimento non ha nulla da rivendicare se non la determinazione a fare ciò che sente essere la sua inclinazione più profonda, portare avanti – semplicemente – un “lavoro” che rispecchi i propri desideri, le proprie aspettative: «Le voci, le luci, sono tutti messaggi / dipende poi tu come li traduci / È un alfabeto Morse / i rimorsi portano a strani percorsi / È un flusso / Arriva sempre chi dice che sbaglio / Anche se io mi sento nel giusto / Come se fare ciò che vorresti fosse un lusso», canta in In alto.
Non c’è una “matrice di violenza” a fondare le origini della propria biografia, non ci sono traumi lancinanti o torti subiti di cui far vendetta (se non un difficile contesto familiare e “ferite” molto vaghe e superficiali: «Per accettarmi a me ce n’è voluto / Son più le volte in cui non mi sono piaciuto / Alle superiori me lo ricordo ancora / stavo sul cazzo a metà della scuola», da La mia vita). C’è, al contrario, una continua messa alla prova della propria identità, una rincorsa del successo nella consapevolezza che, però, la celebrità, il lusso, l’auto-costituirsi come personaggio riconosciuto all’interno di un universo iper-mediatizzato sono delle trappole, sintomi di falsa coscienza.

Rougena Zátková, Marinetti soleil (da commons.wikimedia.org)
In questo senso, la domanda che Fabri Fibra ha posto al centro di quasi tutta la sua produzione discografica è molto vicina ai fantasmi che si agitano nella scrittura di Walter Siti: cosa vuol dire essere unici e speciali in un mondo in cui tutti sono spinti a sentirsi tali? Che senso ha (da un punto di vista artistico, ma non solo) prender parola, esprimersi dal più profondo del proprio io quando (l’illusione di) autenticità è la forma primaria con cui si danno l’omologazione e il conformismo sociale?
Scrive il critico letterario Carlo Mazza Galanti nel suo articolo Autofinzioni: «Se nessuno potrebbe oggi mettere seriamente in discussione il carattere finzionale della Divina commedia, il termine “autofinzione” definisce al contrario proprio il disorientamento che impedisce di interpretare certi elementi del racconto come reali o come inventati. Un gioco piuttosto sadico che lo scrittore impone al lettore, e che ricorda da vicino il potere manipolatorio e persuasivo esercitato dai mezzi di comunicazione di massa».
Ecco, Fabri Fibra – con le sue canzoni – è al tempo stesso vittima e carnefice di questo “gioco piuttosto sadico”. La volontà di emergere, anzi proprio esplicitamente di “vendere” e diventare famoso, si mischia all’inquietudine, alle “turbe giovanili” che non abbandonano mai l’artista neanche all’apice del suo successo: «Sta roba prende perché è intraprendente / Musica che aiuta a sfuggire dal niente / te lo direbbe anche una muta / Ma dio quanto possa essere falso io / Quanto possa andare in basso mi stupisco anch’io / Quando parli mi stai sul cazzo, si fa, si sa / Non ho palle abbastanza grandi per cambiare città», confessa in Idee stupide.
Anzi, la scalata verso la “vetta”, l’attitudine revanscista e sfrontata con cui il rapper si pone in posizione di sfida sia nei confronti dei suoi “concorrenti” che della società tutta, assumono a tratti le tinte fosche e soffocanti di un vero e proprio delirio schizoide: «Vengo dal ventre della paranoia / Il mio corpo è a terra e la mia testa in braccio al boia», allucina in Saic; oppure ancora in +-: «Ultimamente sogno gente famosa / che mi dorme in casa parlandomi in prosa / la gente aspetta una rima che non esiste / e più continui a spiegarlo più dice: “Cosa?”».
E, d’altronde, che ne è dell’io nel momento in cui gli unici contorni di senso per dar conto del proprio percorso esistenziale rimangono quelli dell’incessante sovraesposizione di sé? Se l’auto-realizzazione personale arriva a combaciare con la fama, con la costruzione di un’immagine da “dare in pasto alla folla”, come può questo processo non generare nevrosi e alienazione? In questo senso, la poetica messa in campo da Fabri Fibra è una poetica del disorientamento nell’accezione esposta poco sopra da Mazza Galanti.
Ma, nelle ambivalenti canzoni del rapper di Senigallia, l’impossibilità di discernere gli elementi reali da quelli inventati finisce per “mangiare” e consumare chi scrive più che chi legge, finisce cioè per essere il segno tangibile di un «potere manipolatorio e persuasivo» che viene esercitato in primo luogo su se stessi, non tanto sull’ascoltatore.
Per inciso, qui sta anche il portato più propriamente politico di un procedere siffatto. Potrebbe suonare paradossale per un artista che ha fatto del qualunquismo, della “medietà tutta italiana” e della rivendicazione di un’estraneità rispetto ai contesti più militanti ([…] mi hanno cacciato da ogni centro sociale / Perché non esprimo idee politiche varie / Attuo come se fosse terapia mi dà impulsi alla schiena con delle scosse / Io non descrivo rappresaglie e sommosse / Non è rap quello dei 99 Posse», da Faccio sul serio) le cifre caratteristiche della propria maschera autoriale.

Joseph Podlesnik, Autoritratto (da commons.wikimedia.org)
Eppure, il successo trasversale di Fabri Fibra, la sincerità con cui è riuscito a descrivere urgenze espressive condivise da una maggioranza più o meno silenziosa, la sua ambivalenza morale che è però il segno, innanzitutto, di un cortocircuito fra godimento interpersonale e responsabilità individuali («Può capitare di avere rapporti non protetti / sei scemo? Sei tu che non te lo metti / Ho qualche rima se mi permetti / Dipende dal modo in cui t’intrometti», da Scattano le indagini) interrogano in maniera viscerale le relazioni fra arte e impegno, fra semantiche poetiche e grammatica politica.
Le interrogano dal punto di vista delle “letture di fase” e dei metodi con cui scardinare le coscienze, in particolar modo quelle dei tanti “io” malleabili e auto-riferiti con cui siamo spinti a identificarci: in altre parole, il rapper marchigiano ha presentito, in maniera di gran lunga più vivida e meno ideologica rispetto ad altri, che nella nostra società erano in atto cambiamenti ineludibili, che, in quel “giro di boa” che è stato – per usare un termine certamente problematico e un po’ retrò, ma mai indagato fino in fondo – il berlusconismo, si è verificata una “mutazione antropologica” difficile da sottovalutare, o da prendere in forma puramente oppositiva.
Verrebbe quasi da giocare con i numeri, se non fosse che dalla critica culturale si salterebbe direttamente alla cabala: l’uscita dell’album Tradimento di Fibra e del romanzo Troppi paradisi di Siti avvengono tutt’e due nel 2006, ed entrambi gli autori iniziano a muovere i primi passi nella propria disciplina d’appartenenza nel 1994 (lo scrittore esordisce con Scuola di nudo, mentre il rapper fonda assieme a dj Lato il gruppo Uomini di mare), lo stesso momento in cui il Cavaliere compie la propria “discesa in campo”. Più precipuamente: nel loro corale intervento Rappolitik, i critici musicali Mattioli, Alemanni e Papetti descrivono con dovizia di particolari la parabola per cui, una volta esauritasi la propulsione delle posse e dei centri sociali come incubatori di nuova musica, parte del rap italiano si è fatta necessariamente più “osservazionale” e intimista.
Anzi, proprio in questa attitudine maggiormente orientata verso l’individuo e il privato, che ha comunque convissuto con un approccio più immediatamente militante e impegnato, va ricercata la componente della scena più efficace dal punto di vista politico a partire dal 2000 circa a oggi: se gruppi e singoli come Lou X, Assalti Frontali, Colle der Fomento, Frankie Hi-Nrg, Kaos One, gli stessi 99 Posse in qualche modo “criticati” da Fibra hanno cantato con diversi accenti e obiettivi l’attivismo dei movimenti e dell’antagonismo, facendo giustamente leva sul fatto che un tale attivismo è stato fino a un certo punto foriero di sentimenti emozioni visioni comuni, veri e propri percetti nel senso deleuziano del termine capaci di incendiare le masse, la marginalizzazione sociale di questo “calderone immaginifico e psichico” avvenuta nel nostro paese ha fatto sì che si rendesse necessario ri-orientare il proprio sguardo, che occorresse ricercare le fonti d’ispirazione per il proprio discorso artistico altrove.
Appunto, più nei percorsi individuali e soggettivi che nelle traiettorie collettive di protesta, più nelle irriducibili e intime delusioni che negli afflati spontanei di comunanza, come hanno fatto anche alcuni dei protagonisti della “prima ondata” (il già citato Lou X o il Neffa fuoriuscito dai Sangue Misto, per esempio).
Ma, attenzione: l’elemento di novità che Fabri Fibra introduce nell’immaginario musicale italiano (ma, viene da dire, culturale e politico tout court) è dato proprio dalla consapevolezza che tali percorsi individuali e soggettivi non fossero più disgiungibili dalle loro rappresentazioni mediatiche, che non ci fosse soluzione di continuità fra l’io concreto e sociale, nella materialità delle sue condizioni storiche, e i suoi riflessi televisivi, che invero quelle condizioni storiche informavano di senso e possibilità (e aspirazioni). L’«Italia seduta davanti alla Tv» (questa espressione è di Alessandro Leogrande) era dunque seduta davanti a uno specchio, distorto, deformante ed esagerato fin che si vuole ma non per questo poco fedele alla realtà inconscia della maggioranza della popolazione.

Pavel Filonov, Lavoratori (da commons.wikimedia.org)
O perlomeno, non poco fedele a uno spazio reale in cui si giocavano i criteri di validazione e riconoscibilità del merito, del successo, in definitiva dell’auto-realizzazione di ciascuno: uno spazio che Fabri Fibra non ha mai fatto mistero di abitare e ricercare, con cui ha scelto di confrontarsi sino alle estreme conseguenze dello spossessamento di sé. Qui sta lo scarto fra l’autore di Tradimento e altri rapper coevi, magari di eguale successo ma di gran lunga meno significativi sul piano della rilevanza musicale e politica: una differenza tutta giocata sull’intuizione, probabilmente inconsapevole, che, stante le mutate condizioni del nostro paese, a essere davvero sensibili e problematici non fossero tanto gli abissi sulfurei dell’io e del proprio vissuto, quanto i camuffamenti, le maschere sociali, i tortuosi e labirintici snodi attraverso i quali si sceglie di rappresentare il proprio sé in pubblico al limite della verosimiglianza («Io vengo in pace (Bugiardo) / Non mento mai (Bugiardo) / Non son capace (Bugiardo) / Non ce la fai (Bugiardo) / Ho mille amici (Bugiardo) / Non voglio guai (Bugiardo) / Tu sei tra questi (Bugiardo) / Ma non lo sai (Bugiardo)», esclama nella canzone-manifesto Bugiardo).
Perché è molto semplice e, per certi versi, “comodo” costellare la propria opera artistica di episodi e riferimenti autobiografici, presupporre cioè un’aderenza pressoché totale fra io personale e io letterario (o musicale), usando magari come collante un tono drammatico-confessionale e vagamente vittimistico, mentre ben più rischioso e complesso risulta indagare invece le linee di frattura fra l’io e il me, fra le identità private e le convenzioni esteriori, fare abiura – in ultima istanza – delle proprie autofinzioni.
Questa è la critica radicale cui Fabri Fibra – dai lambiccamenti barocchi di Sindrome di fine millennio alla letterarietà enfatica di Guerra e pace, passando per i provocatori parossismi di Mr. Simpatia o dalla sfrontatezza analitica di Squallor – ha sottoposto se stesso e, attraverso se stesso, la società tutta. O più precisamente, la “società dello spettacolo” che, per certi versi, ha rappresentato nel nostro paese tutta la società. «Fibra, fatti dare due baci / Non ho tempo, scusate signore / Vado a rapire la Gregoraci, poi chiedo il riscatto a Briatore / Lo chiamo e gli dico: / “Dammi i soldi e ti porto la soluzione / Cosa ti manca? Tranquillo ce l’ho io qua” / Questo è il mio disco e lo dedico alla nazione» (da La soluzione): il gioco del rapper di Senigallia è un gioco insolente e feroce, nella misura in cui però una tale ferocia serve a mettere in luce i rapporti di forza dello showbiz e il loro carattere irrimediabilmente fittizio, artefatto.
Se per la canzone A me di te, che irrideva con vituperi di stampo sessual-anatomico Valerio Scanu, Fabri Fibra è stato condannato a un risarcimento di ventimila euro nei confronti del cantautore sanremese, impagabile è il movimento per cui un tale battibecco legale rende esplicite delle dinamiche risapute, ma sotterrate nell’inconscio, e cioè che ogni rapporto che si svolge all’interno dell’industria cultural-mediatica è, alla lettera, un rapporto di “prostituzione” («il 99% di tutti i giornalisti pubblicati sono pennivendoli», diceva Lester Bangs, oppure in maniera più colorita ed esplicita lo stesso Fibra in Non fare la puttana: «Per questa roba ho pugnalato troppi amici / Per questa roba ho preso merda in troppi uffici / Ho fatto musica con i peggio falliti / Che ora vendono vernici come fossero vestiti»).
Inutile ricamare con sentimentalismi o prosopopee introspettive: ogni piccolo spazio di vera libertà espressiva lo si conquista presupponendo una possibilità reale di scontro e conflitto, senza esclusione di colpi («Il rap nel mio paese / non essere scortese»… ), e così, senza esclusione di colpi, nel corso della sua carriera Fabri Fibra ha scelto di indossare tutte le maschere, anche quelle più abiette e apparentemente maschiliste.
Com’è noto, Mr. Simpatia, album che lo ha reso un nome di culto ancor prima del passaggio a una major, è infatti un concentrato programmatico di misoginia, nichilismo, violenza verbale e meschinità assortite, che hanno procurato al rapper non poche critiche e accuse di sessismo e omofobia. Eppure, voler raccontare il male e la degradazione in maniera cruda – al di fuori, cioè, dei rassicuranti filtri dell’ironia o della denuncia sociale – non è anche un modo per esorcizzare quello stesso male e quella stessa degradazione? O, perlomeno, per esorcizzare il rischio che certe parole “proibite”, certi “cattivi pensieri”, rimangano infine sepolti nella sfera del non-detto, coperti dalla retorica delle buone intenzioni.
Dice appunto Walter Siti in Contro l’impegno: «[…] la letteratura cambia davvero le cose quando urta contro la propria impotenza, alleandosi a quei fondamentali temi umani che gli “esercenti di questa Terra” (politici, industriali, opinion makers) trascurano e rimuovono: la depressione, la noia, la convinzione che nulla abbia un senso, il lasciar perdere, il desiderio di schiavitù, il rancore, l’inconcludenza, la stupidera – il basso continuo della miseria umana da cui ogni volta le ideologie si dichiarano offese e sorprese».
Cos’è Mr. Simpatia se non il marchio rovente e spietato di una simile “alleanza”? Un’alleanza che, peraltro, si verifica come conseguenza dell’insufficienza di tante ideologie e moralismi che serpeggiavano al momento dell’uscita dell’album e che ancora serpeggiano come luoghi comuni nella nostra società: il culto del lavoro, la meritocrazia, l’aziendalismo, la natura ipocrita dei rapporti interpersonali («Faccio falsi aperitivi, poi non lo diresti mai / Che si conclude ogni rapporto con discorsi sbrigativi, continui / E ti ripeto: mi responsabilizzerò, ma che t’affanni? / C’è chi ci mette un mese e chi trent’anni», canterà successivamente in Ci penso dopo)… Il protagonista del disco – ovvero Fabri Fibra stesso “trasfigurato” nel personaggio di Mr. Simpatia – è un “uomo medio” frustrato dal proprio impiego e dall’ambiente che si ritrova attorno, oltre che dalla propria incapacità di stringere relazioni che non siano in una certa misura disfunzionali.
Le uniche vie d’uscita che vede di fronte a sé sono l’annichilimento e il suicidio («E se ancora non mi ammazzo / è grazie al cazzo», da L’uomo nel mirino) o il fantasticare sfoghi brutali e gratuiti verso i suoi “aguzzini” («Afferro per i capelli questa donna e faccio effetto / Cadendo a piedi in avanti la sbatto sull’armadietto / E non ne vale la pena / Se questo è un lavoro meglio farsi in vena / Almeno per un po’ non sentirò il problema / Vorrei vedere il mio capo andare in cancrena», da Rap in vena).
Ogni alleanza implica un certo grado di complicità: il carattere “scandaloso” e urtante di Mr. Simpatia ma, grosso modo, della quasi totalità della poetica di Fabri Fibra è dato dal fatto che ci ritroviamo a ridere, divertirci, essere partecipi di sentimenti ed emozioni di cui normalmente ci vergogneremmo. È difficile ascoltare un verso come «Ho letto che esistono madri con i figli handicappati / che li portano a puttane perché è giusto, vanno amati / lo ha suggerito il Papa, ma poi la cosa strana / è che questi vanno a troie quattro volte a settimana» senza provare un minimo di dolore allo stomaco. Ma, allo stesso tempo, quanto ci dice rispetto alla natura spesso a-morale, schizofrenica e tendenzialmente “ripugnante” (nei termini con cui la norma comune ci porta a definire ciò che è da considerare ripugnante) del desiderio?

(da Rapologia)
E quanto ci dice rispetto all’inefficacia di politiche retoriche discorsi “caritatevoli”, che nel loro agire non contemplino anche questo lato oscuro, questa cornice di senso forse imbarazzante eppure concretamente presente in ogni sforzo, individuale e collettivo, di emancipazione? Perché, poi, il punto realmente politico è che se con Fabri Fibra ridiamo, ci divertiamo e ci sentiamo partecipi di sentimenti ed emozioni di cui normalmente ci vergogneremmo, questo succede nella misura in cui siamo spinti a leggere tali sentimenti ed emozioni come sintomi e gesti di ribellione, ancorché velleitari e fini a se stessi.
Il ritornello «Io me ne sbatto il cazzo / di un lavoro in città» (ancora da Rap in vena), con la sua base incalzante e ossessiva, è davvero un sussulto d’orgoglio, un grido di “rabbia e amore” che non sfigurerebbe in nessuna mobilitazione contro il precariato o, più genericamente, contro le “normali” condizioni di vita della nostra società.
Non solo per il suo carattere assertivo e provocatorio, ma perché – nell’imporre con forza come metro di misurazione di “giustizia” solo e insindacabilmente il proprio “sentire” – ci ricorda che ogni cambiamento, ogni rivoluzione (se è concesso usare questo termine altisonante) vanno sempre rapportati alla moltitudinaria galassia dei bisogni e delle esigenze personali, devono trovare il proprio fondamento ultimo nella carne e nei vissuti di ciascuno. «La ribellione inizia quando non è più possibile fuggire dalla propria vergogna quotidiana», afferma la scrittrice turca Ece Temelkuran… similmente, la scrittura di Fabri Fibra è una scrittura capace di porsi – grazie anche al filtro inconscio dell’autofinzione – sempre “con le spalle al muro”, di situarsi in quel luogo simbolico in cui (per usare il bel titolo di un libro dedicato a Tommaso Labranca) le alternative non esistono, ovvero quel luogo in cui – se vogliamo prestar fede alla massima per cui «non abbiamo tutte le possibilità, ma solo la libertà di scegliere» – si dà dunque la vera emancipazione di tutte e di tutti.
Così, un verso come «Ora capisco, sono cresciuto sono cresciuto, sembro cresciuto? / Pago l’affitto a uno sconosciuto, a uno sconosciuto, a uno sconosciuto» (da Non c’è tempo) sembra davvero raccontarci della gerontocrazia, della sperequazione di risorse e del conflitto generazionale nei nostri contesti molto più di quanto lo facciano a volte mille saggi di teoria sociale e mille comunicati “combattivi”. Oppure, per venire a tempi più recenti, la graffiante satira dei costumi di Fenomeno («Fallo anche tu, eccome no / Si guadagna di più, è comodo / Qui nessuno diventa autonomo / Senza fare un po’ il fenomeno») mette in luce quella sorta di “doppio legame” e atteggiamento paternalistico che spesso investe i giovani e le giovani nella nostra società, per cui viene loro rimproverato di “stare sempre su Internet”, di isolarsi attraverso i social e la comunicazione telematica per diventare personaggi e “vendere la propria immagine”, quando dall’altro lato li si invita a fare null’altro che questo, fra esortazioni a non essere choosy e ingiunzioni a monetizzare i propri sentimenti, a far della loro esistenza un lavoro vero e proprio.
Più in generale, la poetica di Fabri Fibra tanto ci racconta di un’eccedenza – sempre più acuta, quanto più le nostre relazioni si danno nello spazio del “virtuale” – dell’io rispetto alla vita, della coscienza rispetto a ciò che viene quotidianamente esperito.
Nel finale del suo ultimo romanzo La natura è innocente – che prende l’abbrivio da due differenti casi di cronaca – Walter Siti ci fa capire che ha avuto bisogno di analizzare nel profondo le vicissitudini di due biografie differenti dalla sua per scoprirsi ulteriormente, per «scavare qualche metro del (suo) tunnel, dove ormai (gli) sarebbero mancate le forze per spinger(si) da solo». Così, Fabri Fibra ci fa capire che, ora più che mai, non c’è alcuna possibilità di esprimersi se ci si presuppone uguali a se stessi, se non si compie quel salto che corrisponde al dirsi diversi da ciò con cui ci si identifica. Che non esiste – in definitiva, e come già ammoniva Marx – nulla di più prezioso che “ un altro essere umano”, quale poi in fondo siamo noi stessi.
Immagine di copertina di Andrea Di Quarto (da commons.wikimedia.org)
