cult

CULT
Profugo nella sua dimora
Con “Avere. Sulla natura dell’uomo loquace”, il suo ultimo saggio da poco pubblicato da Bollati Boringhieri, Paolo Virno presenta il vivente umano come animale paradossale, che deve sempre di nuovo incontrare, e fare sue, le prerogative innate che lo caratterizzano
Tra le 219 proposizioni condannate dal vescovo di Parigi Étienne Tempier, con l’editto del 7 marzo del 1277, ce ne è una che più di tutte fu motivo di scandalo: «homo non intelligit». Scandalo e ostilità, tenendo in conto la fine che fece il seguace più autorevole di tale tesi: cacciato dall’università parigina, Sigerus de Brabantia cercò rifugio a Orvieto, dove fu accoltellato dal suo segretario. Per fortuna sua e nostra, Paolo Virno non ha segretari né ambisce ad averne e, nonostante abbia già conosciuto la durezza dell’ordine costituito, non ha mai smesso di fare del pensiero una «macchina da guerra». E così, dunque, la blasfemia riappare.
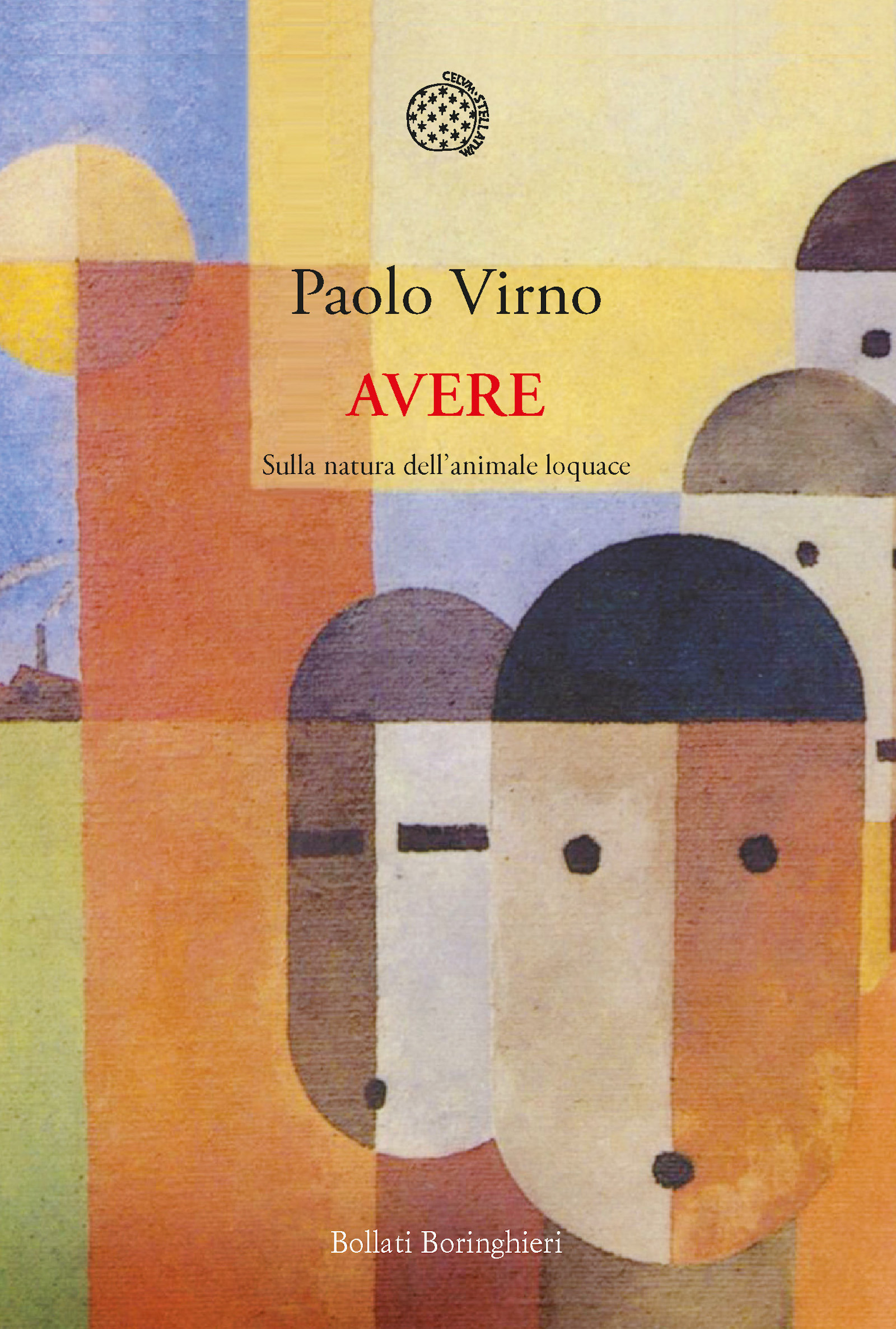 La tesi in questione fu ispirata da un filosofo maledetto del XII secolo, l’arabo di Cordova al quale dobbiamo – più di quanto non si ammetta ancora oggi – la conoscenza di Aristotele: Ibn Roshd, meglio noto come Averroè. Ma quale il motivo dello scandalo e, soprattutto, cosa c’entra la proposizione odiata dalla Chiesa di Giovanni XXI con Avere. Sulla natura dell’uomo loquace (Bollati Boringhieri, 15 euro), l’ultimo saggio di Paolo Virno? Se è proprio il nostro modo di pensare che ci distingue dalle altre specie, come si può affermare che l’animale che siamo non pensa? Semplice: ciò che ci fa quello che siamo, la nostra essenza, è «qualcosa di imprescindibile, certo, ma anche di estrinseco» (p. 16). Averroè limitava l’esteriorità all’intelletto, sia quello possibile che agente, definendoli entrambi unici per l’intera specie, dunque impersonali ed eterni. Mandando così a farsi fottere la volontà e i peccati dell’individuo sovrano, e su tutte le furie Tommaso, il roccaseccano di successo a Parigi. Paolo Virno, che pure torna a più riprese su Aristotele, si spinge oltre: non è solo il pensiero genericamente inteso a essere estrinseco, ma la natura tutta che ci contraddistingue. A dar conto di questa estraneità costitutiva, un verbo non poco sottovalutato dalla speculazione più squisita: il verbo “avere”, appunto. Abbiamo, e non siamo, la nostra facoltà di linguaggio, il nostro corpo, i nostri desideri.
La tesi in questione fu ispirata da un filosofo maledetto del XII secolo, l’arabo di Cordova al quale dobbiamo – più di quanto non si ammetta ancora oggi – la conoscenza di Aristotele: Ibn Roshd, meglio noto come Averroè. Ma quale il motivo dello scandalo e, soprattutto, cosa c’entra la proposizione odiata dalla Chiesa di Giovanni XXI con Avere. Sulla natura dell’uomo loquace (Bollati Boringhieri, 15 euro), l’ultimo saggio di Paolo Virno? Se è proprio il nostro modo di pensare che ci distingue dalle altre specie, come si può affermare che l’animale che siamo non pensa? Semplice: ciò che ci fa quello che siamo, la nostra essenza, è «qualcosa di imprescindibile, certo, ma anche di estrinseco» (p. 16). Averroè limitava l’esteriorità all’intelletto, sia quello possibile che agente, definendoli entrambi unici per l’intera specie, dunque impersonali ed eterni. Mandando così a farsi fottere la volontà e i peccati dell’individuo sovrano, e su tutte le furie Tommaso, il roccaseccano di successo a Parigi. Paolo Virno, che pure torna a più riprese su Aristotele, si spinge oltre: non è solo il pensiero genericamente inteso a essere estrinseco, ma la natura tutta che ci contraddistingue. A dar conto di questa estraneità costitutiva, un verbo non poco sottovalutato dalla speculazione più squisita: il verbo “avere”, appunto. Abbiamo, e non siamo, la nostra facoltà di linguaggio, il nostro corpo, i nostri desideri.
Zóon lógon échon: del refrain dello Stagirita, tutti ricordano e ripetono senza sosta i due sostantivi, attribuendo valore nullo al verbo. Mentre è proprio quest’ultimo, secondo Virno, a mostrare la natura paradossale di un vivente che non coincide con se medesimo, che di volta in volta deve possedere le prerogative – quali il pensiero verbale – senza le quali non sarebbe ciò che è. Nello stesso tempo, l’animale umano vive un cronico e perturbante distacco dalla sua natura esattamente perché ha, e non è, la facoltà di linguaggio che rende possibile il verbo “avere”. Visto che «innanzi tutto e per lo più» parliamo gesticolando, come consente la postura eretta e la libertà della mano che altrettanta libertà concede alla lingua e alla voce, proprio per questo succede che non parliamo affatto, smettiamo di saper parlare, d’improvviso balbettiamo, sosteniamo con angoscia inenarrabile il turno di parola in assemblea. Siamo profughi – afasici dall’inizio e sempre di nuovo – nella nostra familiare dimora.
È bene che un ragazzo non più giovane del fan club dica la sua senza girarci attorno: Avere, di Paolo Virno, è l’opera più importante. Completa il Saggio sulla negazione (2013) e ricapitola, innovando, le fatiche di tre decenni. Meglio essere più precisi: ripercorrendo il sentiero della sua originale antropologia filosofica, Virno produce uno scarto ulteriore, immergendo la storia nei tratti innati della specie, facendo di questi un’aggiunta labile e provvisoria, come tale sempre segnata da congiunture storiche e vicende biografiche. Non c’è pagina del libro che non meriterebbe attenzione minuziosa, ma, affinché la minuzia non manchi ai lettori di me meno fanatici, preferisco selezionare tre momenti luminosi – nel senso che illuminano un pensiero che, del presente, prova a cogliere l’eterno. In ordine di apparizione: l’amicizia, la partecipazione, l’Io diviso.
Se il nemico è categoria politica per eccellenza, ciò per il giurista nazista sempre di moda, l’amicizia attiene alla dimensione antropologica, ovvero al rapporto di possesso che intratteniamo con la nostra natura. Al pari di Aristotele, Virno ritiene che l’amico sia un héteros autós, un altro sé. Ma è tale, ed questo quello che conta, perché ciascuno di noi è in primo luogo straniero a se stesso. Il distacco dalla propria essenza, che rende maldestro e inquieto l’animale che ha linguaggio, costituisce la radice dell’amicizia. Se è indubitabile che la nostra storia è costellata di conflitti e sofferenze, è altrettanto vero che non c’è vivente umano senza amicizia. Per tornare ad Aristotele, il syzèn, il «vivere assieme», che fa l’amicizia è reso possibile dalla non coincidenza di ciascuno di noi con le prerogative che pure distinguono la nostra specie. Ancora meglio: è la stessa amicizia a rendere possibile la capacità autoriflessiva, ovvero quel tratto distintivo dell’animale che parla. Il riferimento a sé è sempre una eteroaffezione, l’amicizia, che pure non sarebbe tale senza il distacco che ci rende umani, rende umani gli animali che hanno, e non sono, la propria essenza. Il carattere antropogeno dell’amicizia ovviamente non basta, senz’altro non dà conto dell’amicizia di Paolo con Valerio o con Mario. Perché Paolo ha avuto per amici proprio Valerio e Mario e non altri? È una questione di stile: con l’amico ci accomuna un certo modo di avere la nostra natura, di mettere in forma la nostra vita. Se l’amicizia finisce, è perché si smette di sperimentare, il condiviso esercizio di stile viene meno, l’uso della natura che ci appartiene si atrofizza; per pigrizia, per paura o rassegnazione, si coincide per intero con questa o quella “parte in commedia”.

La partecipazione delle idee è concetto platonico tra i più importanti, senz’altro il punto più elevato dell’idealismo tutto. Antico, come antico è Platone, sempre ripetuto da chi vede nel mondo solo una caduta, un’emanazione che è pur sempre, alla fin fine, una degradazione. Non stupisce che tra neoplatonismo e cristianesimo il rapporto non sia stato banale. Virno in primo luogo scompone il verbo, metéchein, dando rilievo a échein, “avere”, e ricordando che metá corrisponde a “con”, “per mezzo”, “tra”. Così facendo, indica una traduzione suggestiva: «accogliere, prelevare, lasciarsi contagiare, utilizzare» (p. 85). La nuova blasfemia materialistica allora afferma che le idee non sono forme eterne che preesistono alla partecipazione, sono invece il risultato della partecipazione stessa. E la prima partecipazione che ci riguarda è quella, sempre condivisa con altri, della nostra natura. Essendo questa la nostra e, nello stesso tempo, un che di separato e di non identico di cui ci dobbiamo appropriare, «la partecipazione è prassi», chiarisce Virno. Per chi ha fatto di quest’ultima una sfera ben delimitata, attinente alla politica e ai parlamenti educati, lo scacco è evidente: prassi è il nome del nostro comune mettere in forma la vita, ovvero ciò che Wittgenstein chiamava «abitudini, usi, istituzioni». Animali istituzionali, questo siamo, dunque enti naturalmente storici. Più precisamente, partecipando noi della nostra essenza, esibiamo il tratto contingente del necessario e, nello stesso tempo, la necessità inaggirabile del contingente «prelievo utilizzante».
Segnò l’epoca, in particolare quella ribelle dei Sessanta e seguenti, uno «studio di psichiatria esistenziale» dal titolo L’Io diviso (1959). Ronald Laing, l’autore allora ventottenne, aveva con acume raro combinato la clinica e i concetti più rilevanti dell’Essere e il nulla di Sartre (mescolanze spregiudicate, quelle tra medicina e filosofia, per diversi decenni respinte con furia reazionaria, da poco tornate di moda grazie alle neuroscienze più ardite). Secondo Laing, radice della schizofrenia è una cronica insicurezza ontologica che si accompagna, in prevalenza, a un vero e proprio sdoppiamento dell’Io, tra corporeo e incorporeo, esteriore e interiore. Virno, che non si occupa di sofferenza psichica, propone invece di pensare l’Io in generale e fin dall’origine diviso, dovendo noi umani sempre di nuovo appropriarci della facoltà di linguaggio, della neotenia, del nostro corpo polivalente, ovvero incontrare – e non c’è nulla di più aleatorio di un incontro – le nostre innate prerogative specie-specifiche. «Je est un autre» (Io è un altro), scriveva Rimbaud nel maggio della Comune (1871); Virno concorda, con Rimbaud e pure con la Comune. Se insistiamo, poi, sul dualismo costitutivo del quale Avere dà conto, tornano alla mente le parole profane della canzone pop: la vita è tutto un equilibrio sopra la follia.
Chiudo con un rompicapo e uno sguardo sulla politica del nostro tempo, e in avanti. Siamo certi che il possesso non sia transitivo? Proprio perché ho, e non sono, il pensiero verbale, da questo sono a volte posseduto così fortemente da dimenticare di avere pure un corpo, col suo singolare desiderio di riposare, di stare in silenzio, di ballare e nient’altro. La non coincidenza col corpo che mi è dato fa del corpo, e le sue forme, il comando imperioso di una vita nella quale il pensiero è un incidente funesto. Rafforza gli esempi un cenno alle droghe che vanno per la maggiore: cocaina e amfetamina annullano o riducono i limiti del corpo, destituendo il sonno, emarginando il riposo, spesso combinandosi con il lavoro cognitivo «24/7»; l’MDMA e la ketamina non di rado celebrano un corpo ineffabile, che meno parla e più sente, un despota reattivo alla dittatura della «chiacchiera informatica». Vero, non c’è grandezza senza possessione. In ogni filosofo, ci insegna Čechov, c’è anche e sempre un «monaco nero»; ma non tutti i monaci neri sono filosofi, o semplicemente pazzi. Il fatto che abbiamo la nostra essenza, e non la siamo, è motivo di bellezza sconfinata come di sofferenza emotiva, di esistenze poliedriche e di quelle unilaterali, di creatività esplosiva e di monotonia sfiancante. Ora lo sguardo sul passaggio d’epoca: l’animale “eccentrico”, che ha, e non è, la propria vita, è capace di sentire la vita altrui, di farla propria, di lottare senza sosta contro la sofferenza che altri patiscono. Esibiscono la natura del vivente che non coincide con se medesimo le rivolte di Black Lives Matter negli Stati Uniti, gli scioperi globali femministi contro la violenza maschile, i salvataggi dei migranti nel Mediterraneo. Potrei citare molti altri eventi politici ultimi, ovviamente, ma in modo non casuale insisto su quelli che più di altri saldano fino a confondere la lotta di classe e quella contro l’oppressione, sia essa di “razza” o di genere, o entrambe assieme. Solo un vivente cronicamente “fuori posto”, che non coincide con la propria esistenza, può lottare per quella altrui e di tutti, perché solo così difende la propria.
Venerdì 20 novembre, dalle ore 18 in diretta streaming sulla pagina fb di DINAMOpress
In copertina, Allegoria dei cinque sensi dei fratelli Preti
