cult
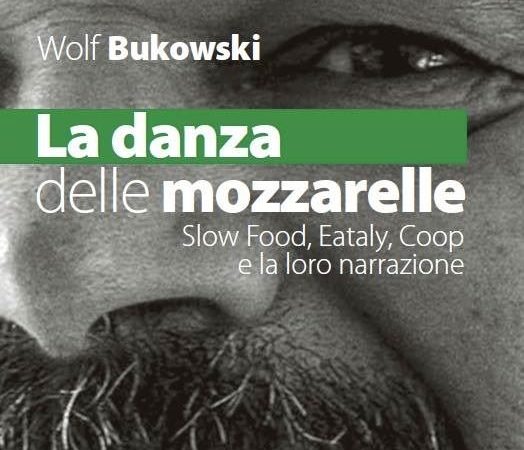
CULT
Lost in the supermarket
Recensione de “La danza delle Mozzarelle”, dal 25 marzo in libreria per Alegre.
Oscar Farinetti è senza alcun dubbio l’imprenditore simbolo dell’Italia renziana. La sua figura funziona da anello di congiunzione tra l’aziendalismo berlusconiano e l’ideologia profonda del Partito della nazione. In “La danza delle mozzarelle” (Alegre, 158 pagine, 14 euro), Wolf Bukowski ci aiuta a comprendere come questo passaggio di testimone non possa essere ridotto a pratiche inciuciste o al perseverare della corruzione: c’è qualcosa di più profondo, che attiene alla sfera politica e culturale, all’idea di paese, che Farinetti e ciò che lo ha spinto a divenire il master chef della grande distribuzione rappresentano.
L’uomo che ha mantecato il supermarket per dargli un altro sapore e coprirne le magagne ha utilizzato come ingredienti base due luoghi comuni: due frasi fatte che diamo per assodate e che, come capita per le costruzioni ideologiche più subdole, paiono innocenti e persino di buon senso. Il primo componente retorico viene miscelato da anni dagli opinionisti, compare nelle ricette di editorialisti di bocca buona, è il tocco segreto di imprenditori dal volto umano. È efficace perché contiene un indubbio retrogusto di moralismo. Eccolo: “Spendiamo più per comprare un telefonino che per nutrirci”. Bukowski, dati alla mano, decostruisce questo luogo comune. Ne dimostra l’inconsistenza logica e ci conduce a comprenderne l’essenza più profonda, il messaggio nascosto (“Spendete di più per mangiare”) in un paese che per il cibo ha sviluppato una vera ossessione, portando al centro di talent show televisivi, riempendone pagine di giornali. Si tratta dell’aspetto dell’ideologia farinettiana più legato al consumo e alla sua supposta forza rivoluzionaria, che si afferma grazie a trent’anni di neoliberismo e alla capacità del capitalismo di appropriarsi di discorsi costruiti dai suoi oppositori per condurli dalla sua parte. Ogni controrivoluzione ben riuscita si appropria di istanze che provengono dalla rivoluzione. Un atto individuale, deresponsabilizzante e mediato dal denaro, diventa forza di cambiamento. Basta “saper scegliere” un prodotto da uno scaffale per contribuire a migliorare le cose! Il sogno di ogni liberista.
Anche il secondo ingrediente fondamentale risuona da tempo. Lo avrete riconosciuto anche voi galleggiare nel pentolone dei luoghi comuni: “Potremmo campare tutti di turismo”. Oscar Farinetti l’ha gettata nel calderone, questa frase strafatta, senza mancare di condirlo con parole forti: “Per me nel Sud c’è un’unica cosa da fare: un unico grande Sharm el-Sheikh”. Detassare i profitti, deregolare il lavoro, facilitare l’opera di speculazione e di messa a valore dei territori. Come questo progetto distopico possa avere la sua genealogia nel primo “Gambero Rosso” (che nacque come allegato al Manifesto), passi il tramite di Carlin Petrini e Slow Food. Si parla, in questo volume prezioso e impavido, di come questa ideologia possa papparsi la storia della Resistenza e quella della sinistra italiana,Bukowski spiega con dovizia di documenti e senza saltare passaggi come si giunga al mito del consumo e dell’accettazione delle forze del mercato. Perché va bene “spendere di più per mangiare”, ma non basta la domanda interna. E la divisione globale del lavoro richiede che l’Italia sia terra di conquista, piattaforma per compratori, supermercato pieno di offerte. Bisogna attrezzarsi, recita Farinetti ricalcando il programma di Renzi (o forse il contrario) per attirare gli investitori.
La narrazione in questo senso senso attiene al carattere fantasmagorico delle merci, è un elemento strutturale e non di complemento. La coreografia dei latticini del titolo fa riferimento alle pagine psichedeliche in cui Marx spiega come sia possibile che una merce nasconda i rapporti sociali che contiene. Un tavolo, spiega Marx, serve per mangiare, per appoggiarvi i gomiti e studiare, per lavorare. Tuttavia, non appena si considera il mobile come “valore di scambio”, ecco che questo prende forma: “Il tavolo si trasforma […]. Non solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare”. Sono passi visionari e paradossali, cui si aggiunge un paradosso ulteriore, che il nostro autore descrive bene. Nel caso della produzione postmoderna di Farinetti e della filosofia che si autorappresenta come “lenta” che lo legittima, i rapporti sociali vengono esibiti, distorti e piegati alle esigenze dell’imprenditore. Se produrre è sempre più un atto sociale, che si ciba del linguaggio, della cultura e di ciò che fino a qualche decennio fa non valicava i muri della grande fabbrica, allora mai come nel cibo bisogna mettere le mani avanti, costruire apparati fantasmagorici che, appunto, mettono in secondo piano il costo sociale della precarietà utilizzando reti sociali e sensibilità diffuse come grimaldello, trasformando la storia dell’alimentazione e più in generale quella contadina e gastronomica in un rosario di feticci da tirar fuori all’occorrenza. Se il conflitto riguarda la vita in quanto tale, soprattutto nelle faccende alimentari, saranno la vita in quanto tale e il patrimonio storico di un paese a diventare oggetto di colonizzazione. Così, se Petrini almeno si indigna di fronte agli scandali dello schiavismo della filiera agricola e al lavoro sottopagato (salvo poi non citare esplicitamente le responsabilità della grande distribuzione), Farinetti spiega ad un contadino che il prezzo basso di un bene è dovuto all’incapacità di saperlo “narrare”, da cui deriverebbe che l’eventuale costo del lavoro dovrebbe ricadere tutto sui consumatori e che l’unica strada contro lo sfruttamento, in un mondo che non prevede conflitti, si percorre imparando a raccontare meglio le storie.
Questo libro è anche un’inchiesta on the road nel Belpaese che si taglia come una fetta di formaggio Dop. C’è Torino, capitale di Eataly e Slow Food, capofila della transizione al postindustriale e territorio da cui proviene il renzianissimo Sergio Chiamparino, che dalla politica è passato alla finanza di Intesa San Paolo (che investe in Slow Food e fa affari con Farinetti ed Expo) e ne ha fatto ritorno. C’è Bologna, capitale delle Coop e sede della Disneyland del cibo. C’è la Firenze del presidente del consiglio. C’è il Sud, che Farinetti descrive, attingendo al repertorio dell’orientalismo esotico, come terra posta al di fuori delle logiche di mercato, spazio selvatico in attesa di divenire una specie di portaerei da crociera nel Mediterraneo. C’è ovviamente la Milano dell’Expo, il grande evento globale dedicato per l’appunto all’ideologia del cibo e che presenta il rischio, come racconta Bukowski citando la testimonianza dei piccoli produttori critici, di introiettare definitivamente dentro le reti della grande distribuzione organizzata i marchi cosiddetti etici. Perché lo scopo non è produrre in maniera equa e solidale, ma presentare l’opzione “equa e solidale” come una delle tante a disposizione del singolo consumatore, perso in un supermercato grande quanto la città infinita.
