cult

CULT
Deleuze oscuro: verso la distruzione di questo Mondo
Esce oggi per i tipi di Mimesis “Dark Deleuze” di Andrew Culp (a cura di Francesco Di Maio e con saggi di Rocco Ronchi e Paolo Vignola), tentativo di riportare Deleuze alla sua originaria “forza dissociatrice” dandone un’immagine oscura e crudele, avversa tanto all’idea di Mondo quanto all’attualità della sua stessa filosofia
In un suo noto scritto dedicato a Differenza e ripetizione, Michel Foucault preannunciava già che il nostro sarebbe stato un secolo deleuziano. Una previsione decisamente tempestiva, se si pensa a come la filosofia di Gilles Deleuze sia brevemente riuscita a divampare in una quantità sorprendentemente variegata di domini del sapere: lungi dal limitarsi a stravolgere l’universo della filosofia accademica, il pensiero di Deleuze ha presto invaso sensibilmente gli ambiti dell’ecologia, della cibernetica, della theory fiction, della musica, dell’architettura e delle controculture. Concetti quali la differenza, il rizoma, l’intensità, il molecolare, il concatenamento sono diventati ormai termini che respirano di un’autonomia propria, tanto indipendenti quanto decisivi per allargare gli orizzonti della pensabilità del mondo e della turbolenta epoca in cui viviamo. Tuttavia, anziché accomodarsi su di un’immagine fissa, il ritratto di Deleuze che scaturisce da questo incessante abbeveraggio ermeneutico appare come qualcosa di fascinosamente mostruoso, interpellandoci nel senso doppiamente deleuziano del termine: mostruoso è qualcosa di “composito”, un patchwork di saperi e discorsi che si intessono e si attraversano in una maglia di materiali eterogenei e, contemporaneamente, l’«estrema determinazione» che «consente all’indeterminato di sussistere» (G. Deleuze, Responses to a Series of Questions, in Collapse, vol. III, Urbanomic, Falmouth, 2007, p. 39). Una mostruosità etica ed epistemica dunque, che per estensione arriva a lambire anche le soglie del pensiero, fino a farlo niccianamente coincidere con il mostro tout court. Ereditare Deleuze implica di conseguenza fare i conti non solo con la mostruosità di quest’ultimo, e cioè con le sconvolgenti capacità che la sua filosofia offre al pensiero, ma anche con quella della propria mente: essere deleuziani, oggi, significa forse accogliere in sé e al di là di sé la mostruosità formale di ogni pensiero.

Una simile traiettoria interpretativa non costituisce certo una novità: già Alain Badiou, descrivendo il suo personale “non-rapporto” con Deleuze, ammoniva i posteri che un vero “deleuzianismo” sarebbe prosperato solo al di fuori degli accoglienti salotti dell’ortodossia, in un terreno aperto alle intemperie del reale, in cui ciascun presunto deleuziano sarebbe stato chiamato a ridefinire costantemente l’apparato concettuale del filosofo francese (A. Badiou, Deleuze. Il clamore dell’essere, Einaudi, Torino, 2004). Anche Robin Mackay ha recentemente ribadito l’impossibilità di costruire un deleuzianismo definitivo, proponendo tutt’al più che tale operazione possa avvenire soltanto attraverso un’incommensurabile serie di «ritagli», «sezioni […] trasversali» e brandelli di “collage”: anche quando crediamo di aver catturato un’immagine “totale” di Deleuze, scrive Mackay in un volume significativamente intitolato Unkown Deleuze, possiamo stare sicuri che essa ci sfuggirà di nuovo, all’infinito. (R. Mackay, Editorial Introduction, in Collapse, cit., p. 38)
Non si tratta soltanto di «dare un [ennesimo] figlio» a Deleuze, e cioè di continuare ad alimentare la macchinazione del suo pensiero pilotandolo verso impensabili destinazioni, ma anche di aborrire la propria filiazione, diseredare la struttura del pensiero dalla spietata ricorsività del concetto. È stato proprio Deleuze a sottolineare più volte la necessità di preservare una falla tra il concetto e la sua paternità, tra il padre e la propria mostruosa progenie, come quando in Cinque proposizioni sulla psicoanalisi arriva a ripudiare alcuni suoi fortunati termini accusandoli di essere una pericolosa “trappola”:
«Quando un termine è lanciato, e ha un minimo di successo, come è accaduto per “macchina desiderante” o per “schizoanalisi”, o lo si riprende, e allora è molto increscioso, è già il recupero, oppure ci si rinuncia, bisogna trovarne altri, e spostare tutto. Ci sono parole che Félix e io sentiamo che è per noi urgente non usare più: schizoanalisi, macchina desiderante, è orrendo, se li usiamo, siamo presi in trappola» (G. Deleuze, Cinque proposizioni sulla psicoanalisi, in L’isola deserta e altri scritti, Einaudi, Torino, 2007, p. 354).
Creare mostri e aborrirli, lanciare termini e abbandonarli senza che essi si rapprendano nella normatività del concetto, è probabilmente l’essenza stessa di quell’imparare “con” che Deleuze distingueva fermamente dal passivo imparare “da”: un infaticabile lavoro di assemblaggio di mostri, anziché di simulacri.
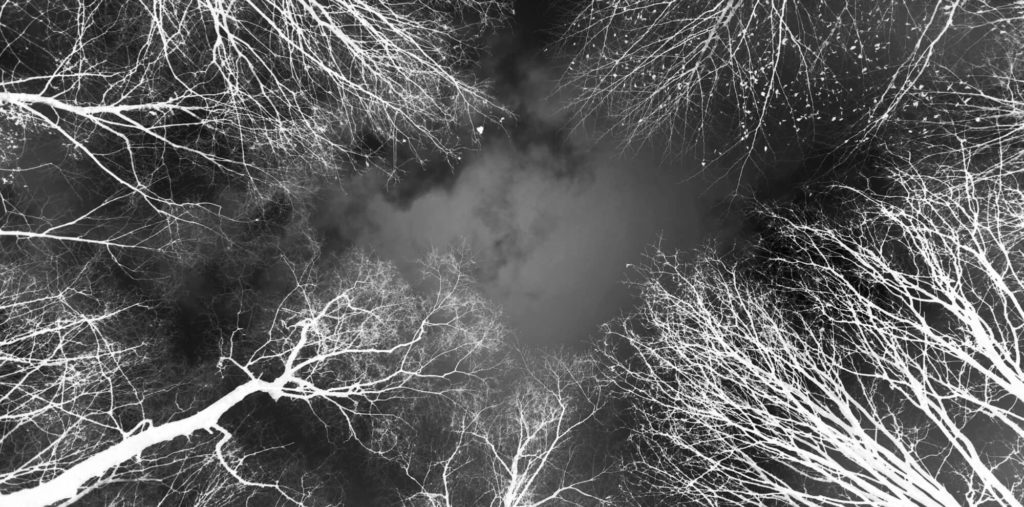
Dark Deleuze è un testo che esaspera questo mantra, e che intende dare a Deleuze «un ennesimo figlio», ma che sia il più mostruoso e rinnegato di tutti (A. Culp, Dark Deleuze, Mimesis, Milano, 2020, p. 33). Un figlio che, per ammissione dell’autore, non sarebbe riconosciuto neanche dallo stesso Deleuze. Finalmente tradotto in italiano per Mimesis e impeccabilmente curato da Francesco Di Maio, il libro di Andrew Culp è un richiamo al (dis)ordine dell’eredità deleuziana, un pamphlet sterminatore di discendenze che setaccia e rade al suolo le barricate del pensiero critico contemporaneo per far riemergere il volto più oscuro e apocalittico di questo mondo. Più che divenire partecipe di questa gloriosa progenie, l’intento di Culp è di sabotare la macchinazione deleuziana, creare «vacuoli di non-comunicazione» (ivi, p. 38) all’interno dei suoi tessuti che sfibrino la trama dell’attualità. Per Culp, anarchico radicale, anti-globalista facinoroso e militante della cosiddetta anti-politics, la figura di Deleuze sarebbe ormai stata saturata dalla propria filiazione, finendo per reinscriversi in quelle stesse logiche reazionarie che essa si prefiggeva tanto arditamente di combattere. Da un lato, tale figura sarebbe rimasta intasata all’interno di un vortice interpretativo fine a se stesso, spudoratamente accademico, barricandosi in una roccaforte ortodossa e impermeabile a qualunque setaccio critico. Nella sua radicalità, Culp non esita a tirare dentro questo ampio mucchio (a volte persino forzatamente) approcci decisamente differenti tra loro, come la flat ontology, il deleuzismo democratico, l’accelerazionismo e le identity politics. Pur partendo da propositi apparentemente rivoluzionari infatti, questi ‘figli’ di Deleuze dissimulerebbero presto la propria mostruosità, stemperando il proprio arsenale da guerra in «un milione di angoli smussati» (ivi, p. 53). Dall’altro lato, gli aspetti più selvaggi ed eversivi del pensiero del filosofo francese sarebbero finiti preda dei geni del capitalismo cognitivo della Sylicon Valley e dei guru della tecno-informazione, che avrebbero adottato Deleuze come «paladino dello status quo» (ivi, p. 10), tramutando le sue opere in una paradossale lettura di ispirazione per gli ingegneri del Controllo di massa.
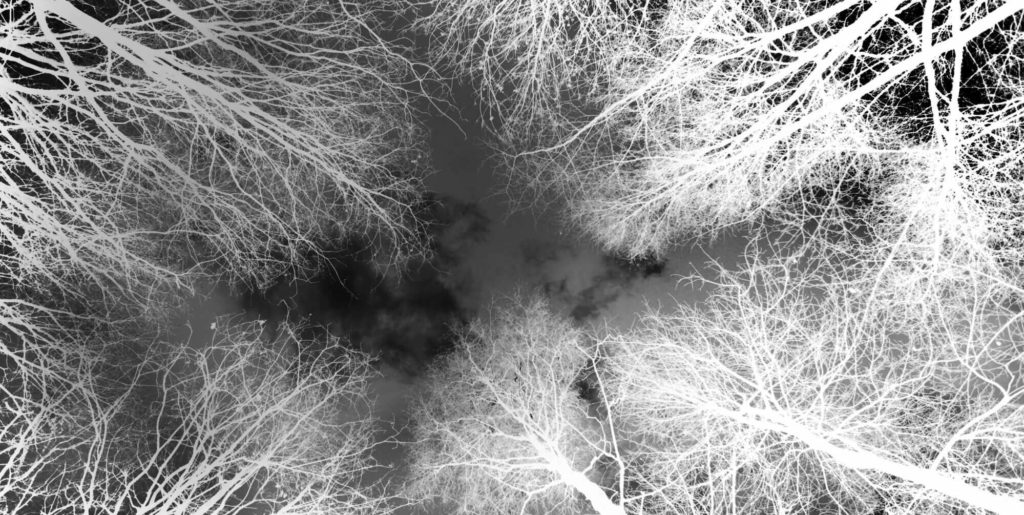
Per quanto apparentemente distanti tra loro, entrambe queste misappropriazioni convergerebbero in quello che Culp chiama il Joyous Deleuze, una macchina concettuale le cui creazioni si limiterebbero a riflettere un mondo «uguale a se stesso», in cui il compito della filosofia non è più quello di «creare concetti», produrre aborti, generare mostri, ma preservare l’esistenza di ciò che è, immutabilmente. A caratterizzare il Deleuze gioioso sarebbero proprio due tendenze che, agli albori della diffusione della filosofia deleuziana, hanno riscosso vasta eco nel panorama culturale occidentale: la connettività e il produttivismo. La prima, concepibile come quel processo di «integrazione che costituisce il mondo in una rete che si espande», opera attraverso «l’inclusione promiscua» di elementi apparentemente irrelati, segregandoli in un «corpo unico», che può essere dunque facilmente sorvegliato e messo a profitto (ivi, p, 88). La fantasia finale del connettivismo è di rendere «tutti e tutto parte di un solo mondo» (ivi, p. 37), disperdere le pieghe della complessità nel culto oceanico della sinergia e della trasparenza completa (internet non è forse la più micidiale delle reti rizomatiche?). Questo sogno è particolarmente evidente nelle politiche a “ecologia aperta” à la Google, in cui l’ottimismo per la connessione senza limiti si rovescia nella solidità espansionistica delle sovrastrutture dell’informazione e nell’ubiquità del Controllo. Il produttivismo, d’altro canto, opera in parallelo con le logiche connettiviste e si basa sui principi formali dell’accumulazione e della riproduzione, gli stessi con cui il Capitalismo riafferma costantemente la propria egemonia. Nel produttivismo tardocapitalista, ogni produzione è sempre-già segregata come riproduzione e ad essere ricorsivi sono solo i circuiti cannibali, quelli capaci di espandersi e proliferare a discapito degli altri.

Al Deleuze «gioioso pensatore della confusione del mondo» (A. Badiou, Deleuze, cit.), Culp oppone un Deleuze oscuro e crudele, avverso tanto all’idea di Mondo quanto, per certi versi, all’attualità della sua stessa filosofia. Che questo sia un secolo deleuziano, scrive Culp riprendendo Foucault, è una constatazione puramente sardonica, che ci offre un Deleuze ideologicamente troppo attuale, prigioniero delle nefandezze del nostro tempo e, per questo, docile e dissanguato, totalmente privo della sua originaria «forza dissociatrice» (A. Culp, Dark Deleuze, cit., p. 62). Il pessimismo apocalittico di Culp, miscelato con la foga eversiva dell’anarchismo e del nichilismo, fa terra bruciata di ogni mediazione possibile, gettando un anatema sul presente che lo pone ad una distanza tanto siderale quanto – per certi versi – ontologica dal futuro. Il thatcheriano “there is no alternative”, successivamente rilanciato in chiave critica dagli scritti di Mark Fisher e della weird philosophy, è per il Dark Deleuze un ostacolo reale, che non concede patteggiamenti con lo status quo: di fronte al realismo capitalista e all’irreversibilità suicida del nostro destino, non ci resta che rigettare la luce, “oscurare” e distruggere il Mondo.

In tal senso, quello di Culp può essere letto come un rinnovato invito ad abbracciare il Sole marcio ed epilettico di Bataille, il nocciolo folle e putrido che pulsa al di sotto dell’irradiazione dei raggi solari: divenire complici di un’oscurità vivida, che agli occhi di questo Mondo così astratto non può che apparire «orribilmente brutt[a]», sfigurata dalla smorfia della follia (G. Bataille, Sole Putrido, in Documents, Dedalo, Bari, 1993). Appellarsi al Deleuze oscuro vuol dire discendere «dalla cappella alla cripta del suo pensiero» (A. Culp, Dark Deleuze, cit., p. 44), abitare quel territorio di desolazione in cui il potere autoalimentante della cartografia viene meno, e dove alla disamina concettuale non subentra un apparato di concetti più “illuminati”, chiari e distinti, ma la decomposizione stessa della produzione concettuale tout court. Ecco perché, nel presentare il proprio armamentario di termini e nuclei tematici, Culp non opta per l’opposizione muscolare (un braccio di ferro che, nella migliore delle ipotesi, si risolverebbe nell’ennesima prevaricazione del più forte), ma vira verso un’asimmetria radicale, in cui la negatività opera come un vettore di destrutturazione antinomico e non dialettico. Laddove il rizoma dispiega mondi e dissemina concetti, la «spiegatura» del Dark Deleuze boicotta la proliferazione e manomette il processo di macchinazione; mentre il Deleuze gioioso celebra le indomabili forze dei corpi, Culp scatena i poteri del falso e della cospirazione; all’abitabilità del nomos subentra l’«orribile disaccordo» del «di fuori», che mette a soqquadro tanto le «armonie della ragione», quanto le «sale» del pensiero di Stato” (ivi, p. 81)

Il risultato di questo tritacarne concettuale ci consegna un Deleuze cospiratore, anarchico, nemico dello Stato, un feroce rivoluzionario avverso a un Mondo in cui la felicità e la proliferazione (pseudo)creativa sono divenute obbligatorie. Il Dark Deleuze è un Deleuze stereoscopico, che in parte riporta a galla le componenti più radicali e sconcertanti del deleuzismo (un canone inverso ma inattuale), e in parte si muove contro lo stesso Deleuze, accusandolo di essere stato a sua volta complice e istigatore delle sue letture “gioiose”.
Come scrive Culp, questo è difatti «un libro che Deleuze […] non avrebbe mai potuto scrivere» (ivi, p. 87), perché incapace di prevedere il fondo reazionario e paranoide del suo affermazionismo esuberante. «Correggere l’errore di Deleuze» vuol dire allora «coltivare un odio per questo mondo», far confluire la renaissance del Dark nell’abbattimento della realtà e del principio di produttività come suo «meccanismo centrale di liberazione» (ivi, pp. 42 e 40). Questo reale tutto ossa, senza Dio (non teologico), senza Uomo (non antropocentrico) e senza Mondo (non mondificato) coincide con l’avvento stesso del comunismo, l’unico pensiero politico in grado di veicolare l’intrinseca distruttibilità del Mondo, di rompere il guscio realista del capitalismo e di spezzare la maledizione del presente. Non sorprende che l’idea culpiana di comunismo si separi drasticamente dal modo in cui la tradizione contemporanea è abituata a pensare un simile concetto: quello Dark non è un comunismo a priori, presuntamente naturale, ma un comunismo barbaro, spinto contro la tolleranza, la compassione e ogni altro principio falsamente emancipativo propinato dal liberalismo. Un comunismo del complotto in cui la propensione alla negatività e l’inclinazione alla lotta asimmetrica non si condensano mai in un pensiero, ma ritornano compulsivamente nella «provocazione a pensare» l’avvento e l’eredità del cataclisma a venire (ivi, p. 84).
In copertina un’immagine in negativo di Gilles Deleuze. All’interno del testo “Forest in Negative” di Marcos Domingo Sanchez
