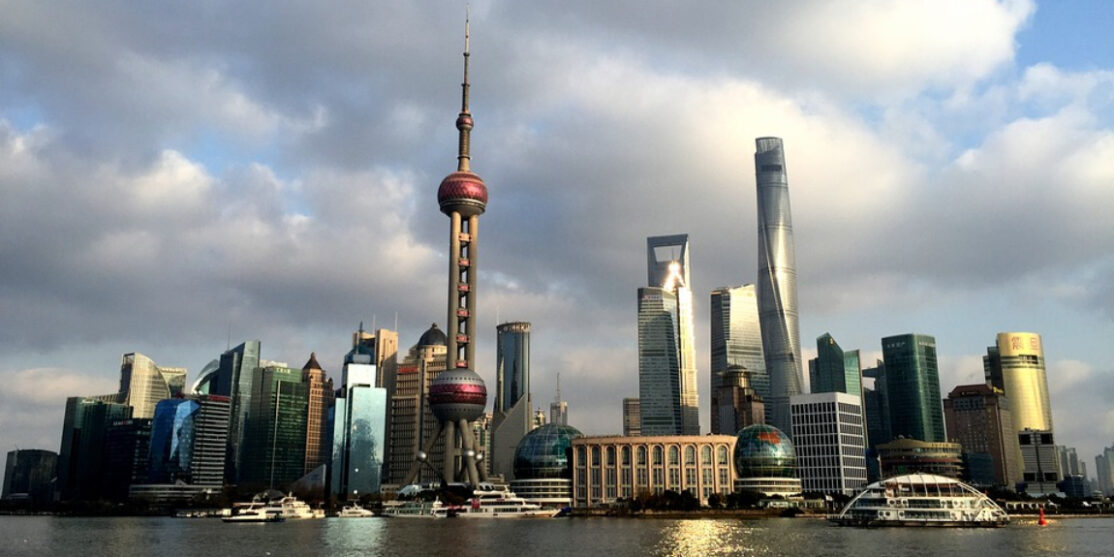COMMONS
CommonHelp, nelle pieghe della sharing economy

Un progetto di lavoro comune e mutualismo per sfidare le contraddizioni della sharing economy. È una sfida contro il cinismo, l’individualismo e le difficoltà che ci ha imposto l’epoca in cui ci è dato vivere. Abbiamo bisogno di rabbia, di intelligenze in comune… e di un po’ di fortuna!
Vi presentiamo CommonHelp, un sito di servizi, un luogo virtuale di incontro tra competenze, esigenze, affinità, un hub del lavoro autonomo. CommonHelp nasce dopo migliaia dicurriculum inviati, dentro la crisi e come reazione ad essa, dentro la favola della sharing economy e della rete come nuovo spazio della vita e del lavoro. È una sfida che vede protagonisti due concetti che a nostro avviso segnano la differenza nell’epoca in cui viviamo: il (lavoro) comune e il mutualismo, la solidarietà. Siamo precari, giovani e meno giovani, partite Iva per forza e non per scelta e crediamo che mettere in comune competenze, esperienze e relazioni possa produrre lavoro. Per lavoro, seguendo la definizione del Dizionario Sabatini Coletti, si intende: “Occupazione specifica che prevede una retribuzione ed è fonte di sostentamento”. Siamo contro il lavoro gratuito, anche quando fa curriculum. Il lavoro gratuito “fa” sfruttamento. Vogliamo costruirci un reddito a partire da un codice etico che rispetta e viene incontro alle esigenze di chi condivide il nostro stile, il più possibile solidale.
Allo stesso tempo CommonHelp è una CommonUnity, uno spazio in rete dove far rimbalzare informazioni, diritti, passioni, competenze informali, opportunità. Uno strumento la cui pretesa è quella di costruire relazioni, convinti di non essere autosufficienti e del fatto che per sopravvivere alla crisi sia necessario riconoscersi e coalizzarsi.
È fondamentale per noi indagare il contesto in cui abbiamo mosso i nostri primi passi, consapevoli della complessità della fase economica e sociale in cui viviamo. Crediamo che, in tempi così bui, sia urgente alimentare il dibattito sulle nuove forme dell’economia contemporanea, azzardare ipotesi e procedere per tentativi. Iniziamo dalle parole con cui Lelio De Michelis su Micromega descrive il lavoro in rete oggi: “una mobilitazione di tutti al lavoro o alla ricerca di un lavoro o a sviluppare nuove tecnologie e nuove applicazioni, senza più distinzione tra tempo di vita e di lavoro, tra mercato e società, tra rete e società, tutti a produttività crescente ma ad alienazione anch’essa crescente – anche se abilmente nascosta dall’apparato sotto le parole della neo-lingua e del proprio storytelling”. Un’analisi apocalittica, ma reale, che se per alcuni versi può apparire datata (e ricalcare le critiche già mosse alla cosiddetta new economy), ci viene in aiuto per orientarci nella comprensione di un fenomeno in corso tanto diffuso quanto ambivalente ma che, a nostro avviso, apre spiragli. Spiragli che sono il risultato dei rapporti di forza in gioco nelle condizioni materiali di vita, di lavoro, di formazione, di socialità della nostra generazione nella quale nessuno regala nulla a nessuno e raramente si condivide.
Molto interessante, in particolare, la riflessione linguistica che De Michelis mette in campo: l’invenzione, la trasformazione, il rinnovamento della “narrazione comune” che diviene lingua universale, universalmente condivisa, necessariamente “in rete”, sui social, nei tweet, nei luoghi del lavoro, della vita, della politica e in primis dell’economia. Lo storytelling della rete è effettivamente ormai resistente ad ogni critica, ad ogni tentativo di verifica sulla base di dati reali, che un like o un retweet in meno può trasformare in relativi, è una narrazione degna delle più grandi ideologie novecentesche. E secondo l’autore “nel grande storytelling del tecno-capitalismo si è aggiunta la sharing economy, ovvero l’economia della condivisione, un’economia dove il sociale orienterebbe un nuovo modo di essere economia”. La sharing economy, nel suo piccolo, mentre tenta di ridefinire, o quantomeno di incidere sull’organizzazione del lavoro nella crisi, è, infatti, entrata a pieno titolo nell’Oxford English Dictionary. Paul Mason, sostenitore dell’avvento del “post-capitalismo” la definisce su The Guardian “l’anticamera del comunismo digitale”. Più correttamente gli risponde l’economista Robert Reich da Berkeley, la culla dell’innovazione globale, che trattasi piuttosto di “economia di condivisione delle briciole”.
Nei rivoli della supposta universalità del concetto di sharing economy, che, è bene ricordarlo, sottintende sempre e comunque (ed è qui l’inganno) una peer economy, ovvero uno scambio tra pari, rientra un complesso eterogeneo di pratiche organizzative, di produzione e di scambio fondate su una comunità di soggetti, i cosiddetti “pari”. Non è questa la sede di un’analisi dettagliata di ciascun modello e certamente ogni esperienza gode di quel margine di indefinitezza e di ambivalenza offerto dalla “rete”, ma a grandi linee potremmo individuare: coloro i quali rispondono a logiche di mercato, ma allo stesso tempo di reciprocità, e sono orientati al profitto e che più in generale sarebbe più corretto includere in una rental economy; poi, altri che riescono a tenere assieme effettiva condivisione (di beni, di tempo, di servizi, di competenze) e ritorno economico; e altri ancora che agiscono secondo una reciprocità nella quale l’utile è solo eventuale.
Ad un primo sguardo sembra vi sia un’insistenza ricorrente nel mettere insieme (per confondere le acque?) modelli reali di condivisione con pratiche commerciali sicuramente innovatrici ma se possibile sempre più orientate alla libertà del mercato, alla concorrenza, alla messa in discussione delle garanzie sul lavoro e sulla sicurezza dei consumatori. La neolingua può anche chiamarli “consum-attori”, rispetto al loro grado di attivazione per tramite tecnologico, ma la questione non cambia. Uno dei libri più importanti sul tema evoca l’utopia della condivisione pura, What is mine is yours (Roger e Botsman, 2010). Ad esso risponde cinicamente, Tom Slee in What is yours is mine dove mette chiaramente in risalto la trasformazione della condivisione in una sorta di rete di relazioni di marketing e orienta il dibattito verso una possibile lettura foucaultiana della sharing economy, quale tecnica governamentale finalizzata all’organizzazione della vita nella sua totalità.
Il dato concreto che sostanzia l’esigenza di una riflessione è che una quantità sempre maggiore di valore d’uso è creato “in condivisione” al di fuori delle imprese e del sistema finanziario, ma allo stesso tempo una quota consistente di questo viene trasformato in valore di scambio dalle piattaforme mainstream, che si appropriano dell’intero profitto: “con la sharing economy […] abbiamo una liberalizzazione di fatto, circonvenendo le regole esistenti” (Melloni 2015) Airbnb e Uber sono accomunati non tanto dal carattere bonario e di “messa in comune” quanto dalla capacità di estendere l’offerta e rendere fortemente competitivi i propri prezzi, nel primo caso trattasi dell’affitto di un posto letto, nel secondo di un servizio taxi. Se entrambi può essere che facilitino la cooperazione, è da essa che estraggono valore senza redistribuirlo se non in minima parte, a vantaggio della “forza lavoro”. Ed infine, dato non secondario, l’utile individuale, in entrambi i casi è garantito dal possesso di un bene e dalla sua rendita.
Quella minima parte, dentro la crisi, può assumere però un significato non secondario e diventare, appunto, uno spiraglio. Scrive Tiziano Bonini: “…gli esclusi dalle forme di sicurezza sociale hanno iniziato ad arrangiarsi sfruttando economicamente gli appigli offerti dalla sharing economy. Come la nascente classe operaia del mondo industriale ottocentesco ha creato le sue forme di mutuo soccorso (poi incorporate dallo stato sotto forma di welfare state), oggi i freelance e i precari della nuova economia digitale si auto-organizzano in nuove forme di cooperazione e di mutualismo per affrontare la durezza della vita da imprenditore di se stesso.”
Ci è dunque più facile, per tornare a CommonHelp, presentarci da questa prospettiva, che seppur non vittimista ma passionale, non riesce con la sola adozione di una nuova lingua universale a ribaltare le condizioni materiali del vivere contemporaneo in un batter di click.
Lo scontro con le difficoltà generate dalla crisi ha sconfessato – definitivamente – per quel che riguarda la nostra generazione nata nei ‘70/’80, il mito dell’autosufficienza. Si è reso necessario costruire reti e relazioni mutualistiche, praticare forme di collaborazione inedite, mettere a valore l’informalità delle competenze acquisite negli anni dedicati alla formazione ufficiale e all’acquisizione di titoli e riempirci la bocca di “condivisione”, dopo aver già tentato con “partecipazione” all’inizio del millennio. Diventare lavoratori autonomi per noi non è stata una scelta, o meglio, è stata una scelta obbligata ed è all’interno di essa che proviamo a giocare una differenza. Abbiamo provato a cogliere nella pluralità esibita dalla sharing economy un’opportunità, “… un terreno fertile per la creazione di forme di prossimità e mutualismo che spesso colmano il vuoto di appartenenza e di rappresentanza degli ultimi anni”.
CommonHelp vuole dunque sperimentare uno stile differente di condivisione. Uno stile in nulla eccezionale, se l’epoca non avesse normalizzato la barbarie in ogni tipo di relazione (e dunque anche in quelle lavorative). Ci prefiggiamo di costruire una rete di collaboratori in grado di gestire incarichi differenti con qualità e professionalità, a partire da una mappa di competenze formali e informali che si compone giorno dopo giorno. Vogliamo riuscire a lavorare (secondo il significato illustrato all’inizio), a condividere responsabilità e risorse in modo il più possibile equo.
È una sfida contro il cinismo, l’individualismo e le difficoltà che ci ha imposto l’epoca in cui ci è dato vivere. Abbiamo bisogno di rabbia, di intelligenze in comune… e di un po’ di fortuna!