editoriale
Le vie della Costituzione sono infinite?
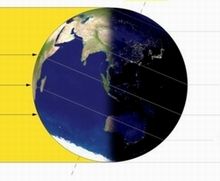
Note sull’ottobre italiano e sullo stato dei movimenti in Europa.
Il dibattito di movimento in queste ultime settimane si è concentrato sulla questione delle date di ottobre. Per evitare di dilungarci troppo sul punto, diciamo fin da subito che saremo parte attiva della settimana di mobilitazioni che si aprirà il 12 mattina, con la giornata di lotta per i beni comuni indetta dall’assemblea del Monte Amiata, che passerà per lo sciopero del 18 e arriverà fino al corteo e all’assedio del 19 ottobre. Ci auguriamo che l’intera settimana costituisca un momento importante di conflitto, in vista però – com’è logico che sia – della riproduzione e dell’estensione sociale del conflitto stesso. Non ci servono toni roboanti per affermarlo, e auspichiamo che tutti si pongano lo stesso obiettivo.
L’autunno previsto
Ciò detto, riteniamo sia il caso di sviluppare un ragionamento più articolato sull’attuale stato del movimento e, soprattutto, sui suoi limiti. Le lotte contro la crisi esplose negli ultimi anni, dentro e fuori l’Europa, hanno avuto la grande capacità di dotarsi di una temporalità autonoma, nell’esercizio della decisione comune e nei modi dell’azione politica. Per questa ragione, in molti casi, esse non sono state previste. Addirittura queste lotte hanno avuto la capacità di sconvolgere il ciclo naturale delle stagioni, le primavere sono divenute degli eventi politici di rottura insurrezionale e di trasformazione costituente, prima ancora che una legge di natura.
In Italia, al momento attuale, la situazione ci appare diversa. L’autunno arriva proprio quando era previsto che arrivasse, e per di più si apre all’insegna di un’indizione già vista, un’adunata in difesa della Costituzione (o, per essere più precisi, in difesa della Costituzione del Lavoro). Volendo chiudere in modo sbrigativo la faccenda basterebbe osservare che ci troviamo di fronte alla riproposizione di uno stanco rituale, che porta con sé il senso della sconfitta.
Se però proviamo a situare la manifestazione del 12 ottobre nel contesto odierno, essa ci sembra non solo insufficiente, ma del tutto fuorviante. Qualche parola in più ci sentiamo perciò di spenderla.
Chiamare a raccolta ampi strati della società civile e dei movimenti per i beni comuni, in difesa dello stendardo della legalità costituzionale (che poi per molti che scenderanno in piazza sarà declinata come legalità tout court), significa porsi in netta discontinuità con il desiderio costituente e la tensione al rinnovamento dello spazio democratico che le lotte globali hanno espresso in questi anni. In altre parole, convocare una manifestazione su quelle basi equivale a non comprendere che la tematica democratica, nel contesto della riorganizzazione autoritaria della governance finanziaria, assume una portata fino in fondo rivoluzionaria e, come tale, non può costituire un’istanza difensiva.
Per democrazia intendiamo la ricerca di un nuovo spazio della decisione e dell’organizzazione comune della società, che non ha nulla a che vedere con la rappresentanza politica. È un grave errore ritenere che la crisi della rappresentanza sia un effetto secondario della riorganizzazione della governance finanziaria, sia solo l’esito di “trasformazioni dall’alto”, perché essa è stata messa in crisi innanzitutto dalle lotte e dai processi trasformativi della società degli ultimi decenni. Non è dunque ripristinando i dispositivi di rappresentanza (su scala nazionale e/o su scala europea, dal momento che una parte del dibattito della sinistra si concentra sul rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo), che si potrà arginare la governance finanziaria né tantomeno riaprire una reale processualità democratica.
Standby
Inoltre, il percorso della “Via maestra”, proprio perché si vuole inserire nel solco tracciato in questi anni dalle lotte sui beni comuni, rischia seriamente di comprimerne la loro portata. Queste esperienze – dal movimento per l’acqua bene comune alle lotte ambientali fino alle nuove occupazioni di teatri, cinema, fabbriche – hanno avuto la capacità di praticare un uso strumentale dei dispositivi e degli istituti del diritto vigente, con lo scopo di superare l’attuale regime proprietario e di reinventare completamente il diritto stesso. È questo – o almeno a noi pare così – l’aspetto più interessante del dibattito sviluppatosi all’interno della stessa Costituente dei beni comuni, forse non a caso messa in standby poco prima dell’annuncio della manifestazione del 12.
È innegabile che, all’interno di queste esperienze di lotta, è stato costante il richiamo al lessico giuridico, sul piano dei diritti come sul piano dei principi e delle norme costituzionali. Si pensi, tra tutte, a una tra le disposizioni più avanzate e meno attuate della Costituzione, l’art. 43, dove si afferma che possono essere affidate «a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia e a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». Una disposizione, quest’ultima, che in forma indubbiamente embrionale prefigura una terza strada, oltre la coppia pubblico-privato, alludendo a una prospettiva di gestione comune della produzione e dei servizi un tempo affidati al welfare state. Una disposizione che resta solo sulla carta se non viene travolta, resa finalmente viva da una prospettiva costituente di trasformazione radicale del regime giuridico attuale.
In definitiva: il fatto che queste lotte abbiano fatto richiamo al lessico giuridico e costituzionale non autorizza nessuno a pensare che esse si siano poste l’obiettivo di riaffermare, come se fosse una legge divina e immutabile, la supremazia assoluta della Costituzione.
La Costituzione dei partiti
Ma quali sono le argomentazioni politiche che hanno spinto a convocare una piazza come quella del 12? Entriamo più nel merito.
Si dice, in primo luogo, che in questo preciso momento storico, la difesa della Costituzione è l’unica arma che i “cittadini” hanno a disposizione per frenare l’incedere impetuoso della governance finanziaria, la riorganizzazione del potere politico attraverso la forma del commissariamento, specie nei paesi dell’Europa del Sud (anche la presunta “crisi di governo” italiana degli ultimi giorni va letta in questo senso e la forma della dittatura commissaria, inaugurata dal governo Monti, ben si adegua anche al modello delle “larghe intese”, nella variante Letta-bis). In questo senso la Costituzione sarebbe l’unico argine al potere, per come esso si sta riconfigurando su scala europea e globale. L’unico scudo contro l’erosione della sovranità nazionale. Per rafforzare ancor di più questo discorso, si dice anche che la difesa della Costituzione sia oggi più che mai necessaria a fronte del documento della JP Morgan diffuso quest’estate, nel quale le classi politiche europee vengono invitate a sbarazzarsi definitivamente delle proprie costituzioni nazionali. Le cose a nostro avviso non sono così semplici.
Cominciamo con il negare due premesse – indispensabili al discorso di chi convoca il 12 ottobre secondo quelle parole d’ordine e col fine esclusivo di raggiungere l’applicabilità pura e semplice della Costituzione –: la prima è una lettura economicista della crisi, che continua a concepire economia e politica come due sfere separate nella teoria, là dove nella realtà esse sono congiunte, intrecciate, fuse. La seconda è una lettura della crisi come parentesi infelice che prima o poi si chiuderà con una risoluzione positiva di stabilità e accrescimento. La crisi è la forma costitutiva dell’economia politica oggi. E così, la governance finanziaria è la forma politica che il comando capitalistico assume. Non c’è alcuna politica “soggiogata” che andrebbe riportata in auge. Se questo è vero – e tutto sembra confermarcelo – allora pensare che il ripristino dei presupposti politici del compromesso costituzionale del ’48 sia la soluzione ci sembra un tantino fuori dalla realtà.
Tentiamo due esempi. Anche se si riuscisse ad abrogare il pareggio di bilancio dalla Costituzione – rivendicazione più che legittima, intendiamoci – essa, come potrebbe essere d’aiuto in tema di controllo dei dispositivi della finanza? In nessun modo, perché la Costituzione si limita a un generico richiamo alla sovranità monetaria. Ogni Costituzione ha una storia e la nostra, quando è stata scritta, rispondeva a un contesto nel quale differente era il ruolo delle Banche centrali, differente la misura del rapporto capitale-lavoro (si potevano ancora intravedere le tiepide spinte riformiste nel rinvio alla funzione sociale della proprietà, art. 42).
Il secondo riguarda la grave situazione di squilibrio dei poteri che si è affermata in Italia negli ultimi anni. Qui i difensori della Costituzione ci direbbero che occorre salvarla per contrastare il presidenzialismo de facto messo in atto da Napolitano e impedire le ipotesi di revisione costituzionale in senso presidenziale, con tanto di deroga all’art. 138, quindi occorre difendere la Costituzione.
Anche in questo caso, però, ci chiediamo: occorre difendere, per riaffermare che cosa?
La Costituzione italiana, la costituzione di Dossetti e Togliatti, è la costituzione dello Stato dei Partiti. Da qui non si sfugge. È una costituzione fondata su una forma di governo parlamentare, nella quale i partiti, attraverso il rapporto di rappresentanza, governavano la società. Oggi i partiti – ma è oramai banale dirlo – non rappresentano più nulla, non esercitano alcuna funzione di mediazione, essendo imprigionati nel ciclo polibiano della corruzione politica. A chi quindi si chiede l’applicazione rigorosa della Costituzione? Ai partiti stessi, alla magistratura, o a Napolitano, che ha imposto governi commissari e presidenzialismo de facto?
Oltre la rappresentazione, per un processo costituente euromediterraneo
Lo squilibrio dei poteri può essere modificato solo avviando su scala euromediterranea un processo costituente. Crediamo che non ci siano altre soluzioni e scorciatoie. Il problema è se si vuole lasciare lo spazio dell’iniziativa costituente al “sovversivismo dall’alto delle classi dirigenti” oppure assumerlo come progettualità politica e sfida per la trasformazione.
Avviare un processo costituente su scala euromediterranea non equivale a scrivere una nuova costituzione. Le costituzioni sono sempre l’espressione di una determinata composizione sociale, registrano e tentano di fissare dei rapporti di forza. Le costituzioni sono un fatto politico, prima ancora che giuridico-normativo. Oggi è sotto l’evidenza di tutti che i rapporti di forza in Europa sono a noi sfavorevoli. Ciò nonostante lo spazio euromediterraneo è stato attraversato da movimenti di importanza straordinaria, che pur non avendo vinto (nelle condizioni attuali, andrebbe anche rimesso a tema cosa significa vincere…), hanno scavato a fondo sul livello della produzione delle soggettività e della sperimentazione di nuove pratiche di decisione e di organizzazione politica.
Da questo punto di vista non possiamo non constatare come il movimento italiano, a tutti i suoi livelli, in tutte le sue componenti, abbia sottovalutato enormemente la portata rivoluzionaria della questione democratica, così come è emersa, ad esempio, nello sviluppo del movimento 15M in Spagna (è indicativo che in Spagna in questo periodo si stia discutendo proprio del superamento della Costituzione del ’78).
La sottovalutazione di tale questione porta alcuni a pensare che l’affermazione della democrazia coincida con la difesa della Costituzione; spinge altri a ritenere che la traduzione delle lotte accadute altrove possa darsi attraverso la semplice importazione delle pratiche di conflitto e dell’immaginario che le varie piazze tumultuose ci consegnano. L’immaginario e l’immaginazione, però, non hanno nulla a che vedere con la rappresentazione, sono un processo di produzione reale, incarnato nelle contraddizioni che la realtà propone.
È il momento di farla finita con la rappresentazione, in tutte le sue forme, ed avviare una riflessione seria sulla costituzione di nuovi dispositivi della decisione comune che siano delle macchine e non più dei teatri: ciò che i compagni spagnoli chiamano con il nome di tecnopolitica dovrebbe interrogarci a fondo.
Da questo punto di vista ci sembra del tutto riduttivo piegare i limiti del movimento italiano solo sul lato della presenza o assenza del conflitto. Il conflitto ci sarà, sta all’intelligenza collettiva saperlo agire nella maniera più efficace. Ciò che è gravemente assente dalla discussione non è tanto la tensione al conflitto, quanto la necessità di ricreare le condizioni per l’apertura di spazi comuni di movimento, spazi che naturalmente non devono essere cartelli, alleanze o conglomerati di soggetti precostituiti. Spazi che si pongano il problema di ricreare le condizioni di possibilità stesse per la trasformazione sociale. Spazi esemplificati proprio dalle piazze in rivolta, che non sono riconducibili ai soggetti politici organizzati, né appropriabili da alcuna componente particolare.
La sensazione è che anche nel dibattito che prepara la giornata del 19 Ottobre questi elementi siano stati trascurati, col rischio di non innescare quei processi di allargamento sociale ai quali pure si allude.
Questa scommessa non può più essere risolta negli angusti confini degli Stati nazione. Persino lo spazio politico italiano, che vanta una nobile tradizione di lotte, risulta troppo stretto di fronte alle sfide che ci pone il presente. La questione della costituzione di uno spazio comune di movimento va ricercata immediatamente sul piano europeo. In tal senso il prossimo appuntamento di Agora99 a Roma sarà occasione preziosa per cominciare a discutere di tutto ciò, e auspichiamo che altri percorsi, dello stesso tenore, si possano aprire.
